53830298.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Civiltàdellatavola
CIVI LT ÀDELL ATAVOLA ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA IN T ER E N D AT IT IO IO N N A L ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA A CULTURAL INSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ITALY 3 FOUNDED IN 1953 BY ORIO VERGANI 1 0 2 Y A M www.accademia1953.it , 9 4 2 . N TABLE OF CONTENTS L’ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA FOUNDED IN 1953 BY ORIO VERGANI AND LUIGI BERTETT , D INO BUZZATI TRAVERSO , CESARE CHIODI , G IANNINO CITTERIO , ERNESTO DONÀ DALLE ROSE , M ICHELE GUIDO FRANCI , GIANNI MAZZOCCHI BASTONI , A RNOLDO MONDADORI , ATTILIO NAVA , A RTURO ORVIETO , S EVERINO PAGANI , ALDO PASSANTE , G IAN LUIGI PONTI , G IÒ PONTI , DINO VILLANI , E DOARDO VISCONTI DI MODRONE , WHIT MASSIMO ALBERINI AND VINCENZO BUONASSISI . DEAR ACADEMICIANS… CIVI LT ÀDELL ATAVOLA 6 The Birth of Middle Class ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA 3 Italian Restaurants Abroad Cuisine INTERNATIONAL EDITION (Nicola Rivani Farolfi ) MAY 2013 / N. 249 in a Time of Globalizazion EDITOR IN CHIEF (Giovanni Ballarini) GIOVANNI BALLARINI ASSISTANT EDITOR AND ART DIRECTOR 8 Restaurant Acoustics FRANCESCO RICCIARDI FOCUS (Maurizio Campiverdi ) COPY EDITOR SILVIA DE LORENZO 4 The Perennial Topicality EDITORIAL SECRETARY of the Italian Academy TILDE MATTIELLO FRANCO MARENGHI of Cuisine STUDY CENTER LAYOUT (Paolo Petroni) MARIA TERESA PASQUALI TRANSLATORS 9 Is Family Cuisine NICOLA LEA FURLAN DONALD J. C LARK CULTURE AND RESEARCH Still Alive and Well? THIS ISSUE INCLUDES ARTICLES BY (Silvia De Lorenzo ) Giovanni Ballarini, Maurizio Campiverdi, Silvia De Lorenzo, Paolo Petroni, 5 Piadinas and Piadinerias Gianbruno Polllini, Nicola Rivani Farolfi. (Gianbruno Pollini ) OOO PUBLISHER ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA VIA NAPO TORRIANI 31 - 20124 M ILANO TEL . -

Shaping Sense Italian Post-War Functionalistic Design
Kjetil Fallan SHAPING SENSE ITALIAN POST-WAR FUNCTIONALISTIC DESIGN Thesis in fulfilment of the degree of cand. philol. (MA) Department of History / Centre for Technology and Society Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Trondheim 2001 To my parents “We have never discussed it, but I think the main reason why we are reluctant to get married is all those dreadful presents you get and can not dispose of just like that. Every christmas, we get a little foretaste of that hell. Cathrine’s parents have gotten wind of our “interest in design”, so that is why the garish wrapping paper nor- mally contains something even more garish; rubbish from Alessi.” -Torgrim Eggen in Pynt Preface This project has been fatiguing in addition to being extremely interesting. I would never have finished it without the help and support from many persons: I wish to thank my supervisor Per Østby for taking on such a unorthodox project. His enthusiasm has been very important to me, and his experience crucial to my work. Øst- by and my co-supervisor Stig Kvaal have guided a sometimes frustrated candidate through the non-determined, multidirectional flux of writing history. Centre for Technology and Society has been my haunt the last two years. I am very thankful for the good working environment the centre has provided me with. I have shared office, problems and laughter with Jon N. Eikrem and Finn Arne Jørgensen. Jørgensen also deserves many thanks for his proofreading and formatting. I also wish to thank the staff at the Biblioteca Nazionale Braidense and the Settore Bib- lioteca, Documentazione, Archivio of the Triennale di Milano for being so helpful and service-minded. -

RAPPORTO Il Mercato E L’Industria Del Cinema in Italia 2008
RAPPORTO Il Mercato e l’Industria del Cinema in Italia 2008 fondazione ente dello spettacolo RAPPORTO Il Mercato e l’Industria del Cinema in Italia 2008 In collaborazione con CINECITTA’ LUCE S.p.A. Con il sostegno di Editing e grafica: PRC srl - Roma fondazione ente Realizzazione a cura di: Area Studi Ente dello Spettacolo Consulenza: Redento Mori dello spettacolo Presentazione el panorama della pubblicistica italiana sul cinema, è mancata fino ad oggi una sintesi che consentisse una visione organica del settore e tale da misurare il peso di una realtà produttiva che per qualità e quantità rappresenta una delle voci più significative Ndell’intera economia. Il Rapporto 2008 su “Il Mercato e l’Industria del Cinema in Italia” ha lo scopo primario di colmare questa lacuna e di offrire agli operatori e agli analisti un quadro più ampio possibile di un universo che attraversa la cultura e la società del nostro Paese. Il Rapporto è stato realizzato con questo spirito dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in collaborazione con Cinecittà Luce S.p.A., ed è il frutto della ricerca condotta da un’équipe di studiosi sulla base di una pluralità di fonti e di dati statistici rigorosi. Questo rigore si è misurato in alcuni casi con la relativa indeterminatezza di informazioni provocata dall’assenza di dati attualizzati (ad esempio, per i bilanci societari) e dalla fluidità di notizie in merito a soggetti che operano nel settore secondo una logica a volte occasionale e temporanea. La Fondazione Ente dello Spettacolo opera dal 1946. Finora si è conosciuto molto del cinema italiano soprattutto in termini di È una realtà articolata e multimediale, impegnata nella diffusione, promozione consumo. -
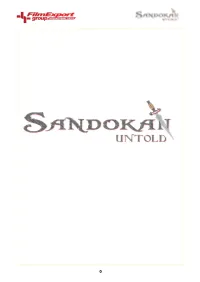
Line Producer
0 INDEX Pag. 2 - DIRECTOR’S NOTE Pag. 4 - SINOPSYS Pag. 5 - TECNICAL DATA Pag. 6 - PRODUCTION PROFILE Pag. 7 - DIRECTOR Pag. 11 - SCREENWRITER Pag. 12 - CAST WISH LIST Pag. 15 - LOCATIONS Pag. 18 - SKETCHES GOLETTA AND PRAHO 1 DIRECTOR’S NOTE Many years have passed since the last Theatrical or Television production narrating the achievements of the most fascinating and exotic hero born from the imagination of a novelist and this is where our story starts, from the casual meeting between the young Emilio Salgari in a tavern at the port of Trieste and a mysterious sailor who will tell him a story, a story rich of adventure and courage, of battles and love : the story of the Tiger of Mompracem. The old sailor is Yanez De Gomera, a Portuguese pirate and Sandokan’s companion in many adventures. The idea to narrate Salgari’s character at the beginning and at the end of the story, will also give a hypothetical reading of a mystery that has always intrigued thousands of readers worldwide: how Emilio Salgari was able to describe so well and with such abundance of exciting details, lands and countries that in reality he had never seen, having never been able to travel if not with his imagination. Another innovation in comparison to the previous versions of Sandokan will be the story of the genesis of the character, the creation of its myth by the English themselves, that he will fight against for his whole life. In fact we will narrate Sandokan as a child, son of a Malayan Rajah who fights against the control of his country by the English and for this reason he is killed together with all his family by some hired assassins Dayakis paid by James Brooke the white rajah of Sarawak, a man without scruples at the service of the Crown. -

Fertile Land for Art
fertile land for art ike all places with a rich historical heritage, Bassa L Romagna is bursting with art, and we are not only referring to ancient buildings, sculptures and paintings. In the past as well as in the present Bassa Romagna has been the cradle and the adopted country of numerous painters, writers, musicians, opera singers, composers and poets, whose work has been influential on a national level, but also on an international one. It's no wonder then that this tradition is still on. Bassa Romagna has a wide and varied artistic community of creative people who prefer to live in this area, instead {19} of large cities that could give them more visibility, because here they find a powerful source of inspiration and a sense of respect for their sensibility. This corner of Romagna has nourished the creativity of several writers, musicians, actors and directors. This somehow "enchanted" land can also claim to have hosted in its mist the poet George Gordon Byron (in the picture), hero and symbol of Romanticism. · FERTILE LAND FOR ART · reading bassa romagna: landscapes of literature landscape of Bassa Romagna has can be found in the parsonage of the church of The been the inspiration for outstanding San Francesco, in Bagnacavallo, and the local poets such as Dante and Byron. This is also Museo Civico delle Cappuccine has dedicated the birthplace of remarkable protagonists of a part of its collection to the illustrious writer. past and present literature. Several writers Vincenzo Monti (Passetto, 1754 - Milan, 1828) from other regions and countries have found was born in a tiny village near Alfonsine inspiration here for their essays about Romagna and is one of the most important figures of and for the evocative settings of their novels. -

Titolo Anno Paese
compensi "copia privata" per l'anno 2018 (*) Per i film esteri usciti in Italia l’anno corrisponde all’anno di importazione titolo anno paese #SCRIVIMI ANCORA (LOVE, ROSIE) 2014 GERMANIA '71 2015 GRAN BRETAGNA (S) EX LIST ((S) LISTA PRECEDENTE) (WHAT'S YOUR NUMBER?) 2011 USA 002 OPERAZIONE LUNA 1965 ITALIA/SPAGNA 007 - IL MONDO NON BASTA (THE WORLD IS NOT ENOUGH) 2000 GRAN BRETAGNA 007 BERSAGLIO MOBILE (A VIEW TO A KILL) 1985 GRAN BRETAGNA 007 DOMANI NON MUORE MAI (IL) (TOMORROW NEVER DIES) 1997 GRAN BRETAGNA 007 SOLO PER I TUOI OCCHI (FOR YOUR EYES ONLY) 1981 GRAN BRETAGNA 007 VENDETTA PRIVATA (LICENCE TO KILL) 1989 USA 007 ZONA PERICOLO (THE LIVING DAYLIGHTS) 1987 GRAN BRETAGNA 10 CLOVERFIELD LANE 2016 USA 10 REGOLE PER FARE INNAMORARE 2012 ITALIA 10 YEARS - (DI JAMIE LINDEN) 2011 USA 10.000 A.C. (10.000 B.C.) 2008 USA 10.000 DAYS - 10,000 DAYS (DI ERIC SMALL) 2014 USA 100 DEGREES BELOW ZERO - 100 GRADI SOTTO ZERO 2013 USA 100 METRI DAL PARADISO 2012 ITALIA 100 MILLION BC 2012 USA 100 STREETS (DI JIM O'HANLON) 2016 GRAN BRETAGNA 1000 DOLLARI SUL NERO 1966 ITALIA/GERMANIA OCC. 11 DONNE A PARIGI (SOUS LES JUPES DES FILLES) 2015 FRANCIA 11 SETTEMBRE: SENZA SCAMPO - 9/11 (DI MARTIN GUIGUI) 2017 CANADA 11.6 - THE FRENCH JOB (DI PHILIPPE GODEAU) 2013 FRANCIA 110 E FRODE (STEALING HARVARD) 2003 USA 12 ANNI SCHIAVO (12 YEARS A SLAVE) 2014 USA 12 ROUND (12 ROUNDS) 2009 USA 12 ROUND: LOCKDOWN - (DI STEPHEN REYNOLDS) 2015 USA 120 BATTITI AL MINUTO (120 BETTEMENTS PAR MINUTE) 2017 FRANCIA 127 ORE (127 HOURS) 2011 USA 13 2012 USA 13 HOURS (13 HOURS: -

Amedeo Nazzari and National Melodramatic Masculinity
Maria Elena D’Amelio ‘The ideal man’. Amedeo Nazzari and national melodramatic masculinity In 1939 the film magazine Cinema organized a survey among its read- ers, to establish who was the most popular actor in Italy. Amedeo Nazzari came in first with 19,020 votes, widely surpassing the other candidates, such as Fosco Giachetti and Vittorio De Sica1. Nazzari, born in Sardinia in 1907, had just achieved enormous success with two films directed by Goffredo Alessandrini, Cavalleria (1936) and Luciano Serra pilota (1938). With the latter Nazzari had also won the Coppa Mussolini at the Venice Film Festival in 1938. Due to the popularity of these films in Fascist Italy, with their themes of masculine heroism and war sacrifice, the result of the 1939 survey wasn’t that surprising. More surprising was a 1982 poll organized by the TV show Flash which asked its spectators to choose a individual from the past who would represent their ‘ideal man’. The result was again Amedeo Nazzari, who surpassed international stars such as Tyrone Power, media icons such John F. Kennedy, and popular histor- ical heroes like Garibaldi. In 1982, three years after his death, Nazzari still embodied a summa of the highest values of Italian masculinity in the collective imaginary. The longevity of Nazzari’s stardom in Italian cinema serves as a site to explore the link between stardom, gender, politics and industry during the transition from the Fascist era to the postwar period, focusing on the cultural signification of his star persona and his work in one of the most popular genres of postwar Italy, the melodrama. -

Uw Cinematheque Announces Fall 2012 Screening Calendar
CINEMATHEQUE PRESS RELEASE -- FOR IMMEDIATE RELEASE AUGUST 16, 2012 UW CINEMATHEQUE ANNOUNCES FALL 2012 SCREENING CALENDAR PACKED LINEUP INCLUDES ANTI-WESTERNS, ITALIAN CLASSICS, PRESTON STURGES SCREENPLAYS, FILMS DIRECTED BY ALEXSEI GUERMAN, KENJI MISUMI, & CHARLES CHAPLIN AND MORE Hot on the heels of our enormously popular summer offerings, the UW Cinematheque is back with the most jam-packed season of screenings ever offered for the fall. Director and cinephile Peter Bogdanovich (who almost made an early version of Lonesome Dove during the era of the revisionist Western) writes that “There are no ‘old’ movies—only movies you have already seen and ones you haven't.” With all that in mind, our Fall 2012 selections presented at 4070 Vilas Hall, the Chazen Museum of Art, and the Marquee Theater at Union South offer a moveable feast of outstanding international movies from the silent era to the present, some you may have seen and some you probably haven’t. Retrospective series include five classic “Anti-Westerns” from the late 1960s and early 70s; the complete features of Russian master Aleksei Guerman; action epics and contemplative dramas from Japanese filmmaker Kenji Misumi; a breathtaking survey of Italian Masterworks from the neorealist era to the early 1970s; Depression Era comedies and dramas with scripts by the renowned Preston Sturges; and three silent comedy classics directed by and starring Charles Chaplin. Other Special Presentations include a screening of Yasujiro Ozu’s Dragnet Girl with live piano accompaniment and an in-person visit from veteran film and television director Tim Hunter, who will present one of his favorite films, Tsui Hark’s Shanghai Blues and a screening of his own acclaimed youth film, River’s Edge. -

Riccardo Freda’S I Vampiri (1957) and the Birth of Italian Horror
Northumbria Research Link Citation: Guarneri, Michael (2017) The Gothic bet: Riccardo Freda’s I vampiri (1957) and the birth of Italian horror cinema from an industrial perspective. Palgrave Communications, 3 (1). p. 29. ISSN 2055-1045 Published by: Palgrave Macmillan URL: https://doi.org/10.1057/s41599-017-0030-3 <https://doi.org/10.1057/s41599-017- 0030-3> This version was downloaded from Northumbria Research Link: http://nrl.northumbria.ac.uk/id/eprint/32602/ Northumbria University has developed Northumbria Research Link (NRL) to enable users to access the University’s research output. Copyright © and moral rights for items on NRL are retained by the individual author(s) and/or other copyright owners. Single copies of full items can be reproduced, displayed or performed, and given to third parties in any format or medium for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge, provided the authors, title and full bibliographic details are given, as well as a hyperlink and/or URL to the original metadata page. The content must not be changed in any way. Full items must not be sold commercially in any format or medium without formal permission of the copyright holder. The full policy is available online: http://nrl.northumbria.ac.uk/policies.html This document may differ from the final, published version of the research and has been made available online in accordance with publisher policies. To read and/or cite from the published version of the research, please visit the publisher’s website (a subscription may be required.) ARTICLE DOI: 10.1057/s41599-017-0030-3 OPEN The Gothic bet: Riccardo Freda’s I vampiri (1957) and the birth of Italian horror cinema from an industrial perspective Michael Guarneri1 ABSTRACT Scholars tend to agree on Riccardo Freda’s I vampiri (1957) being the first Italian horror film. -

Giovanna Ralli
VIALE PARIOLI, 72 – 00197 ROMA TEL. 0636002430 – FAX 0636002438 [email protected] www.carolleviandcompany.it GIOVANNA RALLI TEATRO 1997-1998 “È stata una festa bellissima 1977 “Fra un anno alla stessa ora” , regia di Garinei e Giovannini 1962 “Una giornata particolare” regia di E. Scola 1957 “Un paio d'ali” regia di Garinei e Giovannini CINEMA 2021 “Marcel!”, regia di Jasmine Trinca 2013 "Un ragazzo d'oro", regia di P.Avati "Mister Love", regia di B. Pontellini 2012 "Immaturi - Il viaggio", regia di P. Genovese 2011 "Immaturi", regia di P. Genovese 2008 “Il sangue dei vinti” regia di M.Soavi 2003 “Il pranzo della domenica regia di C.Vanzina 1995 "Tutti gli anni una volta l'anno” regia di G.Lazotti 1991 “Verso sera” regia di F.Archibugi 1981 “Manolesta” regia di P. F.Campanile 1980 “Arrivano i bersaglieri” regia di L.Magni 1977 “Pane, burro e marmellata” regia di G..Capitani 1976 “Languidi baci... perfide carezze” regia di A.Angeli "Chi dice donna dice donna”, regia di T.Cervi 1975 "40 gradi all'ombra del lenzuolo” regia di S.Martino “Colpita da improvviso benessere” regia di F.Giraldi “Di che segno sei?”regia di S,Corbucci 1974 “Per amare Ofelia” regia di di F. Mogherini "C'eravamo tanto amati” regia di E. Scola “La polizia chiede aiuto” regia di M. Dallamano 1971 “Gli occhi freddi della paura”regia di E.G. Castellari 1970 “Una prostituta al servizio del pubblico e in regola con le leggi dello stato” regia di di I.Zingarelli “4 per Cordob” regia di P.Wendkos 1969 “La donna invisibile”, regia di P.Spinola “Il mercenario” regia di di S.Corbucci 1966 "Papà, ma che cosa hai fatto in guerra?” regia di B. -

Italiani Brava Gente
Cineforum della formica Stagione 2010-2011 ITALIANI BRAVA GENTE Commedia e impegno nel grande cinema italiano www.cineformica.org Cineforum della formica Stagione 2010-2011 IITTAALLIIAANNII BBRRAAVVAA GGEENNTTEE Commedia e impegno nel grande cinema italiano I soliti ignoti Regia Mario Monicelli Interpreti Vittorio Gassman (Peppe ), Marcello Mastroianni (Tiberio ), Renato Salvatori (Mario ), Totò (Dante Cruciani ), Carlo Pisacane (Capannelle ), Tiberio Murgia (Ferribotte ), Memmo Carotenuto ( Cosimo ), Carla Gravina (Nicoletta ), Claudia Cardinale (Carmelina ) Sceneggiatura Mario Monicelli, Suso Cecchi D'Amico, Age & Scarpelli Fotografia Gianni Di Venanzo Montaggio Adriana Novelli Italia, 1958, b/n, 111 min E' una doppia svolta: per la commedia che il cinema italiano coltiva in maniera pedissequa e spesso volgare, per Monicelli che mette a fuoco l'orizzonte dei suoi interessi. Una struttura efficiente e snella, grazie all'ottima sceneggiatura, una distribuzione di ruoli che rappresentò una vera sorpresa (Gassman per la prima volta in un personaggio comico, Mastroianni e Salvatori perfettamente caratterizzati, la presenza di due straordinarie macchiette come Capannelle/Carlo Pisacane e Ferribotte/Tiberio Murgia, un assolo formidabile di Totò maestro scassinatore), la felice coincidenza di una situazione sociale nuova (il boom economico) con l'intuizione che a tempi nuovi appena iniziati occorrano strumenti espressivi inediti, slegati dal populismo neorealistico: tutto questo confluisce in un film leggero, scettico e in apparenza disimpegnato, che lascerà un segno sul destino della commedia all'italiana e che troverà imitatori in Italia e fuori. (Fernaldo Di Giammatteo, Dizionario dei capolavori del cinema , B. Mondadori, 2004) Frasi famose Capannelle: Dimmi un po' ragassolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno? Bambino: Qui de Mario ce ne so' cento. -

121Comunicato Stampa Millenovecento64
COMUNICATO STAMPA Il Museo Nazionale del Cinema ospita al Cinema Massimo Millenovecento64. Il cinema italiano del 1964 5-9 dicembre 2011 Cinema Massimo - via Verdi, 18, Torino Giunge alla sua ventiquattresima edizione Millenovecento64. Il cinema italiano del 1964, il consueto appuntamento, curato dall’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e presentato nella Sala Tre del Cinema Massimo , dedicato al cinema italiano anno per anno. La rassegna propone, dal 5 al 9 dicembre 2011 , otto film tra i più importanti e esemplificativi del panorama cinematografico del 1964. Ingresso 5.50/4.00/3.00 euro. Millenovecento64. Il cinema italiano del 1964 , a cura di Paola Olivetti , Baldo Vallero , Corrado Borsa , Emanuela Maranci , è un progetto dell' Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, realizzato in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale di Roma , il Museo Nazionale del Cinema di Torino , Associazione Museo Nazionale del Cinema e con il contributo della Direzione Generale Cinema Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Piemonte . L’inaugurazione della retrospettiva avrà luogo lunedì 5 dicembre 2011 , alle ore 16.30 , presso la Sala Tre del Cinema Massimo , con la proiezione del film Gli indifferenti di Francesco Maselli , nella copia proveniente dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale . In replica alle ore 20.30 . Ingresso 5.50/4.00/3.00 euro. Francesco Maselli Gli indifferenti (Italia/Francia 1964, 90’, b/n) Il film rilegge per lo schermo il primo romanzo di Moravia, offrendo una rappresentazione densa e articolata del clima culturale e morale dell'Italia del fascismo. Maselli evoca nel suo ricco e duttile bianco e nero tutta l'incapacità borghese di travalicare gli argini, quelli costituiti dalla demolizione fascista dei valori storici e sociali, ma anche quelli, più sfumati ed esistenziali, indotti dalla precarietà di ogni cosa nel tempo, sentimenti, bellezza e poteri connessi.