Guida Alla Mostra
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lettera Da San G Iorgio
CONTACTS PROGRAMMES (MARCH – AUGUST 2016) PATRONS FRIENDS OF SAN GIORGIO Fondazione Virginio Bruni Tedeschi Giorgio Lettera da San Marco Brunelli Pentagram Stiftung Rolex Institute Year XVIII, number 34. Six-monthly publication. March – August 2016 Giannatonio Guardi, Neptune, detail, private collection Spedizione in A.P. Art. 2 Comma 20/c Legge 662/96 DCB VE. Tassa pagata / Taxe perçue CONTACTS PROGRAMMES (MARCH – AUGUST 2016) PATRONS FRIENDS OF SAN GIORGIO Fondazione Virginio Bruni Tedeschi Giorgio Lettera da San Marco Brunelli Pentagram Stiftung Rolex Institute Year XVIII, number 34. Six-monthly publication. March – August 2016 Giannatonio Guardi, Neptune, detail, private collection Spedizione in A.P. Art. 2 Comma 20/c Legge 662/96 DCB VE. Tassa pagata / Taxe perçue 16 FEB VENICE, ISLAND OF SAN GIORGIO MAGGIORE 23 APR, 21 MAY, 25 JUN VENICE, ISLAND OF SAN GIORGIO MAGGIORE LETTERA DA SAN GIORGIO CONTACTS International Conference Paolo Venini and His Furnace Concert Series e Complete Beethoven String Quartets PUBLISHED BY SECRETARY’S OFFICE ISTITUTO DI STORIA DELL’ARTE INTERNATIONAL ADVISORY BOARD 1 MAR – 31 DIC VENICE, ISLAND OF SAN GIORGIO MAGGIORE 25 – 30 APR VENICE, ISLAND OF SAN GIORGIO MAGGIORE Fondazione Giorgio Cini onlus tel. +39 041 2710229 – fax +39 041 5223563 Luca Massimo Barbero, director Maurice Aymard e Replica Project International Workshop and Symposium Accademia Monteverdi Isola di San Giorgio Maggiore, 1 [email protected] Secretary’s oce: tel. +39 041 2710230 – +39 041 2710239 Brenno Boccadoro 30124 Venezia fax +39 041 5205842 Steven Feld PRESS OFFICE 3-10-17 MAR VENICE, ISLAND OF SAN GIORGIO MAGGIORE 2 – 4 MAY VENICE, ISLAND OF SAN GIORGIO MAGGIORE tel. -

Refractory Migrants. Fascist Surveillance on Italians in Australia 1922-1943
Refractory Migrants. Fascist Surveillance on Italians in Australia 1922-1943 by Gianfranco Cresciani Gianfranco Cresciani emigrated University of New South Wales in from Trieste to Sydney in 1962. He 2005, in recognition of worked for EPT, the Ethnic Affairs “distinguished eminence in the field Commission and the Ministry for of history”. In 2004 the Italian the Arts of the NSW Government Government awarded him the on cultural and migration issues. In honour of Cavaliere Ufficiale 1989 and 1994 he was member of dell‟Ordine al Merito for facilitating the Australian Delegation re- cultural exchanges between Italy negotiating with the Italian and Australia. He has produced Government the Italo-Australian books, articles, exhibitions and Cultural Agreement. Master of Arts radio and television programs in (First Class Honours) from Sydney Australia and Italy on the history of University in 1978. Doctor of Italian migration to Australia. Letters, honoris causa, from the There are exiles that gnaw and others that are like consuming fire. There is a heartache for the murdered country… - Pablo Neruda We can never forget what happened to our country and we must always remind those responsible that we know who they are. - Elizabeth Rivera One of the more salient and frightening aspects of European dictatorships during the Twentieth Century, in their effort to achieve totalitarian control of 8 their societies, was the grassroots surveillance carried out by their state security organisations, of the plots and machinations of their opponents. Nobody described better this process of capillary penetration in the minds and conditioning of the lives of people living under Communist or Fascist regimes than George Orwell in his book Nineteen Eighty-Four (1), published in 1949 and warning us on the danger of Newspeak, Doublethink, Big Brother and the Thought Police. -

A British Reflection: the Relationship Between Dante's Comedy and The
A British Reflection: the Relationship between Dante’s Comedy and the Italian Fascist Movement and Regime during the 1920s and 1930s with references to the Risorgimento. Keon Esky A thesis submitted in fulfilment of requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Arts and Social Sciences. University of Sydney 2016 KEON ESKY Fig. 1 Raffaello Sanzio, ‘La Disputa’ (detail) 1510-11, Fresco - Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatican. KEON ESKY ii I dedicate this thesis to my late father who would have wanted me to embark on such a journey, and to my partner who with patience and love has never stopped believing that I could do it. KEON ESKY iii ACKNOWLEDGEMENTS This thesis owes a debt of gratitude to many people in many different countries, and indeed continents. They have all contributed in various measures to the completion of this endeavour. However, this study is deeply indebted first and foremost to my supervisor Dr. Francesco Borghesi. Without his assistance throughout these many years, this thesis would not have been possible. For his support, patience, motivation, and vast knowledge I shall be forever thankful. He truly was my Virgil. Besides my supervisor, I would like to thank the whole Department of Italian Studies at the University of Sydney, who have patiently worked with me and assisted me when I needed it. My sincere thanks go to Dr. Rubino and the rest of the committees that in the years have formed the panel for the Annual Reviews for their insightful comments and encouragement, but equally for their firm questioning, which helped me widening the scope of my research and accept other perspectives. -

Alceste De Ambris Dall'interventismo All'esilio
Alceste De Ambris dall’interventismo all’esilio (1914-1934) Enrico Serventi Longhi La figura di Alceste De Ambris è stata studiata ed è conosciuta da diversi ricercatori, studiosi o appassionati di storia. La sua vicenda biografica lo vede protagonista della politica rivoluzionaria e non solo dei primi trentenni del novecento; nato a Licciana di Pontremoli (Massa) il 15 settembre 1874, il suo nome è legato a due episodi celebri: lo sciopero generale dei contadini a Parma nel maggio 1908 e la collaborazione con Gabriele D’Annunzio a Fiume – Rijeka nel 1920. Esperienze profondamente diverse per fini, caratteri ideologici e sviluppi organizzativi, testimoni di una indiscutibile trasformazione, comune del resto alla generazione degli interventisti di sinistra. La guerra fu un momento di rottura fra la tradizione riformistica, parlamentare, persino evangelica, del socialismo italiano ufficiale e parte della nuova generazione di giovani rivoluzionari. In tale ottica ho ritenuto opportuno segnare come inizio simbolico dell’indagine analitica il discorso interventista di De Ambris pronunciato nell’agosto 1914; la guerra rappresenta senza dubbio il determinante momento di rottura del sindacalista di Licciana con il movimento operaio e libertario, sebbene insieme preceduto dall’avvicinamento alle posizioni antigermaniche del sindacalismo rivoluzionario francese e dalla fondamentale esperienza politica ed esistenziale nel Ticino1. La tesi di dottorato nasce con lo specifico intento di mettere in luce la travagliata esperienza del sindacalista aprano e, allo stesso tempo non sottovalutando lo studio prosopografico dei gruppi con cui entra in contatto e collabora. Il taglio biografico può permettere di entrare in profondità nel dibattito, nelle fratture, nelle riorganizzazioni, nelle affermazioni e nelle sconfitte delle diverse scuole della sinistra rivoluzionaria italiana sorte dalla campagna antimilitarista e dall’interventismo rivoluzionario e democratico. -

The Centennial of the Conflagration at the Slovenian Cultural Centre in Trieste
Fire in the Roof, Truth in the Air: The Centennial of the Conflagration at the Slovenian Cultural Centre in Trieste 22. 3. 2021 Številka: 15/2021 Avtor: Ivan Smiljanić Drawing: Zoran Smiljanić July 2020 marked the hundredth anniversary of the fire at the Slovenian Cultural Centre in Trieste also known as the National Hall (Narodni dom). The event, because of its dramatic quality and consequences, is well-known in Slovenia, and has (once again) become the subject of heated debate. In the month of July, it was possible to read many things about the Trieste National Hall in the Slovenian media, and the writers all agreed about the most important elements of the incident including its cause and the order in which events unfolded on July 13, 1920. The problem is that we read very many different interpretations of the same incident in accounts from beyond our western border. The actual fire begins to be lost between new (and newer) interpretations and reinterpretations, and the abundance of contradictory information. Not only the event itself, but also its meaning in the wider historical context, becomes indistinct. This is counterproductive. Of course, it is good to have many sources available when considering the fire, sources from which we can compose a complete picture. But when these sources arise from specific (and differing) motives, they are useful for the analysis of discourses but considerably less so in the search for historical truth. But let's take a step back. It has become questionable whether the concept of historical truth really exists. Historians in the nineteenth century idealistically believed that it was possible to extract a refined truth from the careful study of historical sources. -

Una Misión Fascista En América Latina: La Travesía De La R
Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. División de Historia. Una misión fascista en América Latina: la travesía de la R. Nave Italia, 1922-1924. Tesis que para obtener el grado de Maestro en Historia Internacional presenta Walter Raúl de Jesús Martínez Hernández. Asesor: Dr. Marco Zuccato. 2014. 1 Índice. Agradecimientos. 3 Introducción. 5 Capítulo I. Punto de partida. 14 Capítulo II. Una nave llamada Italia. 27 Capítulo III. La travesía Latinoamericana. 63 Capítulo IV. México: un estudio de caso. 87 Epílogo. 129 Consideraciones finales. 146 Anexo I. 154 Anexo II. 163 Fuentes. 177 2 Agradecimientos. Dedico este trabajo a mi familia, que me apoyó y reconfortó en los momentos más complicados. Agradezco infinitamente el cariño y el apoyo moral que me ha brindado la mujer con la que he compartido los últimos seis años de mi vida, Daniela Calderón Canseco. Expreso también mi agradecimiento al Ingeniero Roberto Hernández López, sin cuyo respaldo no hubiera podido concretar este y otros proyectos de vida. Mi gratitud inmensa para el profesor Stefano Tedeschi de la Università La Sapienza di Roma, quien tuvo la gentileza de aceptar y asesorar mi estancia de investigación en Italia. Doy gracias, igualmente, al Dr. Paolo Evangelisti por haberme dado orientación y asesoría personalizada durante mi labor en el Archivio Storico della Camera dei Deputati en Roma. Quiero agradecer al Dr. Marco Zuccato, mi asesor de tesis, por el compromiso que asumió con mi trabajo y todos los consejos francos y útiles que me ha dado. No olvidaré tampoco las críticas, opiniones y recomendaciones tan valiosas de la Dra. -

Redalyc.MASONERÍA Y FASCISMO EN ITALIA: UNA RELACIÓN AMBIGUA (1922-1943)
Diálogos - Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História ISSN: 1415-9945 [email protected] Universidade Estadual de Maringá Brasil Savarino, Franco MASONERÍA Y FASCISMO EN ITALIA: UNA RELACIÓN AMBIGUA (1922-1943) Diálogos - Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, vol. 13, núm. 1, 2009, pp. 167-184 Universidade Estadual de Maringá Maringá, Brasil Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305526877009 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Diálogos, DHI/PPH/UEM, v. 13, n. 1 p. 167-184, 2009. MASONERÍA Y FASCISMO EN ITALIA: UNA RELACIÓN AMBIGUA (1922-1943) * Franco Savarino** Resumen. La formación de un régimen autoritario en Italia en 1922 (desde 1925 dictadura totalitaria), causó un enfrentamiento con la masonería. Inicialmente varias logias apoyaron la llegada al poder de Mussolini, y entre los fascistas había muchos masones. Sin embargo, existía una fuerte corriente antimasónica heredada del nacionalismo, que compartía personalmente el Jefe de los «camisas negras» y varios líderes importantes del nuevo régimen. La masonería fue primero prohibida en las filas del Partido y luego (1925) proscrita. Aquí me propongo indagar sobre los motivos que llevaron a este enfrentamiento y el significado de la oposición masonería-fascismo, frente al programa fascista de alianza con fuerzas liberales, acercamiento a la Iglesia católica y formación de una nueva «religión política» incompatible con la tradición masónica. -
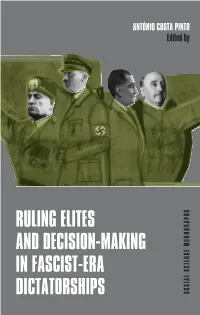
Ruling Elites.Indb
António Costa Pinto is a professor Dictators do not rule alone, and a governing elite stratum is always ANTÓNIO COSTA PINTO After the so-called ‘third wave’ of de- of politics and contemporary Euro- formed below them. This book explores an underdeveloped area in the study ANTÓNIO COSTA PINTO mocratisation at the end of the 20th pean history at the Institute of Social of fascism: the structure of power. The old and rich tradition of elite studies Edited by century had significantly increased the Sciences, University of Lisbon. He has can tell us much about the structure and operation of political power in the number of democracies in the world, been a visiting professor at Stanford dictatorships associated with fascism, whether through the characterisation of the survival of many dictatorships has University (1993) Georgetown Uni- had an important impact. Taking as the modes of political elite recruitment, or by the type of leadership, and the versity (2004), a senior associate mem- starting point the dictatorships that ber at St Antony’s College, Oxford relative power of the political institutions in the new dictatorial system. emerged since the beginning of the University (1995) and a senior visiting Analyzing four dictatorships associated with fascism (Fascist Italy, Nazi 20th century, but mainly those that fellow at Princeton University (1996) Germany, Salazar’s Portugal and Franco’s Spain), the book investigates the were institutionalised after 1945, the and at the University of California, dictator-cabinet-single party triad from -

Consensus for Mussolini? Popular Opinion in the Province of Venice (1922-1943)
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM SCHOOL OF HISTORY AND CULTURES Department of History PhD in Modern History Consensus for Mussolini? Popular opinion in the Province of Venice (1922-1943) Supervisor: Prof. Sabine Lee Student: Marco Tiozzo Fasiolo ACADEMIC YEAR 2016-2017 2 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Declaration I certify that the thesis I have presented for examination for the PhD degree of the University of Birmingham is solely my own work other than where I have clearly indicated that it is the work of others (in which case the extent of any work carried out jointly by me and any other person is clearly identified in it). The copyright of this thesis rests with the author. Quotation from it is permitted, provided that full acknowledgement is made. This thesis may not be reproduced without my prior written consent. I warrant that this authorisation does not, to the best of my belief, infringe the rights of any third party. I declare that my thesis consists of my words. 3 Abstract The thesis focuses on the response of Venice province population to the rise of Fascism and to the regime’s attempts to fascistise Italian society. -

Waiting for War: Portugal, Spain, Italy and Greece, 1914-1918 FILIPE RIBEIRO DE MENESES *
Comunicação & Cultura, n.º 16, 2013, pp. 31-46 Waiting for war: Portugal, Spain, Italy and Greece, 1914-1918 FILIPE RIBEIRO DE MENESES * In his Modern Spain 1875-1980, Raymond Carr wrote that “in all countries of Southern and Eastern Europe the strains imposed by the Great War of 1914- 1918 proved too great for democratic and quasi-democratic regimes.”1 While undoubtedly true, these words should not be read to mean that the war was nec- essarily a catastrophe imposed by the Great Powers on these countries: Many within them saw the generalized European war – the result of the existing alliance system which turned an Austrian-Serbian dispute into something very different – as a unique historic opportunity to be seized in order to pursue concrete, often expansionist, goals. Interventionism, in other words, was a policy choice freely pursued. When the First World War began officially, on 28 July 1914, the countries of southern Europe were by no means unaccustomed to armed conflict. Whether in the colonial sphere (in the cases of Portugal, Spain, and Italy) or against one or more European powers (in the cases of Italy and Greece), all four of the coun- tries covered in this article had recently been engaged in sometimes defensive, but more often than not aggressive, military action – so much so that the chronologi- cal limits of the First World War are beginning, in the opinion of many historians – to fray at the edges, not because of actions undertaken by the Great Powers, but because of the activities undertaken by their southern neighbours.2 All four _______________ * Professor at the National University of Ireland, Maynooth. -

E' Universalmente Noto L'episodio Dell'assalto E Dell'incendio Del Narodni Dom a Trieste Avvenuto La Sera Del 13 Luglio
La Redazione de “La Nuova Alabarda” presenta il dossier n. 36 Anonimo Triestino AL BALKAN CON FURORE Ardua la vera verità sul Tenente Luigi Casciana Si può sciogliere un nodo stretto da novant’anni? Trieste, 2010 È noto l’episodio dell’assalto e dell’incendio del Narodni Dom a Trieste (la casa del popolo slovena, meglio conosciuta con il nome dell’hotel Balkan presente nello stesso edificio) avvenuto la sera del 13 luglio 1920 per opera dei fascisti capitanati da Francesco Giunta. L’autorevole storico Renzo De Felice lo definisce in assoluto “il vero battesimo dello squadrismo organizzato” (R. De Felice, “Mussolini il rivoluzionario. 1883-1920” Einaudi, 1965). Attorno alle ore 17, 30 si erano riuniti in piazza Unità d’Italia nazionalisti e fascisti per manifestare contro i cosiddetti jugoslavisti e gli slavi in genere ritenuti responsabili dell’uccisione, avvenuta due giorni prima a Spalato, del capitano Tommaso Gulli, comandante della nave militare Puglia e del motorista Aldo Rossi. La manifestazione a Trieste degenerò in innumerevoli atti di violenza e poi di devastazioni ai danni soprattutto della comunità slovena. Nella giornata, coinvolti nei disordini vi furono due morti, il diciassettenne apprendista cuoco del ristorante Bonavia, pugnalato in piazza Unità e un ospite dell’Hotel Balkan che si buttò da una finestra dell’edificio in fiamme. Vi furono altresì più di venti feriti. Tra questi un reduce nato a Caltanissetta ma residente a Trieste, superstite di due fratelli morti in guerra, il tenente Luigi Casciana del 142° reggimento di fanteria: ricoverato all’ospedale civile, ivi operato di laparotomia, la sera del 19 venne trasferito all’ospedale militare dove morì dopo poche ore. -

Sentinelle Perdute Gli Anarchici, La Mort
BFS_2009_01_Antonioli 10-02-2009 19:38 Pagina 1 34 | cultura storica BFS_2009_01_Antonioli 10-02-2009 19:38 Pagina 2 BFS_2009_01_Antonioli 10-02-2009 19:38 Pagina 3 MAURIZIO ANTONIOLI SENTINELLE PERDUTE Gli anarchici, la morte, la guerra BFS_2009_01_Antonioli 10-02-2009 19:38 Pagina 4 In copertina: elaborazione grafica da un disegno di Ugo Ortona (dal volume: F. NIETZSCHE, Considerazioni inattuali, Milano, Monanni, 1926) Progetto grafico e impaginazione: fuoriMargine (Vr) 2009 © BFS edizioni Biblioteca Franco Serantini Amministrazione e distribuzione: Libercoop via I. Bargagna, 60 – 56124 Pisa tel./fax 050 9711432 [email protected] www.bfs-edizioni.it ISBN 978-88-89413-34-0 BFS_2009_01_Antonioli 10-02-2009 19:38 Pagina 5 INDICE 7 PREMESSA 11 LA MORTE DEI TITANI E DEGLI EROI 23 LA COMPAGNIA DELLA MORTE. Gli anarchici garibaldini nella guerra greco-turca del 1897. Ritratto di gruppo 41 GLI ANARCHICI ITALIANI E LA RIVOLUZIONE RUSSA DEL 1905 53 D’ANNUNZIO E GLI ANARCHICI. A proposito di Corrado Brando 63 NAZIONALISMO SOVVERSIVO? 99 GLI ANARCHICI ITALIANI E LA PRIMA GUERRA MONDIALE. Lettere di Luigi Fabbri e di Cesare Agostinelli a Nella Giacomelli (1914-’15) 125 GLI ANARCHICI ITALIANI E LA PRIMA GUERRA MONDIALE. Lettere di anarchici interventisti (1914-’15) 163 GLI ANARCHICI ITALIANI E LA PRIMA GUERRA MONDIALE. Il diario di Luigi Fabbri (maggio-settembre 1915) 187 GUERRA, AMORE E AMICIZIA. Tre anarchiche di fronte alla Prima guerra mondiale 209 INDICE DEI NOMI BFS_2009_01_Antonioli 10-02-2009 19:38 Pagina 6 BFS_2009_01_Antonioli 10-02-2009 19:38 Pagina 7 PREMESSA Andrea Costa, nella sua famosa lettera Ai miei amici di Romagna, del luglio 1879, scriveva: La rivoluzione è una cosa seria.