Air Water Land Collection
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jaguart - the Italian Talent Road Show
Press release | Torino, 25 June 2021 JaguArt - The Italian Talent Road Show Starting in June, the Italian Talent Road Show resumes with an intense calendar of events. The winners will present their research in the hosting galleries of each city, establishing a dialogue in a group show on tour in Italy that will conclude at Artissima, after the announcement of the winner. Artissima – International Fair of Contemporary Art and Jaguar are back at centre stage with the restart of JaguArt - The Italian Talent Road Show, the voyage in pursuit of young talents that began in 2019 thanks to the dialogue between Artissima and Jaguar Land Rover, based on a shared desire to support emerging art and to trigger fertile long-term synergies of collaboration. 10 Italian cities, 10 Jaguar dealerships, 10 contemporary art galleries, 10 fine arts academies, 10 artists are the protagonists of this travel around Italy that continues to present new initiatives to support the selected emerging artists. JaguArt will culminate with the announcement of the absolute winner during the course of the 28th edition of Artissima (5-7 November 2021), the final stop of this voyage that began with the selection of 10 artists, one for each stop, and the activation of a programme of special encounters in the hosting galleries and Jaguar dealerships all over Italy. The 10 winners and finalists of JaguArt are: Matteo Pizzolante, winner of the first appointment in Milan, Luca Arboccò – Turin, Francesco Tagliavia – Catania, Camilla Gurgone – Rome, Boris Contarin – Venice, Stefano Giuri – Florence, Marco-Augusto Basso – Genoa, Teresa Gargiulo – Naples, Camilla Riscassi – Bologna, and Federica Francesconi – Brescia. -

WOPART – Works on Paper Art Fair
WOPART – Works on paper art fair Centro Esposizioni Lugano Via Campo Marzio 6900 Lugano, Switzerland Preview: September 19, 12:00 – 21:00 Stand A 10 Public days: September 20 – 22, 11:00 – 19:00 Robilant+Voena are pleased to present works by Hsiao Chin and Minjung Kim at WOPART 2019. Hsiao Chin was born in Shangai in 1935. He is a Chinese painter known for his lyrical abstractions, which employ both the vocabulary of traditional Chinese brush painting and the conceptual framework of European and American Modernism. After participating in the foundation of the group of abstract painters "Ton Fan" in 1956, in that same year he arrived in Europe, staying in Madrid and Barcelona, where he held his first solo show in 1957. At the end of the fifties he settled in Milan, where in 1961 he participated in the "Punto" movement, along with other eXponents of the neo-avant-garde international art such as Kengiro Azuma, Antonio Calderara, Dadamaino, Henk Peeters. In the 1960s Hsiao Chin spent long periods working in London, Paris, and New York. Today he lives and works in Taiwan as well as in Milan, where he settled in 1971, teaching at the European Institute of Design and then at the Academy of Fine Arts of Brera. Hsiao Chin has had a great influence on the development of abstract painting in China and his works can be found in the collections of The Museum of Modern Art in New York, the Shanghai Art Museum and the Philadelphia Museum of Art, to name but a few. -
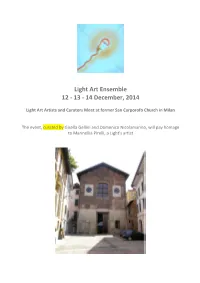
Light Art Ensemble 12 ‐ 13 ‐ 14 December, 2014
Light Art Ensemble 12 ‐ 13 ‐ 14 December, 2014 Light Art Artists and Curators Meet at former San Carporofo Church in Milan The event, curated by Gisella Gellini and Domenico Nicolamarino, will pay homage to Marinellia Pirelli, a Light's artist Light Art Ensemble 2014 Light Art as feature that interacts with architecture and urban landscape, for creating new visual atmospheres, for allowing new ways of enjoying either an outdoor or an indoor space of a city, for conveying cultural messages and contents. That's, in short, the concept of Light Art Ensemble, an occasion for confrontation and debate among Art and Culture experts with a group or artists that will embody that concept in their works. The latter will be set up from 12 to 14 of December in the evocative location of the former San Carpoforo church in Via Formentini, in the hearth of the Brera neighbour, within short distance from the Brera Fine Arts Academy and Pinacoteca (Art Gallery). The event will pay homage to Marinellia Pirelli, the great pioneer artist of Light Art who left us in 2009. For the event a number of her Meteore will be exhibited. San Carpoforo is a deconsecrated church of which the first information date back to the 831 year, albeit of the ancient building there is nothing left since it was rebuilt from scratch in the XVII century, after many refurbishments. Belonging to the Milan's Municipality, from 1993 is at free disposal of the Brera Academy for its courses, but it can also be rented as location for high level cultural or trade events. -

Artyard 62A Trenton Ave. Frenchtown, NJ 08825 Contact
FOR IMMEDIATE RELEASE ArtYard 62A Trenton Ave. Frenchtown, NJ 08825 [email protected] www.artyard.org Opening reception: Saturday, December 10, 2016. Time: 6:00pm- 8:30pm Final day: Sunday, March 5, 2017. BEDLAM AND BALANCE The inaugural group exhibition of ArtYard, featuring eight artists from four continents. Anila Rubiku, Carly Butler, Elsa Mora, Hoda Zarbaf, Hyang Cho, Magdalena Campos-Pons, Regina José Galindo and Vessna Perunovich. Curated by Magda Gonzales-Mora. Bedlam and Balance draws attention to the struggles of individuals to find their own balance, rebuild after the earth has shifted, or forge a new path through uncertain terrain. Eight female artists examine existential and autobiographical elements, drawing from disparate origins in Albania, Canada, Cuba, Iran, Korea, Guatemala and Serbia. In the wake of a surreal election and in an era when the diasporas of far flung continents are both accessible and remote, Bedlam and Balance offers visions of fear and displacement, refuge and restoration. The drawings, installations, objects, poems, sculptures and videos in this exhibition weave together personal and collective narratives that revisit the past, scavenge the present and suggest shrewd, hopeful and vulnerable approaches to the road ahead. ARTISTS Anila Rubiku is an Albanian-born Italian artist who studied at the Tirana Academy of Arts (1994) and did her postgraduate work in Milan at the Brera Academy (2000). At present she works between Milan, Tirana and Toronto. Rubiku’s work is intimately connected to social and political issues. She creates drawings and sophisticated installations that involve contemporary approaches to traditional crafts such as embroidery. Rubiku is drawn to examining and representing the accretion of emotionally complex layers that comprise our identities as social creatures. -

Curriculum Vitae Education Professional Experience
CURRICULUM VITAE Paolo Pedercini 51 3rd Street Troy NY 12180 518.961.3767 [email protected] EDUCATION 2007 - 2009 MFA, Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), Troy NY Integrated Electronic Arts Areas of Specialization: experimental game design, video, tactical media 2001 - 2004 BA, LABA - Libera Accademia di Belle Arti, Brescia Italy Visual arts and multimedia communications Areas of Specialization: Web/interaction design, net.art, new media PROFESSIONAL EXPERIENCE 2006 - Present Independent game designer. Developing serious and casual games for game portals, companies and associations. 2007 - 2008 Teaching assistant. Teaching basic tools from the Adobe suit ad RPI, Rensselaer Polytechnic Institute. 2005 - 2007 Teacher of new media communication. Teaching Flash 8, advanced level, oriented to data visualization project at NABA, New academy of fine arts. 2006 Multimedia community specialist. Designing social software for Sky Italia. 2005 - 2006 Creative director and web developer. Thinking up online and below the line alternative marketing campaigns, designing and developing online contents for guerrilla marketing. 2004 - 2005 Graphic and Web designer. Designing and developing websites and magazines for Studio Rodighiero Associati. Pre-2005 Cartoonist/illustrator, letterman, grocery store associate, steelworker, fast food crew, food worker, plastic worker. SELECTED WORKS 2008 Missed connections A forensics investigation of physical disconnection based on classified ads found on craigslist. Experimental Video 7' 2008 Oiligarchy A commentary on oil industry, lobbying and fossil fuel depletion. Online game 2008 Permitted Habitats Interactive map of genetically modified organisms released for field tests from 1987 to 2008. Collaboration with Center for PostNatural History. Data visualization 2008 The Free Culture Game Playable theory about the struggle between free culture and copyright. -
ICI Venice BHUTAN
Under the patronage of: ENG BHUTAN JOURNEY BEYOND THE SKY BHUTAN VIAGGIO OLTRE IL CIELO BHOUTAN VOYAGE AU CŒUR DU CIEL Exhibition of bhutanese ethnographic pieces MAGAZZINO DEL CAFFÈ – VENEZIA Free admission Support ICI Venice with a donation 1 ◉CURATORS ICI - Institut Culturel International Olivier Perpoint, Chi Phan, Mariarosaria Fogliaro, Martina Masini, Francesca Salvi, Hélène Touzé, Chantal Valdambrini. François Pannier Ethnographic Art Curator Anne Segarra Archives Anne et Ludovic Segarra. ◉ORGANIZATORS ICI - Institut Culturel International Venice - Italy Archive Anne et Ludovic Segarra Paris - France Avec la collaboration de: Le Toît du Monde - Ethnographic Art Gallery in Paris, France, by François Pannier. www.letoitdumonde.com Alain Rouveure Galleries - Tibetan rugs arts and crafts from the Himalayas. www.alainrouveure.com ◉UNDER THE PATRONAGE OF ◉WITH THE SUPPORT OF LAlliance Franaise de Venise Fornasetti Cole & son The Merchant of Venice Fondation Malongo 2 ◉ BHUTAN Journey beyond the sky After the Nepalese Shamanic Art Exhibition showed in Venice and Paris, ICI – International Cultural Institute, presents “BHUTAN Journey beyond the sky”. In December 2012, ICI has organized the first exhibition about Bhutan at “Le 5 Opéra - Compagnies du Monde” in Paris - France. Encouraged by the huge success of the exhibition "Shamanism", with over 16,000 visitors, ICI decided to show more the Himalayan region and produce a new exhibition about Bhutan. From December 2014 to March 2015 will be held "Bhutan: journey beyond the sky" at our venue in Venice, Magazzino del Caffè. ICI offers a journey through time because, of course, the kingdom of Bhutan with the years has changed considerably. To well understand the history and evolution of this Himalayan country a series of conferences will be organized in collaboration with the Department of Studies on Asia and Africa Mediterranean University Ca’ Foscari Venice, under the direction of teachers Stefano Beggiora and Fabian Sanders, in addition to participation of the Association "Amici del Bhutan". -

Piero Fornasetti One Hundred Years
Piero Fornasetti One Hundred Years on show from 9th May to 15th June 2014 Monday to Sunday 11.00 a.m. to 8.00 p.m. at 10 Corso Como Seoul 3F Piero Fornasetti Piero Fornasetti was a Milanese painter, sculptor, interior decorator, engraver of books and a creator of more than 13,000 products. In terms of variety of decoration, Fornasetti’s production of objects and furniture is one of the largest of the 20th century. Fornasetti is celebrated as being among the most original creative talents of the twentieth century. During his career he created a visual vocabulary that is instantly recognizable and unceasingly engaging. Fornasetti designed a magical world, saturated in image and colour and filled with whimsy and wit. Biography • 1913 Piero Fornasetti is born in Milan, Italy. • 1930 Piero entered Brera Academy to study drawing. • 1932 Expelled from Brera for insubordination. • 1933 First artwork shown as part of a student exhibition at Milano University. Also this year, a series of scarves in printed silk was proposed to the Milan Triennale but was rejected. It was during this occasion that Piero’s work was noted by Gio Ponti. • 1935 At the sixth Triennale in Milan, Piero exhibited, among other things, a decorative bronze and ceramic frieze in an archaic style. • 1940 Piero met Gio Ponti and went on to design ‘The Lunar’ illustrated Calendar book for him. • 1942 Created frescoes for the Palazzo Bo in Padova. • 1943-1946 Went into exile in Switzerland. • 1947 Exhibited a series of motifs for ceramics at the Triennale (commissioned again by Gio Ponti). -
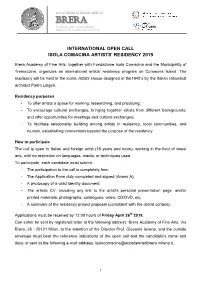
FAC SIMILE Per Ddocumenti Della Qualità
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA Via Brera, 28 - 20121 Milano www.accademiadibrera.milano.it INTERNATIONAL OPEN CALL ISOLA COMACINA ARTISTS’ RESIDENCY 2019 Brera Academy of Fine Arts, together with Fondazione Isola Comacina and the Municipality of Tremezzina, organizes an international artists’ residency program on Comacina Island. The residency will be held in the iconic Artists House designed in the1940’s by the Italian rationalist architect Pietro Lingeri. Residency purposes - To offer artists a space for working, researching, and practicing; - To encourage cultural exchanges, bringing together artists from different backgrounds, and offer opportunities for meetings and cultural exchanges; - To facilitate relationship building among artists in residency, local communities, and tourists, establishing connections beyond the purpose of the residency. How to participate The call is open to Italian and foreign artist (18 years and more), working in the field of visual arts, with no restriction on languages, media, or techniques used. To participate, each candidate must submit: - The participation to the call is completely free; - The Application Form duly completed and signed (Annex A); - A photocopy of a valid identity document; - The artistic CV, including any link to the artist's personal presentation page, and/or printed materials, photographs, catalogues, video, CD/DVD, etc; - A summary of the residency project proposal (consistent with the island context). Applications must be received by 12:00 hours of Friday April 26th 2019. Can either be sent by registered letter at the following address: Brera Academy of Fine Arts, Via Brera, 28 - 20121 Milan, to the attention of the Director Prof. Giovanni Iovane, and the outside envelope must bear the reference indications of the open call and the candidate's name and data; or sent at the following e-mail address: [email protected]. -
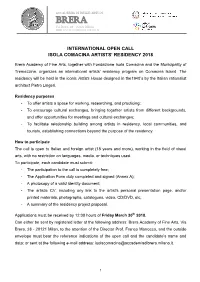
FAC SIMILE Per Ddocumenti Della Qualità
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA Via Brera, 28 - 20121 Milano www.accademiadibrera.milano.it INTERNATIONAL OPEN CALL ISOLA COMACINA ARTISTS’ RESIDENCY 2018 Brera Academy of Fine Arts, together with Fondazione Isola Comacina and the Municipality of Tremezzina, organizes an international artists’ residency program on Comacina Island. The residency will be held in the iconic Artists House designed in the1940’s by the Italian rationalist architect Pietro Lingeri. Residency purposes - To offer artists a space for working, researching, and practicing; - To encourage cultural exchanges, bringing together artists from different backgrounds, and offer opportunities for meetings and cultural exchanges; - To facilitate relationship building among artists in residency, local communities, and tourists, establishing connections beyond the purpose of the residency. How to participate The call is open to Italian and foreign artist (18 years and more), working in the field of visual arts, with no restriction on languages, media, or techniques used. To participate, each candidate must submit: - The participation to the call is completely free; - The Application Form duly completed and signed (Annex A); - A photocopy of a valid identity document; - The artistic CV, including any link to the artist's personal presentation page, and/or printed materials, photographs, catalogues, video, CD/DVD, etc; - A summary of the residency project proposal. Applications must be received by 12:00 hours of Friday March 30th 2018. Can either be sent by registered letter at the following address: Brera Academy of Fine Arts, Via Brera, 28 - 20121 Milan, to the attention of the Director Prof. Franco Marrocco, and the outside envelope must bear the reference indications of the open call and the candidate's name and data; or sent at the following e-mail address: [email protected]. -

When Mythology Jumps Into Economy: a Big Splash of Ecology
Melting Yuchen Wang b. 1990, Inner Mongolia, China Lives and works in Beijing, China Education 2011-2015 BFA, Florence Academy of Fine Art 2015-2017 MFA, Brera Academy of Fine Arts, Milan Solo Exhibitions 2019 run moo-r-oom run, @Art Festival, GeorgeV Art Center, Beijing, China Ejecta outta the corner, PLATEshowcase, Beijing, China Regimen Engineering, 3standardstoppage, New York, USA Selected Group Exhibitions 2020 When Mythology Jumps Into Economy: A Big Splash of Ecology!, PLATESPACE, postpost, Beijing, China Pet Shop Guys II: Wandering on Hennessy Road, Curated by Martin Goya Business, MINE PROJECT, Hong Kong, China How Do We Begin?, X Museum Triennial, X Museum, Beijing, China 2019 Barrier shop project, PLATEspace, Beijing, China The Internet Yami-Ichi in NY, NOWHERE, New York, USA abC Art Book Fair, G11 postpost space, Beijing Times Art Museum, Beijing China Public Art and Technology, China Art Foundation, Hangzhou, China CORPI LEGGERI, Sala Napoleonica, Accademia di belle arti di Brera, Milan, Italy Stroll- Eat, Imagokinetics Lab, HangZhou, China Social media jersey workshop, aotu space, Beijing, China 2018 GAZABOI, Milan photo week, FABBICA DEL VAPORE, Milan, Italy GAZABOI, CIVIC MUSEUM OF CREMA, Italy 2017 ACCADEMIA APERTA, ACADEMY OF FINE ART BRERA, Milan, Italy A CIELO APERTO, Studio Corsini, Milan, Italy HERE 2017 Residence, Cavallerizza Reale, Torino, Italy 2016 Luci dell’lrno Festival, Baronissi, Napoli, Italy In Peccioli Lux, Tuscany, Italy Biennale Gubbio, Umbria, Italy 2015 Painting and Opening Camp of the accademia belle arti di venezia, Forte Marghera, Venezia, Italy Biennale dei Castelli, Bergamo, Italy MINE PROJECT 11/F, The Hennessy, 256 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong ⾹港灣仔軒尼詩道256號11樓 mine-project.com Collections X Museum, Beijing, China Comune di Cassano d’adda, Italy Comune di Peccioli, Italy MINE PROJECT 11/F, The Hennessy, 256 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong ⾹港灣仔軒尼詩道256號11樓 mine-project.com . -

Aldo Spoldi 1968 – 1969
ALDO SPOLDI 1968 – 1969 It is with great pleasure that on Tuesday 16th October 2018, from 7.00 p.m. to 9.00 p.m. we are opening the new art season with the personal exhibition of the young artist Aldo Spoldi, student of Brera Academy. The paintings, on board only, belong to the 1968-69 period; they create iconic, ironic and conceptual images in constant movement. These artworks have never been exhibited before, Aldo kept them in the closets of his home and in his studio. Tempera, collage and pencil write the history of those years, the history of a young artist who outlines his own personal language along with that of the Banda del Marameo, led by Aldo himself and his friends of the Academy. This company used to go around the centre of Milan and Crema joking and taunting passers-by and authorities (with the typical Italian teasing gesture of marameo). This activity is documented by Mat Levi’s pictures, by a fine issued by a policeman in Crema and by numerous articles of the time. That is an ironic answer to the ‘68 youth protest, to the Pop Art and the Happening of those years. In addition to the celebration of the fiftieth anniversary of the ’68 revolutionary period, the exhibition will be held simultaneously with the great anthological exhibition dedicated to Aldo Splodi’s work La storia del mondo, at Fondazione Marconi in 15 Tadino street (fondzionemarconi.org) from 20th September to 10th November 2018. The exhibition has its roots in the great painting entitled Antologica representing the surreal and amazing tale of the whole artistic history of Aldo Spoldi from 1968 to these days. -

Luca De Leva (Milan, Italy, 1986) [email protected]
Luca De Leva (Milan, Italy, 1986) [email protected] www.lucadeleva.com Education Academy of fine Arts of Brera Academy of Visual Art, Leipzig - HGB Solo shows 2019 E' stato bello pensarti, ADA, Rome Hai paura dell'uomo nero? Curated by Daniela Zangrando At Museo Burel, Belluno 2018 TWO at VR projectroom, Manifesta collateral event, Palermo 2017 Ultime Volontà, ADA, Rome Cronache da un altro Occhio, performance at Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art, Rivoli 2016 Ricreazione, Studio Amaro, Naples Horses and Virgin Marys. Sentimentally inspired by Arnaldo Badodi, INPRATICA project in the Giuseppe Iannaccone Collection, Milan 2015 ThySelf Talk: Chronicles from another eye, performative conference, Museo Villa Croce, Genova Requiem, Basilica S.Marco, Milan, project with Artache 2014 Fiammetta dixit, Cura.basement, Rome Ceci n’è pas, Privat house, Wien, project with Artache 2013 Ho perso gli anelli, ma mi restano le dita, Room Galleria, Milan Blarney 5x3, Almanac Projects, London 2012 ThySelf, De Walvisch Culture Ship, London 2011 Thy Self Talk, Zicohouse, Beirut 2009 Ottut, Room Galleria, Milan Group shows 2019 Straperetana curated by Saverio Verini, Pereto 2018 C'est toi ou c'est moi ? Curated by Luca Gennati at Fondazione Pini, Milan Rosina #1, Limone, London 2017 Self-care while smoking, TILE + CLOG, CLOG, Turin Viva arte viva curated by Treti Galaxie, Future Dome, Milan Glimmerate, Marsèlleria New York, New York Collezione Agovino - Frammenti di Paradiso, Le Scalze, Naples 2016 Encounters program, performance at Central Saint