Un Sepolcro Monumentale Romano in Area Vestina: Analisi E Confronti
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Map 44 Latium-Campania Compiled by N
Map 44 Latium-Campania Compiled by N. Purcell, 1997 Introduction The landscape of central Italy has not been intrinsically stable. The steep slopes of the mountains have been deforested–several times in many cases–with consequent erosion; frane or avalanches remove large tracts of regolith, and doubly obliterate the archaeological record. In the valley-bottoms active streams have deposited and eroded successive layers of fill, sealing and destroying the evidence of settlement in many relatively favored niches. The more extensive lowlands have also seen substantial depositions of alluvial and colluvial material; the coasts have been exposed to erosion, aggradation and occasional tectonic deformation, or–spectacularly in the Bay of Naples– alternating collapse and re-elevation (“bradyseism”) at a staggeringly rapid pace. Earthquakes everywhere have accelerated the rate of change; vulcanicity in Campania has several times transformed substantial tracts of landscape beyond recognition–and reconstruction (thus no attempt is made here to re-create the contours of any of the sometimes very different forerunners of today’s Mt. Vesuvius). To this instability must be added the effect of intensive and continuous intervention by humanity. Episodes of depopulation in the Italian peninsula have arguably been neither prolonged nor pronounced within the timespan of the map and beyond. Even so, over the centuries the settlement pattern has been more than usually mutable, which has tended to obscure or damage the archaeological record. More archaeological evidence has emerged as modern urbanization spreads; but even more has been destroyed. What is available to the historical cartographer varies in quality from area to area in surprising ways. -
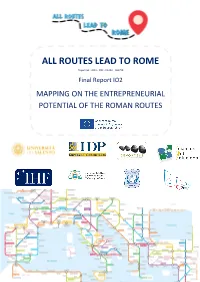
Download IO2 Final Report
ALL ROUTES LEAD TO ROME Project ref.: 2019 - IT02 - KA203 – 062798 Final Report IO2 MAPPING ON THE ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF THE ROMAN ROUTES a a a With the support of the Erasmus+ programme of the European Union. This document and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Content Content..................................................................................................................................... 2 1. Introduction ...................................................................................................................... 6 1.1. Grounding: Secondary Research ................................................................................ 6 1.2. Involvement: Primary Research ................................................................................. 7 2. The Sample ....................................................................................................................... 8 2.1. Descriptives ............................................................................................................... 8 2.2. The Roman Routes Questionnaire ............................................................................ 11 2.3. Results ..................................................................................................................... 12 2.4. Conclusions ............................................................................................................ -

Working Papers
TEMI ECONOMICI DELLA SARDEGNA CONTRIBUTI DI RICERCA CRENOS THE LONG-TERM EFFECTS OF THE HISTORICAL ROMAN ROAD NETWORK: TRADE COSTS OF ITALIAN PROVINCES FISCALITÀ LOCALE E TURISMO LA PERCEZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DELLA TUTELA AMBIENTALE A VILLASIMIUS Luca De Benedictis Vania Licio AnnaCarlo Maria Perelli Pinna Giovanni Sistu Andrea Zara QUADERNIWORKING DI PAPERS LAVORO 20112018/ 01/ 01 !"#!$ C ENTRO R ICERCHE E CONOMICHE N ORD S UD (CRENO S) U NIVERSITÀ DI C AGLIARI U NIVERSITÀ DI S ASSARI CRENOS was set up in 1993 with the purpose of organising the joint research effort of economists from the two Sardinian universities (Cagliari and Sassari) investigating dualism at the international and regional level. CRENoS’ primary aim is to improve knowledge on the economic gap between areas and to provide useful information for policy intervention. Particular attention is paid to the role of institutions, technological progress and diffusion of innovation in the process of convergence or divergence between economic areas. To carry out its research, CRENoS collaborates with research centres and universities at both national and international level. The centre is also active in the field of scientific dissemination, organizing conferences and workshops along with other activities such as seminars and summer schools. CRENoS creates and manages several databases of various socio- economic variables on Italy and Sardinia. At the local level, CRENoS promotes and participates to projects impacting on the most relevant issues in the Sardinian economy, such as tourism, environment, transports and macroeconomic forecasts. www.crenos.it [email protected] CRENO S – C AGLIARI V IA S AN G IORGIO 12, I - 09100 C AGLIARI, I TALIA TEL. -

Als PDF Herunterladen
Namen und Daten : Beobachtungen zur Geschichte des römischen Strassenbaus Autor(en): Radke, Gerhard Objekttyp: Article Zeitschrift: Museum Helveticum : schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft = Revue suisse pour l'étude de l'antiquité classique = Rivista svizzera di filologia classica Band (Jahr): 24 (1967) Heft 4 PDF erstellt am: 06.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-20429 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich -

The Long-Term Effects of the Historical Roman
The long-term effects of the historical Roman road network: trade costs of Italian provinces∗ Luca De Benedictis† Vania Licio‡ Anna Maria Pinna§ March 15, 2018 Abstract The paper provides evidence of the causal effect of infrastructure on trade costs, for the 107 Italian provinces (NUTS3), testing whether current differences in trade costs among provinces can be traced back to the structure of the historical Roman road network. By constructing a specific measure of the extent of the Roman road network for each Italian province and relying on an instrumental variables approach, the empirical analysis shows that having an integrated road system, as the one built during the Roman Empire, plays an important role in current international trade. The study confirms not only the importance of history for contemporary economic development, but also the significant role played by the historical infrastructure in shaping geography and in determining current trade patterns via the influence on today’s infrastructure. JEL Classification: F10, F14. Keywords: Trade costs; Roman roads; Long-term effects of history; Italy; Provinces. ∗The authors thank participants at the ICEG 2017 Conference in Naples, at the SETC 2017 Conference in Sardinia, at the 58th Annual Conference of the Italian Economic Association in Arcavacata, at the 18th World Congress of the International Economic Association in Mexico City, at the 7th International Conference ‘Economics of Global Interactions: New Perspectives on Trade, Factor Mobility and Development’ and at the VII Workshop on Institutions, Individual Behaviour and Economic Outcomes in Alghero for helpful comments and discussions, in particular Rinaldo Brau, Alessandro Bucciol, Emanuele Mazzini, Alireza Naghavi, Gianluca Orefice and Luigi Pascali for the insightful comments. -

The Roman Cultural Memory of the Conquest of Latium
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2016 The Roman Cultural Memory of the Conquest of Latium Elizabeth Grace Palazzolo University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the Classics Commons Recommended Citation Palazzolo, Elizabeth Grace, "The Roman Cultural Memory of the Conquest of Latium" (2016). Publicly Accessible Penn Dissertations. 1929. https://repository.upenn.edu/edissertations/1929 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/1929 For more information, please contact [email protected]. The Roman Cultural Memory of the Conquest of Latium Abstract In this dissertation, I examine the Roman cultural memory of the conquest of Latium and Rome’s earliest expansion through case studies of three Latin cities—Tusculum, Tibur, and Praeneste. Each of these cities underwent the transition from independent civic entity to community of Roman citizens on a different timeline than the majority of Latium: though most Latin cities came under Roman control after being defeated in the Roman-Latin Wars around 338 BCE, Tusculum had already been incorporated as the first municipium cum suffragio after 381 BCE, while Tibur and Praeneste seem to have remained independent allied cities until 90 BCE. I reconstruct the Roman cultural memory of these cities and how it changed over time, incorporating a variety of textual and material sources including literary references, inscriptions, iconography alluding to each city, and monuments or significant sites. I demonstrate that the memory of Tusculum, Tibur, and Praeneste as formerly independent, non-Roman communities persisted through the Late Republic and into the Empire, even as they became completely politically integrated with Rome. -

RODAN Sintesi Delle Strade Romane
RODAN Sintesi delle Strade Romane Questa sintesi, meglio descritta altrove, vuole essere uno sprone per molti Cultori di Storia Locale che, ciascuno per il suo paese o città, possa portare avanti questo tipo di indagini, per farle confluire in Questo Sito, punto di convegno degli appassionati archeologi, dove si potrà costituire un Forum di confronto, discussione e messa a punto dei dati, per completare sempre più, una mappa geografico-storica-archeologica dell‘Italia. Io sono troppo vecchio per continuare questo lavoro, perciò spero di suscitare interesse perché lo facciano altri. Si dice che —nisciuno è nato imparato“, non bisogna preoccuparsi del dire solo cose certe, perché di esse non ce ne saranno mai, servono dati ed idee da porre a confronto con altre persone ed altri dati, perché è questo che porterà al compimento di documentazioni di valore, come servono all‘ampliamento della Conoscenza. STRADE RADIALI DI ROMA NOME STRADA ASSE VIARIO COSTRUTTORE COSTRUZIONE UTILIZZO KM NOTE L‘antica Roma dei sette re, 753-609 a.C. ebbe brevi strade suburbane a disposizione radiale: Campana poi Portuense, RomaœPortus, Imp.Claudio I d.C, 28 km. sponda destra Tevere Macarrese poi inizio Aurelia fino a Fregene, 241 a.C., 25 km Boccea poi via Cornelia, 200 a.C., per Boccea, fiume Arrone, 20 km Veientana poi via Trionfale, Roma œ Veio etrusca VIII sec. a., poi romana 392 a.C., 20 km Braccianese poi Clodia 310 a.C. per Lago Bracciano (l‘antica a Tarquinia) Cimina poi Cassia 171 a.C. per Veio e monti Cimini, fu l‘antica Dorsale Etrusca Amerina poi sostituita da Flaminia 220 a.C., per Amelia 132 km Feronia poi Tiberina VIII sec.a.C. -

669 Galadini
Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata Vol. 51, n. 2-3, pp. 143-161; June-September 2010 Archaeoseismological evidence of a disruptive Late Antique earthquake at Alba Fucens (central Italy) F. G ALADINI1, E. CECCARONI2 and E. FALCUCCI1 1 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Milano, Italy 2 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, Chieti, Italy (Received: April 8, 2009; accepted: September 15, 2009) ABSTRACT Paleoseimological investigations in the 1990s identified a surface faulting event in the Fucino Plain (central Italy) related to the 5th-6th century AD. This event originated along the same seismogenic source responsible for the 1915 earthquake (Mw 7.0) that caused damage over a vast region, including Rome. This earthquake was associated to the one that was responsible for damage to the Colosseum in Rome, just before 484 AD or 508 AD. Considering that this event was energetic enough to create surface faulting, significant effects would be expected on the settlements of the 5th-6th century AD. In modern archaeological publications, the destruction of Alba Fucens in the north-western sector of the Fucino area has been related to the effects of a destructive earthquake that occurred during the Late Antiquity. Archaeological evidence on the effects of the earthquake is mostly made up of collapsed layers including columns, statues, coins and other materials and layers formed by burnt remains (mainly parts of the wooden structures of the buildings). However, this Late Antique earthquake has been attributed to the 4th century AD in archaeological literature. With this discrepancy in mind, we have carried out a study of the archaeological sources and have collected new archaeological data, in order to cast light on this chronological problem. -

Bonner Jahrbücher
Spätantike, frühes Mittelalter und Mittelalter 511 Arnold Esch, Zwischen Antike und Mittelalter.Der Verfall des römischen Straßensystems in Mittelita- lien und die Via Amerina. Publisher C. H. Beck, Munich . pages with illustrations, maps. In ,Arnold Esch published his book »Römische Straßen in ihrer Landschaft.Das Nachleben antiker Strassen (sic) um Rom. Mit Hinweisen zur Begehung im Gelände«(Mainz ). Here, Esch enumerates five sections of Roman roads in CentralItaly: the Via Appia, the Via Cassia, theVia Flaminia, the Via Sala- ria and the Via Valeria. These descriptions follow the same concept: awalking route follows the trace of the former road, based on detailed survey-maps; in add- ition, ameticulous description is given of the ancient history and archaeologyofthe road section and the surrounding landscape. The publication is richly illus- trated: besides thesurvey-maps, there are also photos of the landscape and the road sections themselves and sometimes also illustrations of objects situated along the roads in present or in original times. »Zwischen Antike und Mittelalter« takes adifferent form. It is actually divided into two independentparts, although the title only suggests one. The first part is a general historical overview concerning the decline and fall of the entire Roman road system in Central Italy; the 512 Besprechungen second part is awalking tour along the Via Amerina, andolive oil – up untilthe fifthcentury corn wasimport- described in the same way as the Roman road sections in ed from Africa –,but some centuries later, Rome was »Römische Straßen«. Although the two parts are con- transformed into avillage of peasants, living amongst nected, the differences between them are striking. -

C HAPTER FOUR Dissertation II on the Waters and Aqueducts Of
Aqueduct Hunting in the Seventeenth Century: Raffaele Fabretti's De aquis et aquaeductibus veteris Romae Harry B. Evans http://www.press.umich.edu/titleDetailDesc.do?id=17141, The University of Michigan Press C HAPTER FOUR Dissertation II on the Waters and Aqueducts of Ancient Rome o the most eminent and reverend Gaspare Cardinal Carpegna, vicar of T the city, his most gentle master, Raffaello Fabretti, son of Gaspare, of Urbino, sends greetings. 1. introduction Whoever has said that it is not at all necessary to give an account of one’s leisure must have thought, when he said these things, of a man living for himself alone and focused on his own affairs. Far different, indeed, is the case of those whose course of life established by right counsel cannot be under their own control, especially those who must live or must direct their times for both working and being idle at another’s bidding. This has most certainly been my experience, most eminent prince. After I declared myself among your servants and those of your of‹ce, next to the highest in the Roman church, and dedicated my effort and, at the same time, my industry to this task, I ceased to be my own man altogether. I became sub- ject not only to your authority and will but also to your judgment. For this reason, I think it the special duty of my life to be approved by the one alone by whom I can be praised. I therefore understand that I must make the greatest effort that you not think that the leisure you most generously grant me to interrupt my tasks 101 Aqueduct Hunting in the Seventeenth Century: Raffaele Fabretti's De aquis et aquaeductibus veteris Romae Harry B. -

The Roads of Roman Italy
THE ROADS OF ROMAN ITALY THE ROADS OF ROMAN ITALY Mobility and Cultural Change Ray Laurence London and New York First published 1999 by Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge 29 West 35th Street, New York, NY 10001 Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2002. © 1999 Ray Laurence The right of Ray Laurence to be identified as the Author of this Work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988 All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers. British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloging in Publication Data Laurence, Ray, 1963– The roads of Roman Italy; mobility and cultural change/Ray Laurence. p. cm. Includes bibliographical references and index. 1. Roads, Roman—Italy. 2. Rome—Economic conditions. 3. Transportation—Social aspects—Rome. I. Title. DG28.5.L38 1999 388.1´0937–dc21 99–20446 CIP ISBN 0-415-16616-0 (hardbound) ISBN 0-203-06241-8 Master e-book ISBN ISBN 0-203-21526-5 (Glassbook Format) CONTENTS List of figures vii List of tables x Preface xi Acknowledgements xiii 1 Introduction 1 -

Caracalla's Baths
What the Romans Knew Piero Scaruffi Copyright 2018 http://www.scaruffi.com/know • Technology 1 What the Romans Knew • Imported technology – Stone Age • Pottery making • Cloth making • Tool making – Early civilizations • Wheel • Metallurgy • Writing • Mathematics • Astronomy • Shipbuilding • Food preservation 2 • Grape and oil cultivation What the Romans Knew • Engineering – Roma’s technological mastery of the environment • Roads: 70,000 kms • City walls • Sewer (cloaca) and aqueduct • Multi-story buildings • But… – Vertical waterwheel (1st c BC) used for grinding flour but no need to use it for "industrial" works because of surplus of free slave labor – No horses for agriculture – Little irrigation, relying on the sea for fishing and its colonies for agriculture 3 What the Romans Knew • Engineering – Rivers not fully exploited for transportation and travel because it is safe and rapid to travel by road and by sea – The great rivers (Danube and Rhine) provide the border, not a waterway 4 What the Romans Knew • Communication – Roads: 70,000 kms – Originally paved for military movement – Facilitates trade and administration – Travel becomes relatively easy and unexceptional • Postal delivery system serving the whole Mediterranean world ("cursus publicus") • Riders could cover about 270 kilometers in a 24-hour period • The speed with which mail could be carried about the Mediterranean was not equaled again in Europe until the 19th century 5 What the Romans Knew • Communication – Via Appia (312 BC) – Via Valeria (303 BC) – Via Aurelia (241