Tav. CV1-4 VA-V2 Documento Di
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
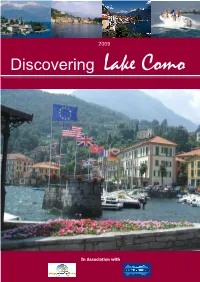
Discovering Lake Como
2009 Discovering Lake Como In Association with Welcome to Lake Como Homes About our Company Lake Como Homes in and can provide helpful Lake Como FREE conjunction with our partners assistance whatever your Advantage Card with every Happy Holiday Homes are now needs. rental booking! established as the leading property management and The Happy Holiday Homes letting company covering Lake team is here to assist you in Como. having a memorable holiday Advantage Card 2009 experience in one of the most Lake Como We are proud to offer a fully beautiful Lakes in the world. comprehensive service to our www.happyholidayhomes.net +39 0344 31723 customers and are equally Try our Happy Service which delighted in being able to offer specialises in sourcing our clients a wide and diverse exceptional good value deals on selection of holiday homes local events and activities and from contemporary studio passing the savings directly apartments to Luxurious onto you. This represents a discount to modern and period style Villas. many of the attractions and We thank you in selecting Lake Eateries about the lake. Happy Holiday Homes, based Como Homes and Happy in Menaggio have an Holiday Homes for your holiday enthusiastic multi-lingual team in the Italian Lakes. providing a personal service Happy Holiday Homes©, Via IV Novembre 39, 22017, Menaggio, Lake Como – www.happyholidayhomes.net - Tel: +39 034431723 Beauty in every sense of the word The Lake is shaped rather like an inverted 'Y', with two 'legs' starting at Como in the South- West and Lecco in the South-East, which join together half way up and the lake continues up to Colico in the North. -

The Old Connection Roads Between Moltrasio and Laglio
The old connection roads 2 between Moltrasio and Laglio Easy walk along old footpaths and stairways of the western side of the lake from the boat dock in Moltrasio to Laglio . ITINERARY: Moltrasio - Carate Urio - Laglio WALKING TIME ONE WAY: 1hr 30min ASCENT: 120 m DIFFICULTY: Easy TRAIL SIGNS: Absent CONNECTIONS: - by boat: from Como to Moltrasio every 30 min - by bus: bus C 10 or C 20, “via lago” bus stop Moltrasio Pontile Return from Laglio bus C10/20 ROUTE: from the boat pier at Moltrasio turn left along the main road and pass by the monument to Vincenzo Bellini, the Sicilian composer who lived here for a long time. Turn right up via Raschi to reach the centre of the village. This stairway is known as “the Scala Sancta” because it was used for holy processions and maybe also because it seems so long and steep. But it is not that tiring if you go up slowly and take your time to enjoy the views it gives of the village below and, on the other side of the lake, Torno, the manneristic villa Pliniana and the mountains Boletto and Bolettone. At the parish church follow via Curiè, piazza Umberto I and via Bianchi along the right bank of the stream and head up the valley by passing under the viaduct of the main road. As you reach Villa Memy bear right to reach Tosnacco , the highest suburb of Moltrasio (312 m). Cross the asphalted road and continue uphill following the way marks of the mountain trails. At a junction near the fountains, continue straight on via Marconi until you reach a T-junction with a stairway. -

C 10-20 Como - Argegno ORARIO INVERNALE
C_10-20 Como - Argegno ORARIO INVERNALE 100004 100008 100022 100016 200014 100026 100030 200020 100036 200022 100038 100040 100184 100046 100058 100062 100194 Fer6 Scol Scol Fer6 Scol Sco5 Scol Scol Fer6 Fer6 Gior Fer6 Scol Fer6 Scol Gior Sco5 20 U U 2 79 2 79 Lazzago - Magistri Cumacini Camerlata - Liceo Giovio Como - Stazione Autolinee 06.40 07.04 07.10 07.25 07.35 07.50 08.10 08.15 08.15 08.20 08.25 08.45 09.10 09.55 10.25 11.00 Como - Staz. S. Giovanni FS 06.44 07.14 08.19 08.24 08.29 08.49 09.14 09.59 10.29 11.04 Cernobbio - P.zza Mazzini 05.57 06.54 07.24 08.02 08.21 08.29 08.34 08.39 08.59 09.24 10.09 10.39 11.14 Moltrasio - Panoramica 06.03 07.18 07.39 07.48 08.08 08.29 08.35 08.40 09.05 10.15 11.20 Urio - Ponte 06:06 07:19 07:41 08:10 08:31 08:37 08:42 09:07 10:17 11:22 Carate - Olzavino 06:08 07:21 07.43 08:12 08:33 08.39 08:44 09:09 10:19 11:24 Laglio - Ticee (panoramica) 06:10 07:23 07.45 08:14 08:35 08.41 08:46 09:11 10:21 11:26 Torriggia - bivio Panoramica 06:13 07:26 07.48 08:17 08:38 08.44 08:49 09:14 10:24 11:29 Moltrasio - Pontile 06.59 07.29 08.27 08.45 09:29 10:44 Urio - Pontile 07:03 07:33 08:29 08:49 09:33 10:48 Carate - Pontile 07:06 07:36 08.34 08:52 09:36 10:51 Laglio - Piazza Riva Silvio 07:07 07:37 08.35 08:53 09:37 10:52 Torriggia - Via Regina - Pontile 07:08 07:38 08.36 08:54 09:38 10:53 Brienno - Paese 06.16 07.15 07.45 08.20 08.48 09.18 09:45 11:00 Argegno - P.zza Roma - Pontile 06.22 07:21 07.33 07.51 07.56 07.59 08.27 08.45 08.46 08:54 08.57 09.01 09.26 09.56 10.32 11.06 11.39 segue 2 Si effettua solo nei giorni di Vacanze Scolastiche Invernali. -

Il Prefetto Di Como Ignazio Coccia., Il Sindaco Di Laglio (CO): Roberto Pozzi, La Cittadinanza Democratica E Antifascista
Destinatario: Il Prefetto di Como Ignazio Coccia., Il sindaco di Laglio (CO): Roberto Pozzi, La cittadinanza democratica e antifascista Lettera: Saluti, Sindaco e Prefetto impediscano a Laglio (CO) l'ennesima iniziativa omofoba organizzata FN Firme Nome Posizione Data osservatorio democratico Italia 2019-06-10 sulle nuove destre como Rosanna Ceroni Castiglion Fno, Arkansas, USA 2019-06-10 isabella cellerino torino, Italia 2019-06-10 adelina finzi Venice, Italia 2019-06-10 Roberta Bonacina Italia 2019-06-10 paolo ferrero Italia 2019-06-10 Mauro Baroni Italia 2019-06-10 Patrizia Cassinera Milan, Italia 2019-06-10 Cristiano Negrini Villa Guardia, Italia 2019-06-10 Cornelio Montalbetti Bergamo, Italia 2019-06-10 fabrizio baggi Como, Italia 2019-06-10 Maria Luisa Cossu Portoscuso, Italia 2019-06-10 Evangeline irabon Italia 2019-06-10 silvia valore como, Italia 2019-06-10 Stefano Rognoni Como, Italia 2019-06-10 maurizio mazzucchetti San Paolo, Italia 2019-06-10 Alda Colombera Italia 2019-06-10 Revelin Irabon Como, Italia 2019-06-10 Simonetta Venturini Verona, Italia 2019-06-10 Albino CASATI Bernareggio, Italia 2019-06-10 Nome Posizione Data ilario poloni Italia 2019-06-10 MARCO NORIS Seriate, Italia 2019-06-10 Marinella mandelli Italia 2019-06-10 Eugenio Michele Lussu Uknown, Italia 2019-06-10 giuseppe casati Italia 2019-06-10 Tiziana Cester Bernareggio, Italia 2019-06-10 alberto panaro brugherio, Italia 2019-06-10 Mak Da Ros Italia 2019-06-10 Raffaele Vampa Inzago, Italia 2019-06-10 Sabato Crescenzo Anzio, Italia 2019-06-10 giorgio colombo Milanese, -

Strada Regia Da Pognana a Nesso
C.A.I. AROSIO Domenica 15 Aprile 2018 Strada Regia da Pognana a Nesso Punto di partenza: Pognana (Co) Dislivello di salita: 415 m Durata: 2.30 h (fino a Nesso) + 2.00 h (rientro a Pognana) Difficoltà: T/E Programma: ore 7.30 partenza con mezzi propri dal PARCHEGGIO DELLA CASETTA DELL'ACQUA DI AROSIO (Via G. Oberdan, di fronte al civico 106). ore 8.50 partenza con Bus C30 da stazione S. Giovanni a Como ore 9.30 inizio cammino: Pognana (m 220 ca) ore 15.34- 17.34 partenza Bus C30: Nesso-Como (segue rientro ad Arosio) oppure: ore 15.45- 17.45 partenza Bus C30: Pognana-Como (segue rientro ad Arosio) Costo pullman: A/R - (+ 8,5 € assicurazione obbligatoria per i non soci.) Equipaggiamento: da escursionismo (giacca a vento, pile e scarponi, utili i bastoncini telescopici). Accompagnatori: Adriano Longoni, Otello Fasolato. (Cell. CAI: 3312659143) N.B.: Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti. Da Arosio raggiungere Como, parcheggiare in zona Stazione San Giovanni. Per BUS C30 Andata Como-Pognana: Stazione S.Giovanni ore 8.50, arriva alle ore 09.16 Ritorno: da Pognana imbarcadero: ore 15.45 oppure 17.45 arriva a Como in mezz’ora circa Ritorno da Nesso, Piazza Castello: 15,34 oppure 17.34 arriva a Como in mezz’ora circa La Strada Regia è oggi un percorso pedonale ben segnalato e lungo circa 30km. Suddiviso in tappe: Brunate-Torno, Torno-Pognana, Pognana-Nesso, Nesso-Bellagio. 1 Da Pognana, passando per Careno e arrivando a Nesso: lunghezza del tratto pedonale: 5,6 Km percorso: mulattiere gradonate, sentieri Itinerario; seguendo le indicazioni della Strada Regia: • autobus C30, da Como a Pognana • Si parte dalla biglietteria di Pognana Lario, si imbocca via Quarzano per arrivare alla omonima frazione di Quarzano. -

Interventi Volti Al Mantenimento Dell'alloggio
AZIENDA SOCIALE COMASCA E LARIANA (Albese con Cassano, Bellagio, Brunate, Cernobbio, Como, Lezzeno, Lipomo, Maslianico, Montano Lucino, Montorfano, San Fermo della Battaglia, Tavernerio, Brienno, Carate Urio, Laglio, Moltrasio, Blevio, Faggeto Lario, Nesso, Pognana Lario, Torno, Veleso, Zelbio) INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19– ANNO 2020 – DGR 3008/2020 Approvato con Determinazione Direttoriale n. 22 del 23/4/2020 1. FINALITA’ Il presente bando mira a sostenere nel mantenimento dell’alloggio in locazione nuclei familiari in disagio economico o in condizioni di particolare vulnerabilità. 2. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI Possono fare istanza di contributo i nuclei familiari: • residenti nei Comuni di: Albese con Cassano, Bellagio, Blevio, Brienno, Brunate, Carate Urio, Cernobbio, Como, Faggeto Lario, Laglio, Lezzeno, Lipomo, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Nesso, Pognana Lario, San Fermo della Battaglia, Tavernerio, Torno, Veleso e Zelbio; • titolari di contratto di locazione, efficace e registrato, su libero mercato o che abbiano in godimento alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art. 1 c.6 • con ISEE ordinario o corrente non superiore a € 20.000,00 • non sottoposti a procedure per il rilascio dell’abitazione • non proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia • residenti nell’alloggio in locazione almeno dal 30/03/2019 • in situazione di disagio economico o condizione di particolare vulnerabilità. I destinatari del presente provvedimento non possono essere identificati tra i cittadini dei Comuni ad Alta Tensione Abitativa (nell'Ambito: Comune di Como) che hanno ricevuto il contributo “AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020”, ai sensi della DGR n. -

From Brunate to Monte Piatto Easy Trail Along the Mountain Side , East from Como
1 From Brunate to Monte Piatto Easy trail along the mountain side , east from Como. From Torno it is possible to get back to Como by boat all year round. ITINERARY: Brunate - Monte Piatto - Torno WALKING TIME: 2hrs 30min ASCENT: almost none DESCENT: 400m DIFFICULTY: Easy. The path is mainly flat. The last section is a stepped mule track downhill, but the first section of the path is rather rugged. Not recommended in bad weather. TRAIL SIGNS: Signs to “Montepiatto” all along the trail CONNECTIONS: To Brunate Funicular from Como, Piazza De Gasperi every 30 minutes From Torno to Como boats and buses no. C30/31/32 ROUTE: From the lakeside road Lungo Lario Trieste in Como you can reach Brunate by funicular. The tram-like vehicle shuffles between the lake and the mountain village in 8 minutes. At the top station walk down the steps to turn right along via Roma. Here you can see lots of charming buildings dating back to the early 20th century, the golden era for Brunate’s tourism, like Villa Pirotta (Federico Frigerio, 1902) or the fountain called “Tre Fontane” with a Campari advertising bas-relief of the 30es. Turn left to follow via Nidrino, and pass by the Chalet Sonzogno (1902). Do not follow via Monte Rosa but instead walk down to the sportscentre. At the end of the football pitch follow the track on the right marked as “Strada Regia.” The trail slowly works its way down to the Monti di Blevio . Ignore the “Strada Regia” which leads to Capovico but continue straight along the flat path until you reach Monti di Sorto . -

Bandi Youthbank
Como, 25 febbraio 2019 All’attenzione delle amministrazioni comunali della provincia di Como OGGETTO: BANDI YOUTHBANK La Fondazione Comasca in collaborazione con quattro non profit della provincia mette a disposizione 150.000 € per progetti realizzati da ragazzi under 25 nel territorio della provincia di Como. I giovani interessati a ricevere un contributo per idee volte a migliorare la comunità in cui vivono devono presentare il proprio progetto alla Fondazione Comasca, sul bando YouthBank del territorio nel quale l’iniziativa si concretizza, tramite organizzazioni non profit operanti nella provincia di Como entro il 2 maggio 2019. I progetti non potranno essere a scopo di lucro e dovranno essere di utilità sociale. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.nonunodimeno.eu/youthbank o contattare le singole YouthBank. Per accompagnare i giovani che vogliono presentare le proprie iniziative, ogni YouthBank mette a disposizione risorse umane in grado di aiutare gli interessati nella fase di progettazione e realizzazione del progetto. BANDO YOUTHBANK COMO – 6° 2018 Risorse a disposizione: euro 40.000 Contributo massimo richiedibile: 5.400 euro (max. 90% del progetto) Importo massimo del progetto: 6.000 euro Comuni nei quali possono realizzarsi i progetti: Albese con Cassano, Blevio, Brienno, Brunate, Carate Urio, Cavallasca, Cernobbio, Como, Faggeto Lario, Laglio, Lipomo, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Nesso, Pognana Lario, San Fermo della Battaglia, Tavernerio, Torno, Veleso, Zelbio; (N.B. I progetti realizzati nei comuni di Lezzeno e Bellagio possono essere presentati SOLO sul Bando YouthBank Centro Lago 2018) Si terranno presso la Fondazione Comasca il 6 marzo e il 19 marzo alle ore 15,00 due incontri di formazione per i ragazzi partecipanti su progettazione e raccolta fondi. -

DELIBERAZIONE N° XI / 4882 Seduta Del 14/06/2021
DELIBERAZIONE N° XI / 4882 Seduta del 14/06/2021 Presidente ATTILIO FONTANA Assessori regionali LETIZIA MORATTI Vice Presidente GUIDO GUIDESI STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini Su proposta dell'Assessore Riccardo De Corato Oggetto SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DA ATTUARE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI COMO, CANTÙ, CUCCIAGO, CAPIAGO INTIMIANO, ERBA, PUSIANO, EUPILIO, MARIANO COMENSE, COLICO, SAN FERMO DELLA BATTAGLIA, CERNOBBIO, MOLTRASIO, CARATE URIO, LAGLIO, BRIENNO, BLEVIO, TORNO, FAGGETO LARIO, POGNANA LARIO, NESSO, LEZZENO, BELLAGIO, COLICO, DERVIO, DORIO, SUEGLIO E VALVARRONE, DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE FINO AL 15 NOVEMBRE 2021 Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Direttore Generale Fabrizio Cristalli Il Dirigente Antonino Carrara L'atto si compone di 13 pagine di cui 7 pagine di allegati parte integrante VISTA la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" e, in particolare, le seguenti disposizioni, che prevedono: - art. 1, comma 3: il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’ente locale da cui dipende il personale, per l’erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza; - art. -

Megaturbidite Deposits in the Holocene Basin Fill of Lake Como (Southern Alps, Italy) ⁎ Daniela Fanetti A, , Flavio S
This article was published in an Elsevier journal. The attached copy is furnished to the author for non-commercial research and education use, including for instruction at the author’s institution, sharing with colleagues and providing to institution administration. Other uses, including reproduction and distribution, or selling or licensing copies, or posting to personal, institutional or third party websites are prohibited. In most cases authors are permitted to post their version of the article (e.g. in Word or Tex form) to their personal website or institutional repository. Authors requiring further information regarding Elsevier’s archiving and manuscript policies are encouraged to visit: http://www.elsevier.com/copyright Author's personal copy Available online at www.sciencedirect.com Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 259 (2008) 323–340 www.elsevier.com/locate/palaeo Megaturbidite deposits in the Holocene basin fill of Lake Como (Southern Alps, Italy) ⁎ Daniela Fanetti a, , Flavio S. Anselmetti b, Emmanuel Chapron b, Michael Sturm c, Luigina Vezzoli a a Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali, Università degli Studi dell'Insubria, via Valleggio 11, I-22100 Como, Italy b Geological Institute, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zentrum, CH-8092 Zürich, Switzerland c EAWAG, Überlandstrasse 133, CH-8600 Dübendorf, Switzerland Received 8 October 2005; accepted 28 February 2007 Abstract For the first time, limnogeological investigations have been carried out in Lake Como, the deepest lake of the Alps, combining a bathymetric survey (multibeam Simrad 3000) with a high-resolution seismic reflection study (single-channel 3.5 kHz sub-bottom profiler) and a coring campaign (gravity corer). This data set enables detailed characterization of the sedimentary subsurface in the western branch of the lake, the Como branch, which has a typical fjord morphology. -

(Siba) Decreto Ministeriale 16 Agosto 1955
Sistema informativo Beni e Ambiti Paesaggistici (S.I.B.A.) DECRETO MINISTERIALE 16 AGOSTO 1955. DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA FASCIA COSTIERA DEL LAGO DI COMO, SITA NELL'AMBITO DEI COMUNI DI COMO, CERNOBBIO, MOLTRASIO, CARATE URIO, LAGLIO, BRIENNO, ARGEGNO, COLONNO, SALA COMACINA, OSSUCCIO, LENNO, TREMEZZO, GRIANTE, MENAGGIO, SANTA MARIA REZZONICO, CREMIA, PIANELLO LARIO, MUSSO, DONGO, GRAVEDONA, DAMASO E GERA. IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI; VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA; CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COMO PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI, NELLA ADUNANZA DEL 29 MAGGIO 1953, INCLUDEVA NELL'ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRACITATA, LA FASCIA COSTIERA DEL LAGO DI COMO, SITA NELL'AMBITO DEI COMUNI DI COMO, CERNOBBIO, MOLTRASIO, CARATE URIO, LAGLIO, BRIENNO, ARGEGNO, COLONNO, SALA COMACINA, OSSUCCIO, LENNO, TREMEZZO, GRIANTE, MENAGGIO, SANTA MARIA REZZONICO, CREMIA, PIANELLO LARIO, MUSSO, DONGO, GRAVEDONA, DAMASO E GERA; CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDDETTA COMMISSIONE E' STATO PUBBLICATO AI SENSI DEL CITATO ART. 2 DELLA LEGGE SULLE BELLEZZE NATURALI, PER UN PERIODO DI TRE MESI ALL'ALBO DEI COMUNI DI COMO, CERNOBBIO, MOLTRASIO, CARATE URIO, LAGLIO, BRIENNO, ARGEGNO, COLONNO, SALA COMACINA, OSSUCCIO, LENNO, TREMEZZO, GRIANTE, MENAGGIO, SANTA MARIA REZZONICO, CREMIA, PIANELLO LARIO, MUSSO, DONGO, GRAVEDONA, DAMASO E GERA; VISTE LE OPPOSIZIONI PRODOTTE DALLA SOCIETA' ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK, DAL SIG. SORMANI AMOS, DA UN GRUPPO DI CITTADINI DEL COMUNE DI BRIENNO, DAL COMUNE DI COLONNO, DAL SIG. -

C 10 Como - Menaggio - Colico VETTORE ASF ORARIO INVERNALE
C_10 Como - Menaggio - Colico VETTORE ASF ORARIO INVERNALE o Si effettua solo il sabato/Only on Saturday 2 Si effettua solo nei giorni di vacanza Scolastica invernali/Only in school holidays 15 Si effettua solo il sabato Scolastico/Only in school Saturday 18 Circola nei giorni di Vacanze Scolastiche Invernali, da Lunedì a Venerdì/Only in school holidays, from Monday to Friday 20 A Cernobbio coincidenza con corsa 60001 della Linea 6 proveniente da Como/In Cernobbio connection with Line 6 - service number 60001 79 Circola nei giorni Scolastici da Lunedì a Venerdì/Only in school days from Monday to friday 96 Circola nei Lunedì, Mercoledì e Venerdì Scolastici/Only in school days on monday, wednesady and friday A7 Transita da Viale Varese, Viale Cattaneo, Piazza Vittoria, Via Battisti, Viale Lecco ed omette la fermata di Lungo Lario Trento/The service goes through Viale Varese, Viale Cattaneo, Piazza Vittoria, Via Battisti, Viale Lecco. It does not stop in Lungo Lario Trento C3 Per e da Lazzago Magistri C. è richiesta l'integrazione tariffa urbana/To and from Lazzago Magistri C. urban fare extracharge is required C9 Transita da Centro Commerciale "Fuentes"/Through shopping mall "Fuentes" E3 In arrivo da Porlezza non transita da Menaggio ma dalla galleria Crocetta fino a Cadenabbia/The service comes from Porlezza and does not stop in Menaggio downtown L4 Dalla Magistri transita dalla via Varesina e termina a Como-Stazione Autolinee / From the Magistri it passes from Via Varesina and ends at Como-Autolinee Station. K7 Prosegue per S. Fedele come C 20 M9 Proviene da S.