Come Raggiungerci
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ha Pronunciato La Presente Sul Ricorso Numero Di Registro Generale 692 Del
N. 00152/2011 REG.PROV.COLL. N. 00692/2004 REG.RIC. N. 00173/2006 REG.RIC. N. 00335/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 692 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Foglietti, Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Fabrizio Avv. Foglietti in L'Aquila, p.zza S. Giusta, N. 4 (N.I.); contro Comune di Roccaraso; nei confronti di Comune Roccaraso-Terzo Settore Area Tecnica; Immobiliare D'Aurora S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Stefano Rossi, con domicilio eletto presso Stefano Avv. Rossi in L'Aquila, via Persichetti 10; Condominio Residence "Neve e Sole", rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carli, con domicilio eletto presso Francesco Avv. Carli in L'Aquila, via Ulisse Nurzia N. 26; e con l'intervento di ad opponendum: Stefano Selvaggi, rappresentato e difeso dagli avv. Arcangelo D' Avino, Paolo D'Avino, con domicilio eletto presso Alessandro Avv. Rosa in L'Aquila, via Poggio Picenze, 21; Roberto Ravier, Stefano Teneriello, Fabio Santaniello, Vincenzo Moretta, Luigi Caruso, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo D'Avino, Arcangelo D' Avino, con domicilio eletto presso Alessandro Avv. Rosa in L'Aquila, via Poggio Picenze, 21; Almerinda Di Benedetto, rappresentata e difesa dagli avv. Arcangelo D'Avino, Paolo D'Avino, con domicilio eletto presso Alessandro Avv. Rosa in L'Aquila, via Poggio Picenze, 21; sul ricorso numero di registro generale 173 del 2006, proposto da: Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. -
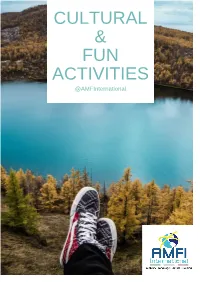
Marketing Report
CULTURAL & FUN ACTIVITIES @AMFInternational 02 | Cultural & Fun Activities @AMFInternational CELANO CASTLE Come and visit the most important building in Celano. This beautiful castle has four massive angular towers, defended by walls reinforced by external cylindrical towers, while the courtyard is delimited by numerous porches. The interior hosts the Diocesan Sacred Art museum that exposes the remains, testimonies and stone artifacts originating between the VII and XIII centuries, wooden sculptures of the XII century, the original frescoes dated between the XIV and XV centuries, the paintings from the XII century until the XVIII century. Finally, jewelry and vestments. COST €10,00/person CELANO MUSEUM The Prehistoric Museum of Paludi (Musè), is an exhibition space located in Fucino. It was built on the site where it was found a pile-dwelling settlement of the twelfth century B.C. The cemeteries were located on the left bank of the lake, which is prone to waterlogging, a feature that gave its name to the archaeological site. The innovative basement that houses the museum was designed by the architects Ettore De Lellis and Pierluigi Natalucci. It is inspired on the prehistoric burial mounds. COST €10,00/person 03 | Cultural & Fun Activities @AMFInternational ALBA FUCENS Alba Fucens, ancient Roman city at the foot of Monte Velino (Province of Aquila), is an archaeological jewel that one should most definitely explore! The ruins that emerged from the 1949 excavations are truly remarkable. COST €20,00/person S. MARIA VALLE PORCLANETA In the beautiful valley called Porclaneta, at the foot of Monte Velino and near to the village of Rosciolo, there is the Santa Maria Church. -

Inclusione, a Fontecchio Laboratori Artistici E Di Cucina Per Il Progetto Arci “Incontri”
| 1 INCLUSIONE, A FONTECCHIO LABORATORI ARTISTICI E DI CUCINA PER IL PROGETTO ARCI “INCONTRI” FONTECCHIO – Dopo gli appuntamenti di Calascio, Barisciano e Castelvecchio Subequo, il progetto “Incontri, culture e tradizioni senza confini”, promosso dall’associazione di promozione sociale Arci L’Aquila, prosegue a Fontecchio (L’Aquila) con la seconda tranche di laboratori iniziati il primo luglio. Realizzato in partenariato con le associazioni di volontariato Auser L’Aquila, Bibliobus L’Aquila e La Ginestra Subequana Onlus, con ben 58 appuntamenti in programma rivolti alle scuole e alle comunità locali, il progetto “Incontri” sta coinvolgendo centinaia di persone in tutto il www.virtuquotidiane.it | 2 comprensorio e va avanti fino a ottobre. In collaborazione con le Cooperative di comunità di Calascio e Fontecchio e Yaw (Young artist workers), a Fontecchio si svolgeranno un’officina di cucina, un laboratorio manuale ed uno artistico nei giorni 12, 13 e 14 luglio. Il progetto si fonda sul coinvolgimento di gruppi eterogenei di persone, che avranno un reciproco vantaggio nelle azioni di dialogo e conoscenza attraverso la valorizzazione del territorio e della tradizione. L’arte e l’artigianato sono protagonisti come strumenti di inclusione sociale, veicolo di dialogo interculturale e di conoscenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale. “Abbiamo iniziato a giugno con i laboratori nelle scuole a Pizzoli, dove abbiamo proposto agli alunni di mettersi in gioco attraverso la conoscenza di sé e dell’altro attraverso il disegno e poi all’interno del territorio e abbiamo trovato una risposta positiva, i ragazzi si sono messi in gioco senza paura o pregiudizi, hanno percepito empatia ed inclusione, l’assenza di un pregiudizio li ha portati a sentirsi liberi”, dice Francesca Chiola, tra i fondatori dell’Associazione Yaw, nata a Calascio lo scorso anno da un gruppo di studenti dell’Accademia di Belle arti dell’Aquila. -

SAGITTARIUS VALLEY and PELIGNA DELL BETWEEN 4Th and 1St CENTURY BC TRENDS and DEVELOPMENTS of ROMANIZATION
SAGITTARIUS VALLEY AND PELIGNA DELL BETWEEN 4th AND 1st CENTURY BC TRENDS AND DEVELOPMENTS OF ROMANIZATION SUMMARY PART I. THESIS FOREWORD It describes the problems that the present work is to contribute to solve : the still poor understanding of Romanization as a phenomenon in the Peligna Valley and the state of documentation, very substantial but fragmentary and unsystematic in large part. The theme of Romanization is introduced and defined, from an historical point of view. Finally, it focuses on methodology followed while developing the work as well as advantages and limitations involved. Acknowledgements and more detailed methodological note close-out this section. HISTORY OF STUDIES An overview of the most significant discoveries and studies on the above mentioned territoryfrom the beginning of the modern era to the present time. PELIGNI SOURCES IN LATIN AND GREEK Analysis of the testimonies of Greek and Latin authors on Peligni, broken down into: Geographical Testimonies Testimonies relating to religion, myths, and customs Documents on the history of Peligni and their relationships with Rome Sources on rearrangements in Romans ’ territory planning activities GEOGRAPHICAL FEATURES Description of area main elements from a geographical point of view, that includes how the territorial structure has influenced the ancient built-up areas. It also outlines the different areas in which the territory is divided. ANALYSIS OF ARCHAEOLOGICAL CONTEXTS A study of the archaeological contexts belonging to each type being present in the territory (urban spreads, sanctuaries, necropolis) provided with a detailed analysis of cultural materials and inscriptions, which is relating to the different districts: SagittariusValley . Study of the necropolis lying in the territory of Anversa degli Abruzzi, a sub-region inserted in the preferred trade routes between the territories of Piceno, Sannio, and Daunia, which were less exposed to the influence of Tyrrhenian and Lazio areas . -

35ª Corsa Podistica “Valle Peligna” 1º Memorial “Emiliano D
ARCICONFRATERNITA SS. TRINITÀ Comune di Festeggiamenti 14 e 15 giugno Pratola Peligna G.A.P. GRUPPO AMATORIALE PODISTICO organizza EntedeSllacPuroovinlcaia dEi dile gruppo autotrasporti sulmona S.S. 80 km. 9 n. 61LLo’cA. Sq. uVititolarino - 67100 L’Aquila www.scuolaedilelaquila.it [email protected] s.a.s. di Angelone Gennaro & C. SOCIETA DI COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI Via Papa Giovanni XXIII, 67 - Tel./Fax 0864.53755 - SUMONA (AQ) PRATOLA PELIGNA (AQ) DOMENICA GRAN PRIX REGIONALE ACCONCIATORE PER UOMO DI CORSA SU STRADA CSEN E UISP MAGGIO ’14 18 valida circuito corrilabruzzo punti 30 AntonMAEiSToRO AP.N.A.eM. trella 35ª Corsa Podistica “Valle Peligna” Via Carso, 88 - Pratola Peligna 1º Memorial “Emiliano D’Andreamatteo” Riparazione & Trasformazione 21º Trofeo Arciconfraternita “SS. Trinità” Veicoli Industriali Rimorchi e Semirimorchi Montaggio rampe elettroidrauliche 13 º Trofeo “ HOTEL SANTACROCE” Saldature in alluminio, ferro e acciaio di Tonio Di Giannantonio & C. S.a.s. e-mail: [email protected] Produzione e riparazione tubi oleodinamici PARTENZA ED ARRIVO: P.ZZA NAZARIO SAURO - KM. 0,300 - 0,500 - 1 - 11,2 • LUDICO MOTORIA KM. 5 INERTI - CONGLOMERATI BITUMINOSI - MOVIMENTO TERRA Iscrizioni: Fax 0872.590249 • [email protected] Via Valle Arcione - Zona Ind. - RAIANO - Tel. 0864.726128 Via Tratturo - Tel. 0864.272045 PRATOLA PELIGNA (AQ) Info: Tel. 348.5133373 - 347-4450692 www.gap-pratola.it [email protected] HOTEL MEETING RESTAURANT S.S. 17 km. 95,500 Sulmona PANIFICIO tel/fax 0864.251696 VALLE MADONNA www.hotelsantacroce.com HOTEL OVIDIUS Via Valle Madonna, 6 RESTAURANT Via Circ. Occidentale, 177 Tel. 0864.271741 tel/fax 0864.53824 PRATOLA PELIGNA www.hotelovidius.com a n g i l e ARTIGIANI PASTAI DA 5 GENERAZIONI p a l o t a r p • o t t u Per noi la pasta è ancora un arte t a ’ p m Via Enopolio - Tel. -

DETERMINAZIONE N. DPD022/28 Del 20/07/2017 Progressivo N. 7975/18
GIUNTA REGIONALE DETERMINAZIONE n. DPD022/28 del 20/07/2017 Progressivo n. 7975/18 DIPARTIMENTO: POLITICHEDELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA SERVIZIO: DPD022 - Servizio Promozione della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura UFFICIO: Cooperazione finalizzata alle Macro e Micro Filiere, ai Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI), Interventi di Formazione, Consulenza e Azioni Dimostrative a favore delle Aziende Agricole OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo. Misura M01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione ”. Bando approvato con Determinazione DPD022/40 del 23.12.2016 - Fase B) - Approvazione graduatorie definitive dei beneficiari dei voucher distinte per focus area. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VISTO il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2014-2020 attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015) 7994 del 13 novembre 2015; VISTA la D.G.R. n. 1056 del 19/12/2015 recante: “Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo – CCI2014IT06RDRP001 – Presa d’atto”; VISTA la Determinazione dirigenziale n. -

Relazione Tecnica Illustrativa
Organizzazione con 6LVWHPDGL*HVWLRQH4XDOLWj Certificato n. 176349 ³&203/(7$0(1726,,5(*,21($%58==2´ Interventi di cui art 3 comma 2 lettera C L. 164/2014 ³'(&5(726%/2&&$,7$/,$´ RIFACIMENTO POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IDROPOTABILE AREA PELIGNA ALTO SANGRO PROGETTO PRELIMINARE ELABORATO: ALLEGATO RELAZIONE ILLUSTRATIVA A DATI CATASTALI: Fg. ____ Par. _____ SCALA: DATA: Gennaio 2015 $JJLRUQDP $JJLRUQDP Collaboratori: SETTORE TECNICO SACA Spa 6XOPRQDOu Il Responsabile del Procedimento INDICE RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA ........................................................................ 2 1- PREMESSA ..................................................................................................................... 2 2- ELENCO DEGLI INTERVENTI .................................................................................. 2 3- DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ....................................................................... 3 1. Adeguamento tecnologico ed efficientamento energetico centrale Surriente nel comune di Castel di Sangro .................................................................................................... 3 2. Adeguamento tecnologico ed efficientamento energetico centrale via Pineta Vittoria nel comune di Roccaraso ......................................................................................................... 4 3. Rifacimento cabine MT-BT e quadri MCC Centrali di sollevamento di Roccaraso, Pescocostanzo e Campo di Giove; ......................................................................................... -

Lettera SUAP
COMUNITÀ MONTANA PELIGNA “ZONA F Comuni associati al SUAP: Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Vittorito, Villalago (Rev. 01) Allo Sportello Unico Associato per le Attività Produttive Via Angeloni 11 67039 Sulmona Comune di _______________________ OGGETTO: DICHIARAZIONE SULLA CONFORMITA’ DELL’OPERA RISPETTO AL PROGETTO PRESENTATO E LA SUA AGIBILITA’ ( Art.10 Capo V del D.P.R. N. 160/2010 del 7 settembre 2010, “Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38, comma 3, del decreto Legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133, dalla Legge n.133 del 2008 ). A1: SE IL RICHIEDENTE E’ UN PRIVATO: I sotttoscritt Sig. ..................................................................... nat ........................... il ................................. e residente in .......................................... Via ……………….. n…..C.F...................................................... in qualità di ………………….. e titolare della : Permesso di costruire N ……… del ………………………… C.U.E. del ……… DIA /…………….………….. N………… del………………………… Prot. N…………… inerente il fabbricato/ locale, ad uso produttivo sito a in Via ……………………... civ. ………. individuato catastalmente al n. di foglio……….part…………sub……….CAT…….. A2: SE IL RICHIEDENTE E’ UNA SOCIETA’ O UN ENTE: Ia sotttoscritta Società individuale/ ditta .................................................................... -

Calendario Allievi Under 17 L'aquila 2019/2020
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 CALENDARIO ALLIEVI UNDER 17 L’AQUILA CALENDARIO ALLIEVI UNDER 17 L'AQUILA 2019/2020 1^ GIORNATA 2^ GIORNATA 3^ GIORNATA 4^ GIORNATA 03/11/2019 09/02/2020 10/11/2019 16/02/2020 17/11/2019 23/02/2020 24/11/2019 01/03/2020 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 GRAN SASSO CALCIO - PESCASSEROLI CAPISTRELLO A.S.D. - REAL L AQUILA CAPISTRELLO A.S.D. - VIRTUS MARSICA EST GRAN SASSO CALCIO - PIZZOLI PIZZOLI - REAL CARSOLI LUPI MARSI AVEZZANO N. - PIZZOLI PIZZOLI - PESCASSEROLI LUPI MARSI AVEZZANO N. - SPORTLAND F.C. CELANO REAL L AQUILA - VIRTUS MARSICA EST PUCETTA - SPORTLAND F.C. CELANO REAL L AQUILA - PUCETTA PESCASSEROLI - SPORTING LIBERATI GUIDO SPORTING LIBERATI GUIDO - PUCETTA REAL CARSOLI - SPORTING LIBERATI GUIDO SPORTING LIBERATI GUIDO - LUPI MARSI AVEZZANO N. PUCETTA - CAPISTRELLO A.S.D. SPORTLAND F.C. CELANO - CAPISTRELLO A.S.D. VIRTUS MARSICA EST - GRAN SASSO CALCIO SPORTLAND F.C. CELANO - REAL CARSOLI REAL CARSOLI - REAL L AQUILA RIPOSA - LUPI MARSI AVEZZANO N. RIPOSA - PESCASSEROLI RIPOSA - GRAN SASSO CALCIO RIPOSA - VIRTUS MARSICA EST 5^ GIORNATA 6^ GIORNATA 7^ GIORNATA 8^ GIORNATA 01/12/2019 08/03/2020 08/12/2019 15/03/2020 15/12/2019 29/03/2020 12/01/2020 05/04/2020 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 CAPISTRELLO A.S.D. - REAL CARSOLI GRAN SASSO CALCIO - SPORTLAND F.C. CELANO CAPISTRELLO A.S.D. - PESCASSEROLI GRAN SASSO CALCIO - CAPISTRELLO A.S.D. PUCETTA - VIRTUS MARSICA EST LUPI MARSI AVEZZANO N. -

Roccaraso Testo Inglese
THE MOST IMPORTANT SKIING RESORT IN SOUTHERN CENTRAL ITA LY RO C C A R A S O THE TOURISM RO U T E It lies between the Parco Nazionale dell'Abruzzo and the Parco della Majella and, thanks to its natural location, to its excellent accommodation facilities and sports equipment, Roccaraso, also called the "Cortina of the South", is a tourist resort becoming more and more appreciated by skiers and mountain lovers in every season of the year HISTORICAL BACKGROUND Be t ween the National Park of A b r uzzo and the Majella Park, a massive group of mountains bounds the reg i o n of the broadest plateau of the A b ruzzo region, among which there is Piano delle Cinquemiglia that stretches for about nine kilometres. It's a place rich in surprises for tourists: a broad terr i t o r y of about 30 km, with remark- a ble beauties of nature and landscapes. The altitude, the richness in water and the good quality of the pastures favour both agriculture and fa r ming. At the centre of the plateau there is Roccaraso, lying just at the beg i n n i n g of the big va l l ey of the River Rasine, tribu t a r y of the River Sangro, at the foot of Monte Zurrone. The village sprang up around the year 1000 in a strategic position, since it controlled the only southern passage of the reg i o n , on the Via Minucia, the main route between the North and the South of the Peninsula. -

Legenda Tav. E1 – Siti Di Interesse Archeologico E Antropologico
LEGENDA TAV. E1 – SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E ANTROPOLOGICO I siti di interesse archeologico nel Parco Naturale Regionale Sirente - Velino e nelle aree limitrofe NEL TERRITORIO DEL PARCO NELLE AREE LIMITROFE NECROPOLI NECROPOLI 1. Castelvecchio Subequo - loc. Le Castagne 7. Celano- loc. Le Paludi 2. Castelvecchio Subequo - loc. Colle Cipolla 8. Fossa - loc. Casale 3. Castelvecchio Subequo - loc. Macrano 9. Scurcola Marsicana - loc. Piani Palentini 4. Molina Aterno - loc. Campo Valentino 10. S. Benedetto in Perillis - loc. Colle S. Rosa Valle 5. Castelvecchio Subequo - loc. Campo di Moro 11. Caporciano - loc. Campo di Monte 6. Ovindoli - S. Potito loc. dei Santi 12. Celano- loc. Ruscella INSEDIAMENTI INSEDIAMENTI 13. Fagnano Alto - Termine loc. Le Fratte. 43. Ocre - loc. Castello di Ocre 14. Fagnano Alto - loc. Colle di Opi 44. Pescina - loc. Rocca Vecchia 15. Fontecchio- loc. Castellone S. Pio 45. Collarmele - centro storico 16. Fontecchio -loc. Chiesa di S. Vittoria 46. Aielli - centro storico 17. Tione degli Abruzzi - loc. Colle Rischia 47. Celano - Bussi loc. Capo Porciano 18. Tione degli Abruzzi - Villa Grande 48. Celano - loc. Le Paludi 19. Acciano - Beffi loc. La Fonte 49. Celano - loc. Ruscella 20. Acciano- area adiacente al cimitero 50. Massa d’Albe - loc. Alba Fucense/ S. Pietro/Albe 21. Molina Aterno - Campo Valentino Vecchia 22. Molina Aterno - Mandra Murata 51. Fossa - loc. Monte di Cerro 23. Molina Aterno - Colle Castellano 52. S. Demetrio ne’ Vestini - loc. Sinizzo 24. Castelvecchio Subequo - loc. Colle Cipolla 53. Prata d’Ansidonia - S. Nicandro loc. Leporanica 25. Castelvecchio Subequo - loc. Macrano 54. Prata d’Ansidonia - loc. Collemaggiore 26. Castelvecchio Subequo - loc. -

Asl 201 Avezzano-Sulmona-L'aquila
REGIONE ABRUZZO - DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO INFERMI E FERITI - ELENCO AGGIORNATO AL 17/02/2017 Denominazione Natura giuridica Sede legale Comune Sede Legale Atto Autorizzazione Regionale ASL 201 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA Autorizzazioni nell'ambito del Sistema di emergenza urgenza 118 Associazione 16 Maggio 1982 Associazione Località Pezzetaglie Oricola (AQ) D.P.G.R. n. 366 del 9.07.1997 Confraternita della Misericordia di Balsorano e S. Vincenzo Valle R. Associazione Piazza T. Baldassarre, 1 Balsorano (AQ) DG15/77 del 4 settembre 2003 Confraternita della Misericordia Associazione Via Marconi, 68 Avezzano (AQ) DG15/46 del 9 luglio 2002 Croce Verde "Rugora Giuseppina" Associazione Via Stazione, 1 Civitella Roveto (AQ) DG 15/20 del 28.07.2004 (4) Pubblica Assistenza Croce Verde Pratola Soccorso Associazione Via F. Colella, 27 Pratola Peligna (AQ) DG15/68 del 13 maggio 2003 Pubblica Assistenza Montereale Associazione Via dello Zaffo Montereale (AQ) DG 15/21 del 28.07.2004(5) DG15/36 del 12 dicembre 2006 Pubblica Assistenza e Protezione Civile "Croce Bianca" Associazione Via del Torcituro, 40 L'AQUILA (nell'ambito)DG15/17-10.07.2008. Confraternita della di Misericordia Magliano dei Marsi Associazione Piazza Santa Lucia, 5 Magliano dei Marsi (AQ) DG13/24 del 28 ottobre 2008 Autorizzazioni al di fuori del Sistema di emergenza urgenza 118 Confraternita di Misericordia Associazione Via Torlonia Luco dei Marsi (AQ) DG15/48 del 9 luglio 2002 Fraternità di Misericordia Associazione Piazza S. Maria Celano (AQ) DG15/47 del 9 luglio 2002 AVIS Associazione Via Cavour Trasacco (AQ) DG15/65 del 18.04.2003 Pubblica Assistenza Croce Verde O.N.L.U.S.