Studi Su Leptoglossus Occidentalis Heidemann
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

WO 2017/023486 Al 9 February 2017 (09.02.2017) P O P C T
(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) (19) World Intellectual Property Organization International Bureau (10) International Publication Number (43) International Publication Date WO 2017/023486 Al 9 February 2017 (09.02.2017) P O P C T (51) International Patent Classification: 0552 (US). FENGLER, Kevin; 7250 NW 62nd Ave, P.O. AOlH l/00 (2006.01) C07K 14/195 (2006.01) Box 552, Johnston, IA 5013 1-0552 (US). SCHEPERS, A01H3/00 (2006.01) C12N 15/82 (2006.01) Eric; 7250 NW 62nd Ave, P.O. Box 552, Johnston, IA 5013 1-0552 (US). UDRANSZKY, Ingrid; 7250 NW 62nd (21) International Application Number: Ave, P.O. Box 552, Johnston, IA 5013 1-0552 (US). PCT/US20 16/04 1452 (74) Agent: BAUER, S., Christopher; Pioneer Hi-Bred Inter (22) International Filing Date: national, Inc., 7100 N.W. 62nd Avenue, Johnston, IA 8 July 2016 (08.07.2016) 5013 1-1014 (US). (25) Filing Language: English (81) Designated States (unless otherwise indicated, for every (26) Publication Language: English kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, (30) Priority Data: BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, 62/201,977 6 August 2015 (06.08.2015) US DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, (71) Applicants: PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, INC. [US/US]; PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, INC., 7100 N.W. -

An Invasive Species: Leptoglossus Occidentalis (Heidemann) How Does It Affect Forestry Activities?
Kastamonu Univ., Journal of Forestry Faculty, 2017, 17 (3): 531-542 Research Note IFS 2016, Special Issue Doi:10.17475/kastorman.292220 An invasive species: Leptoglossus occidentalis (Heidemann) how does it affect forestry activities? Salih PARLAK Bursa Technical University, Faculty of Forestry, Bursa, TURKEY [email protected] Received Date: 14.02.2017 Accepted Date: 09.06.2017 Abstract Aim of study: Leptoglossus occidentalis which is first identified by Heidemann at North America in 1910 spread quickly after WW II. Although it was first seen in 1999 in Europe has swept the continent in 10 years. First damage observation in Turkey reported in Kozak Basin of Bergama on cones of stone pine trees which has valuable edible seeds. The seed yield loss started in 2005 and reached to a peak in 2009. In addition to high early age conelet loss, rate of emptiness of cones has sometimes reached to 90 %. The bug causes decrement in seed formation and seed germination ability significantly by causing early stage conelet loss and destroying endosperm parts of mature cones. In respect of forestry activities decrement of seed resources caused due to bug damage will have negative impact on natural regeneration activities in Turkey and probably will end in failure. In this study, it was aimed to determine the severity of damage caused by the collecting of cone samples from the stone pine forests in our country. Area of study: Without making any discrimination either planted or natural or any altitude or any aspect, stone pine cones have been collected from 42 localities which are distributed all around Turkey. -

Arthropods of Elm Fork Preserve
Arthropods of Elm Fork Preserve Arthropods are characterized by having jointed limbs and exoskeletons. They include a diverse assortment of creatures: Insects, spiders, crustaceans (crayfish, crabs, pill bugs), centipedes and millipedes among others. Column Headings Scientific Name: The phenomenal diversity of arthropods, creates numerous difficulties in the determination of species. Positive identification is often achieved only by specialists using obscure monographs to ‘key out’ a species by examining microscopic differences in anatomy. For our purposes in this survey of the fauna, classification at a lower level of resolution still yields valuable information. For instance, knowing that ant lions belong to the Family, Myrmeleontidae, allows us to quickly look them up on the Internet and be confident we are not being fooled by a common name that may also apply to some other, unrelated something. With the Family name firmly in hand, we may explore the natural history of ant lions without needing to know exactly which species we are viewing. In some instances identification is only readily available at an even higher ranking such as Class. Millipedes are in the Class Diplopoda. There are many Orders (O) of millipedes and they are not easily differentiated so this entry is best left at the rank of Class. A great deal of taxonomic reorganization has been occurring lately with advances in DNA analysis pointing out underlying connections and differences that were previously unrealized. For this reason, all other rankings aside from Family, Genus and Species have been omitted from the interior of the tables since many of these ranks are in a state of flux. -

(12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2014/0274885 A1 Cong Et Al
US 20140274885A1 (19) United States (12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2014/0274885 A1 Cong et al. (43) Pub. Date: Sep. 18, 2014 (54) PHI-4 POLYPEPTIDES AND METHODS FOR (52) U.S. Cl. THEIR USE CPC .............. A0IN 43/40 (2013.01); C07K 14/195 (71) Applicant: PIONEER HI-BRED (2013.01) INTERNATIONAL, INC., Johnston, IA USPC ............................ 514/4.5; 530/350; 536/23.7 (US) (57) ABSTRACT (72) Inventors: Ruth Cong, Palo Alto, CA (US); Jingtong Hou, San Pablo, CA (US); Compositions and methods for controlling pests are provided. Zhenglin Hou, Ankeny, IA (US); Phillip The methods involve transforming organisms with a nucleic Patten, Menlo Park, CA (US): Takashi acid sequence encoding an insecticidal protein. In particular, Yamamoto, Dublin, CA (US) the nucleic acid sequences are useful for preparing plants and (73) Assignee: PIONEER HI-BRED microorganisms that possess insecticidal activity. Thus, INTERNATIONAL, INC, Johnston, IA transformed bacteria, plants, plant cells, plant tissues and (US) seeds are provided. Compositions are insecticidal nucleic acids and proteins of bacterial species. The sequences find use (21) Appl. No.: 13/839,702 in the construction of expression vectors for Subsequent trans (22) Filed: Mar 15, 2013 formation into organisms of interest, as probes for the isola tion of other homologous (or partially homologous) genes. Publication Classification The insecticidal proteins find use in controlling, inhibiting (51) Int. Cl. growth or killing lepidopteran, coleopteran, dipteran, fungal, AOIN 43/40 (2006.01) hemipteran, and nematode pest populations and for produc C07K I4/95 (2006.01) ing compositions with insecticidal activity. Patent Application Publication Sep. -

Importance of the Seedbugs Leptoglossus Corculus
REPRINTED FROM Proceedings: Flowering and Seed Development in Trees: A Symposium. USDA For. Serv., South. For. Exp. Stn., New Orleans. IMPORTANCE OF THE SEEDBUGS LEPTOGLOSSUS CORCULUS (SAY) (HEMIPTERA: COREIDAE) AND TETYRA BIPLJNCTATA {H.-S.) (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) AND THEIR CONTROL IN SOUTHERN PINE SEED ORCHARDS Gary L. DeBarr Principal Research Entomologist USDA Forest Service Southeastern Forest Experiment Station FQrestry Sciences ~~boratary Carlton Street ' Athen~, ~eorgia 30602 I • USA SUMMARY Seedbugs are major pests in the insect complex attacking pine seeds in the Southeastern United States. Le.ptoglo44u& co4culu& is the mos~ important species, but Td.yll.O. b-lpunctata. also is very destructive in orchards established to provide genetically improved seeds. This paper reviews 1O years of research on these insects and discusses the prospects for their control usirg an inte grated pest management system in pine seed orchards. INTRODUCTION In pine seed orchards of the Southeastern United States, seedbugs are key species in the insect complex which limits production (Ebel e;t al. 1 1975). Le.ptogl044U4 c.o4eul.u.6 (.Say) is the predominant species, but Te,tyJta b-lpunctata. (H.-S.) also destroys many seeds. In orchards established to provide geneti cally improved pine seeds, these insects abort ovules or conelets and kill see~s, often destroying over half of the annual crop. More than 10 years have passed since the recognition of these insects as seed pests (DeBar~ 1967). This pap~r reviews research and discusses the prospects for an integrated pest mana~ement system aimed at seedbug control in pine seed orchards. Keywor~s: insecticides, integrated control, P-lnu..6. -
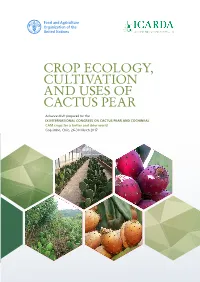
Crop Ecology, Cultivation and Uses of Cactus Pear
CROP ECOLOGY, CULTIVATION AND USES OF CACTUS PEAR Advance draft prepared for the IX INTERNATIONAL CONGRESS ON CACTUS PEAR AND COCHINEAL CAM crops for a hotter and drier world Coquimbo, Chile, 26-30 March 2017 CROP ECOLOGY, CULTIVATION AND USES OF CACTUS PEAR Editorial team Prof. Paolo Inglese, Università degli Studi di Palermo, Italy; General Coordinator Of the Cactusnet Dr. Candelario Mondragon, INIFAP, Mexico Dr. Ali Nefzaoui, ICARDA, Tunisia Prof. Carmen Sáenz, Universidad de Chile, Chile Coordination team Makiko Taguchi, FAO Harinder Makkar, FAO Mounir Louhaichi, ICARDA Editorial support Ruth Duffy Book design and layout Davide Moretti, Art&Design − Rome Published by the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas Rome, 2017 The designations employed and the FAO encourages the use, reproduction and presentation of material in this information dissemination of material in this information product do not imply the expression of any product. Except where otherwise indicated, opinion whatsoever on the part of the Food material may be copied, downloaded and Agriculture Organization of the United and printed for private study, research Nations (FAO), or of the International Center and teaching purposes, or for use in non- for Agricultural Research in the Dry Areas commercial products or services, provided (ICARDA) concerning the legal or development that appropriate acknowledgement of FAO status of any country, territory, city or area as the source and copyright holder is given or of its authorities, or concerning the and that FAO’s endorsement of users’ views, delimitation of its frontiers or boundaries. -

Inventory and Review of Quantitative Models for Spread of Plant Pests for Use in Pest Risk Assessment for the EU Territory1
EFSA supporting publication 2015:EN-795 EXTERNAL SCIENTIFIC REPORT Inventory and review of quantitative models for spread of plant pests for use in pest risk assessment for the EU territory1 NERC Centre for Ecology and Hydrology 2 Maclean Building, Benson Lane, Crowmarsh Gifford, Wallingford, OX10 8BB, UK ABSTRACT This report considers the prospects for increasing the use of quantitative models for plant pest spread and dispersal in EFSA Plant Health risk assessments. The agreed major aims were to provide an overview of current modelling approaches and their strengths and weaknesses for risk assessment, and to develop and test a system for risk assessors to select appropriate models for application. First, we conducted an extensive literature review, based on protocols developed for systematic reviews. The review located 468 models for plant pest spread and dispersal and these were entered into a searchable and secure Electronic Model Inventory database. A cluster analysis on how these models were formulated allowed us to identify eight distinct major modelling strategies that were differentiated by the types of pests they were used for and the ways in which they were parameterised and analysed. These strategies varied in their strengths and weaknesses, meaning that no single approach was the most useful for all elements of risk assessment. Therefore we developed a Decision Support Scheme (DSS) to guide model selection. The DSS identifies the most appropriate strategies by weighing up the goals of risk assessment and constraints imposed by lack of data or expertise. Searching and filtering the Electronic Model Inventory then allows the assessor to locate specific models within those strategies that can be applied. -

Does Access to Opuntia Humifusa Cactus Seeds Affect Egg Production in the Cactus Bug, Narnia Femorata (Hemiptera: Coreidae)?
Does access to Opuntia humifusa cactus seeds affect egg production in the cactus bug, Narnia femorata (Hemiptera: Coreidae)? Anthony Riggio and Christine Miller University of Florida Department of Entomology and Nematology Abstract Animals face challenges in acquiring the resources necessary for their survival and reproduction. Our study considered Narnia femorata, a species of true-bug which feeds on the fruits of the Opuntia humifusa cactus. We sought to determine if N. femorata is feeding on the seeds contained within O. humifusa cactus fruits, information which could help explain environmental and social factors affecting the life histories of true bugs. We compared the egg production of N. femorata breeding pairs provided O. humifusa fruits with the seeds intact with breeding pairs provided O. humifusa cactus fruits where the seeds were physically removed. We found that significantly more eggs were laid in the presence of fruit, as predicted from the results of prior studies showing the importance of proteins and lipids to egg production in insects. Our results suggest that N. femorata feeding on cactus fruit seeds will produce more eggs than those which do not. Therefore we posit that O. cactus fruit seeds are an important food resource for Narnia femorata because the seeds persist within the fruits throughout much of the annual growing season and contain higher concentrations of proteins and lipids relative to other O. cactus tissues. Keywords: Narnia femorata, Opuntia, Cactus, Reproduction Introduction Animals are not always able to acquire the resources necessary to maximize their survival and reproduction (Batzli & Lesieutre 1991). There are food resources present within environments that can enhance the fitness of those animals that selectively feed on them (Batzli & Lesieutre 1991). -

Impact and Ecological Adaptation of Leptoglossus Occidentalis (Hemiptera, Coreidae) on Pinus Pinea
Impact and ecological adaptation of Leptoglossus occidentalis (Hemiptera, Coreidae) on Pinus pinea Ana Cristina Oliveira Farinha Scientific Advisors Supervisor: Ph.D. Manuela Rodrigues Branco Simões Co-supervisor: Ph.D Edmundo Rodrigues de Sousa Co-supervisor: Ph.D. Alain Roques Thesis presented to obtain the Doctor degree in Forestry Engineering and Natural Resources Programa de doutoramento FCT (Sustainable Forests and Products, SUSFOR) 2019 Page 1 of 164 Impact and ecological adaptation of Leptoglossus occidentalis (Hemiptera, Coreidae) on Pinus pinea Ana Cristina Oliveira Farinha Scientific Advisors: Supervisor: Ph.D. Manuela Rodrigues Branco Simões Co-supervisor: Ph.D Edmundo Rodrigues de Sousa Co-supervisor: Ph.D. Alain Roques THESIS PRESENTED TO OBTAIN THE DOCTOR DEGREE IN FORESTRY ENGINEERING AND NATURAL RESOURCES Jury members President: Ph.D Mª Margarida Tomé Full professor Instituto Superior de Agronomia Universidade de Lisboa Ph.D. Andrea BATTISTI Full Professor Università Degli Studi di Padova, Itália Ph.D. António Marques MEXIA Full professor Instituto Superior de Agronomia Universidade de Lisboa Ph.D. Manuela Rodrigues BRANCO Assistant professor with aggregation Instituto Superior de Agronomia Universidade de Lisboa (supervisor) Ph.D. Maria Isabel CARRASQUINHO Assistant researcher Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Funding instituition: Doctoral Program FCT (Sustainable Forests and Products, SUSFOR) Doctoral scholarship ref. PD/BD/52403/2013 2019 Page 2 of 164 À Cátia e à pequena Catarina Somos todas -
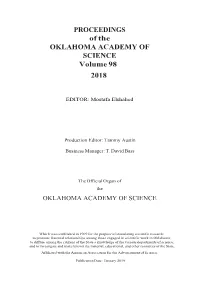
PROCEEDINGS of the OKLAHOMA ACADEMY of SCIENCE Volume 98 2018
PROCEEDINGS of the OKLAHOMA ACADEMY OF SCIENCE Volume 98 2018 EDITOR: Mostafa Elshahed Production Editor: Tammy Austin Business Manager: T. David Bass The Official Organ of the OKLAHOMA ACADEMY OF SCIENCE Which was established in 1909 for the purpose of stimulating scientific research; to promote fraternal relationships among those engaged in scientific work in Oklahoma; to diffuse among the citizens of the State a knowledge of the various departments of science; and to investigate and make known the material, educational, and other resources of the State. Affiliated with the American Association for the Advancement of Science. Publication Date: January 2019 ii POLICIES OF THE PROCEEDINGS The Proceedings of the Oklahoma Academy of Science contains papers on topics of interest to scientists. The goal is to publish clear communications of scientific findings and of matters of general concern for scientists in Oklahoma, and to serve as a creative outlet for other scientific contributions by scientists. ©2018 Oklahoma Academy of Science The Proceedings of the Oklahoma Academy Base and/or other appropriate repository. of Science contains reports that describe the Information necessary for retrieval of the results of original scientific investigation data from the repository will be specified in (including social science). Papers are received a reference in the paper. with the understanding that they have not been published previously or submitted for 4. Manuscripts that report research involving publication elsewhere. The papers should be human subjects or the use of materials of significant scientific quality, intelligible to a from human organs must be supported by broad scientific audience, and should represent a copy of the document authorizing the research conducted in accordance with accepted research and signed by the appropriate procedures and scientific ethics (proper subject official(s) of the institution where the work treatment and honesty). -

Vol. 14, No. 1 Spring 1981 the GREAT LAKES ENTOMOLOGIST Published by the Michigan Entomological Society Volume 14 No
The GREAT LAKES ENTOMOLOGIST Vol. 14, No. 1 Spring 1981 THE GREAT LAKES ENTOMOLOGIST Published by the Michigan Entomological Society Volume 14 No. 1 ISSN 0090-0222 TABLE OF CONTENTS Annotated List of Indiana Scolytidae (Coleoptera) Mark Deyrup .................................................. Seasonal Flight Patterns of Hemiptera in a North Carolina Black Walnut Plantation. 2. Coreoida J. E. McPherson and B. C. Weber .......................................... 11 Seasonal Flight Patterns of Hemiptera in a North Carolina Black Walnut Plantation. 3. Reduvioidea J. E. McPherson and B. C. Weber .......................................... 15 Seasonal Flight Patterns of Hemiptera in a North Carolina Black Walnut Plantation. 4. Cimicoidea J. E. McPherson and B. C. Weber .......................................... 19 Fourlined Plant Bug (Hemiptera: Miridae), A Reappraisal: Life History, Host Plants, and Plant Response to Feeding A. G. Wheeler, Jr. and Gary L. Miller.. ..................................... 23 Hawthorn Lace Bug (Hemiptera: Tingidae), First Record of Injury to Roses, with a Review of Host Plants A. G. Wheeler, Jr. ........................................................ 37 Notes on the Biology of Nersia florens (Homoptera: Fulgoroidea: Dictyopharidae) with Descriptions of Eggs, and First, Second, and Fifth Instars S. W. Wilson and J. E. McPherson.. ...................... Ontogeny of the Tibial Spur in Megamelus davisi (Homoptera: Delphacidae) and its Bearing on Delphacid Classification S. W. Wilson and J. E. McPherson.. ..................... -

The Coreidae of Honduras (Hemiptera: Coreidae)
Biodiversity Data Journal 5: e13067 doi: 10.3897/BDJ.5.e13067 Taxonomic Paper The Coreidae of Honduras (Hemiptera: Coreidae) Carlos A Linares‡‡, Jesus Orozco ‡ Insect Collection, Zamorano University, Zamorano, Honduras Corresponding author: Jesus Orozco ([email protected]) Academic editor: Laurence Livermore Received: 04 Apr 2017 | Accepted: 02 Jun 2017 | Published: 05 Jun 2017 Citation: Linares C, Orozco J (2017) The Coreidae of Honduras (Hemiptera: Coreidae). Biodiversity Data Journal 5: e13067. https://doi.org/10.3897/BDJ.5.e13067 Abstract Background Coreidae bugs are mostly sap-sucking insects feeding on a variety of plants. Despite their abundance and economic importance in Honduras there is little information on the species, their distribution and affected crops. Since knowledge of pest species allows for better management of crops, we aimed to document the diversity of this economically important group. Specimens from four entomological collections in Honduras were studied and an exhaustive search of all available literature was conducted. New information A total of 2,036 insects were examined. The fauna of Honduran coreids is now composed of 68 species. Nineteen species are recorded for the country for the first time and 17 species were found only in literature. Little is known about the biology and economic importance of most of the species. Keywords Taxonomy, diversity, agriculture, pest, Central America. © Linares C, Orozco J. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. 2 Linares C, Orozco J Introduction Bugs of the Coreidae family are primarily phytophagous insects that feed on plants sucking sap from branches, leaves, flowers and fruits.