Giuseppe Giusti
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
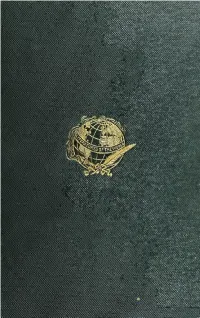
A History of Italian Literature Should Follow and Should Precede Other and Parallel Histories
I. i III 2.3 CORNELL UNIVERSITY LIBRARY C U rar,y Ubrary PQ4038 G°2l"l 8t8a iterature 1lwBiiMiiiiiiiifiiliiii ! 3 1924 oim 030 978 245 Date Due M#£ (£i* The original of this book is in the Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924030978245 Short Histories of the Literatures of the World: IV. Edited by Edmund Gosse Short Histories of the Literatures of the World Edited by EDMUND GOSSE Large Crown 8vOj cloth, 6s. each Volume ANCIENT GREEK LITERATURE By Prof. Gilbert Murray, M.A. FRENCH LITERATURE By Prof. Edward Dowden, D.C.L., LL.D. MODERN ENGLISH LITERATURE By the Editor ITALIAN LITERATURE By Richard Garnett, C.B., LL.D. SPANISH LITERATURE By J. Fitzmaurice-Kelly [Shortly JAPANESE LITERATURE By William George Aston, C.M.G. [Shortly MODERN SCANDINAVIAN LITERATURE By George Brandes SANSKRIT LITERATURE By Prof. A. A. Macdonell. HUNGARIAN LITERATURE By Dr. Zoltan Beothy AMERICAN LITERATURE By Professor Moses Coit Tyler GERMAN LITERATURE By Dr. C. H. Herford LATIN LITERATURE By Dr. A. W. Verrall Other volumes will follow LONDON: WILLIAM HEINEMANN \AU rights reserved] A .History of ITALIAN LITERATURE RICHARD GARNETT, C.B., LL.D. Xon&on WILLIAM HEINEMANN MDCCCXCVIII v y. 1 1- fc V- < V ml' 1 , x.?*a»/? Printed by Ballantyne, Hanson &* Co. At the Ballantyne Press *. # / ' ri PREFACE "I think," says Jowett, writing to John Addington Symonds (August 4, 1890), "that you are happy in having unlocked so much of Italian literature, certainly the greatest in the world after Greek, Latin, English. -

The Unique Cultural & Innnovative Twelfty 1820
Chekhov reading The Seagull to the Moscow Art Theatre Group, Stanislavski, Olga Knipper THE UNIQUE CULTURAL & INNNOVATIVE TWELFTY 1820-1939, by JACQUES CORY 2 TABLE OF CONTENTS No. of Page INSPIRATION 5 INTRODUCTION 6 THE METHODOLOGY OF THE BOOK 8 CULTURE IN EUROPEAN LANGUAGES IN THE “CENTURY”/TWELFTY 1820-1939 14 LITERATURE 16 NOBEL PRIZES IN LITERATURE 16 CORY'S LIST OF BEST AUTHORS IN 1820-1939, WITH COMMENTS AND LISTS OF BOOKS 37 CORY'S LIST OF BEST AUTHORS IN TWELFTY 1820-1939 39 THE 3 MOST SIGNIFICANT LITERATURES – FRENCH, ENGLISH, GERMAN 39 THE 3 MORE SIGNIFICANT LITERATURES – SPANISH, RUSSIAN, ITALIAN 46 THE 10 SIGNIFICANT LITERATURES – PORTUGUESE, BRAZILIAN, DUTCH, CZECH, GREEK, POLISH, SWEDISH, NORWEGIAN, DANISH, FINNISH 50 12 OTHER EUROPEAN LITERATURES – ROMANIAN, TURKISH, HUNGARIAN, SERBIAN, CROATIAN, UKRAINIAN (20 EACH), AND IRISH GAELIC, BULGARIAN, ALBANIAN, ARMENIAN, GEORGIAN, LITHUANIAN (10 EACH) 56 TOTAL OF NOS. OF AUTHORS IN EUROPEAN LANGUAGES BY CLUSTERS 59 JEWISH LANGUAGES LITERATURES 60 LITERATURES IN NON-EUROPEAN LANGUAGES 74 CORY'S LIST OF THE BEST BOOKS IN LITERATURE IN 1860-1899 78 3 SURVEY ON THE MOST/MORE/SIGNIFICANT LITERATURE/ART/MUSIC IN THE ROMANTICISM/REALISM/MODERNISM ERAS 113 ROMANTICISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 113 Analysis of the Results of the Romantic Era 125 REALISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 128 Analysis of the Results of the Realism/Naturalism Era 150 MODERNISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 153 Analysis of the Results of the Modernism Era 168 Analysis of the Results of the Total Period of 1820-1939 -

UCLA Electronic Theses and Dissertations
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title Prima La Musica o Prima La Parola? Textual and Musical Intermedialities in Italian Literature and Film Permalink https://escholarship.org/uc/item/9385t0bs Author Nadir, Erika Marina Publication Date 2017 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Prima La Musica o Prima La Parola? Textual and Musical Intermedialities in Italian Literature and Film A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Italian by Erika Marina Nadir 2017 © Copyright by Erika Marina Nadir 2017 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Prima La Musica o Prima La Parola? Textual and Musical Intermedialities in Italian Literature and Film by Erika Marina Nadir Doctor of Philosophy in Italian University of California, Los Angeles, 2017 Professor Luigi Ballerini, Chair This dissertation is a comparative study of Italian opera, literature, and film, and traces the textual and musical intermedialities among the art forms. Using the analytical prisms of Elio Vittorini’s linguaggio unitario del musicista and Giuseppe Verdi’s notion of verità, I examine the myriad ways that literature, film, and music interact and the effects on the respective arts. Chapter 1 focuses on literature that is written in such a way as to evoke music. I analyze three texts and their musical components: Vittorini’s Italian Resistance novel, Uomini e no; the postmodern novel Passavamo sulla terra leggeri by Sergio Atzeni—a soundscape of text that mimics contemporary opera structure; and Manzoni’s I promessi sposi, which was the inspiration for Giuseppe Verdi’s notion of verità in art. -

Transnational, National, and Local Perspectives on Venice and Venetia Within the “Multinational” Empire
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Nottingham ePrints Laven, David and Parker, Laura (2014) Foreign rule?: transnational, national, and local perspectives on Venice and Venetia within the “multinational” empire. Modern Italy, 19 (1). pp. 5-19. ISSN 1469-9877 Access from the University of Nottingham repository: http://eprints.nottingham.ac.uk/44432/1/Laven%20-%20Foreign%20Rule.pdf Copyright and reuse: The Nottingham ePrints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. This article is made available under the University of Nottingham End User licence and may be reused according to the conditions of the licence. For more details see: http://eprints.nottingham.ac.uk/end_user_agreement.pdf A note on versions: The version presented here may differ from the published version or from the version of record. If you wish to cite this item you are advised to consult the publisher’s version. Please see the repository url above for details on accessing the published version and note that access may require a subscription. For more information, please contact [email protected] David Laven with Laura Parker Foreign Rule? Transnational, national, and local perspectives on Venice and Venetia within the ʻmultinationalʼ empire The so-called seconda dominazione austriaca of Venice and Venetia lasted from 1814 to 1866, punctuated only by the revolutionary parenthesis of 1848–9. This half century of rule from Vienna has traditionally been seen as a period of exploitative and insensitive government backed by heavy- handed policing, restrictive censorship, and ultimately dependent on the presence of regiments of white-coated Croat and Austrian troops. -

Francesco Domenico Guerrazzi Racconti E Scritti Minori
Francesco Domenico Guerrazzi Racconti e scritti minori www.liberliber.it Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di: E-text Editoria, Web design, Multimedia http://www.e-text.it/ QUESTO E-BOOK: TITOLO: Racconti e scritti minori AUTORE: Guerrazzi, Francesco Domenico TRADUTTORE: CURATORE: prefazione di Rosolino Guastalla NOTE: Realizzato in collaborazione con il Project Gutenberg (http://www.gutenberg.net/) tramite Distributed Proofreaders (http://www.pgdp.net/). DIRITTI D'AUTORE: no LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet: http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze/ TRATTO DA: "Racconti e scritti minori" di Francesco Domenico Guerrazzi, collezione: Classici italiani Istituto editoriale italiano, Milano, [s.n.] (probabilmente 1914) CODICE ISBN: informazione non disponibile 1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 26 dicembre 2004 INDICE DI AFFIDABILITA': 1 0: affidabilità bassa 1: affidabilità media 2: affidabilità buona 3: affidabilità ottima ALLA EDIZIONE ELETTRONICA HANNO CONTRIBUITO: Distributed Proofreaders, http://www.pgdp.net/ REVISIONE: Claudio Paganelli, [email protected] Carlo Traverso, [email protected] PUBBLICATO DA: Claudio Paganelli, [email protected] Alberto Barberi, [email protected] Informazioni sul "progetto Manuzio" Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet: http://www.liberliber.it/ Aiuta anche tu il "progetto Manuzio" Se questo "libro elettronico" è stato di tuo gradimento, o se condividi le finalità del "progetto Manuzio", invia una donazione a Liber Liber. Il tuo sostegno ci aiuterà a far crescere ulteriormente la nostra biblioteca. -
Francesco Domenico Guerrazzi Racconti E Scritti Minori
Francesco Domenico Guerrazzi Racconti e scritti minori www.liberliber.it Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di: E-text Editoria, Web design, Multimedia http://www.e-text.it/ QUESTO E-BOOK: TITOLO: Racconti e scritti minori AUTORE: Guerrazzi, Francesco Domenico TRADUTTORE: CURATORE: prefazione di Rosolino Guastalla NOTE: Realizzato in collaborazione con il Project Gutenberg (http://www.gutenberg.net/) tramite Distributed Proofreaders (http://www.pgdp.net/). DIRITTI D'AUTORE: no LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet: http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze/ TRATTO DA: "Racconti e scritti minori" di Francesco Domenico Guerrazzi, collezione: Classici italiani Istituto editoriale italiano, Milano, [s.n.] (probabilmente 1914) CODICE ISBN: informazione non disponibile 1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 26 dicembre 2004 INDICE DI AFFIDABILITA': 1 0: affidabilità bassa 1: affidabilità media 2: affidabilità buona 3: affidabilità ottima ALLA EDIZIONE ELETTRONICA HANNO CONTRIBUITO: Distributed Proofreaders, http://www.pgdp.net/ REVISIONE: Claudio Paganelli, [email protected] Carlo Traverso, [email protected] PUBBLICATO DA: Claudio Paganelli, [email protected] Alberto Barberi, [email protected] Informazioni sul "progetto Manuzio" Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet: http://www.liberliber.it/ Aiuta anche tu il "progetto Manuzio" Se questo "libro elettronico" è stato di tuo gradimento, o se condividi le finalità del "progetto Manuzio", invia una donazione a Liber Liber. -

Rivista Di Studi Italiani 65 Contributi Giovan Battista
RIVISTA DI STUDI ITALIANI CONTRIBUTI GIOVAN BATTISTA NICCOLINI’S LITERARY AND POLITICAL ROLE IN THE RISORGIMENTO PIERO GAROFALO University of New Hampshire Durham, New Hampshire iovan Battista Niccolini was one of the most renowned Italian dramatists of the nineteenth century, but since the early 1900s critical Gand popular interest in his literary production has steadily diminished. His tragedies appealed to the ideals associated with national unification and with the Risorgimento culture because they reiterated the necessity of resisting tyranny in the cause of freedom. Extravagantly praised during his lifetime, Niccolini was buried alongside some of Florence’s most famous citizens in the church of Santa Croce. A funeral monument sculpted by Pio Fedi was added in 1883, to commemorate his literary achievements. The son of Ippolito and Settimia da Filicaja, Giovan Battista was born in Bagni di San Giuliano (today, San Giuliano Terme) near Pisa on 29 October 1782. His father, a nobleman of the Counts of Camugliano, was somewhat of an anglophile so English comprised part of Niccolini’s cultural formation. Ippolito served in the Palazzo Pretorio as a government representative of the Grand Duchy of Tuscany. His mother was also a descendant of a patrician Florentine family. As a child and throughout his life, Giovan Battista was timid and frail, more interested in intellectual activities than physical ones. In 1786, the family moved to Florence where Niccolini frequented the Scolopi School in Florence. He studied under the guidance of Angelo D’Elci (1754-1824) and Giovanni Battista Zannoni (1774-1832). He began to learn Greek in 1796, and quickly developed a passion for classical studies. -

Testi E Studi Di Letteratura Italiana 12
Testi e studi di letteratura italiana 12 La collana “Testi e studi di letteratura italiana” ospita opere che in- teressano il periodo storico compreso fra la metà del Settecento e i giorni nostri. Si articola in due serie, una di “testi” e una di “studi”, contrad- distinte dalla fascia di copertina rispettivamente rossa e azzurra. La sezi- one “testi” è destinata principalmente ad autori minori, a opere mino- ri di autori celebri e a generi semiletterari come raccolte di articoli, diari e carteggi. La sezione “studi” è destinata a monografie, raccolte di saggi, atti di convegni e inventari di archivi e di biblioteche d’autore. La colla- na si rivolge a un pubblico di studiosi e di docenti e studenti universitari. DIREZIONE: Sandro Gentili (Università di Perugia) Isabella Nardi (Università di Perugia) COMITATO SCIENTIFICO: Simona Costa (Università di Roma Tre) Christian Del Vento (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) Enrico Ghidetti (Università di Firenze) François Livi (Université Paris Sorbonne) Gloria Manghetti (Direttore “Vieusseux” di Firenze) Laura Rorato (University of Hull) Luigi Surdich (Università di Genova) Luigi Trenti (Università per stranieri di Siena) Anna Tylusińska-Kowalska (Università di Varsavia) I volumi sono sottoposti a duplice referaggio anonimo. Giuseppe Giusti – Alessandro Manzoni Carteggio e lettere non spedite (1843-1850) A cura di Laura Diafani Morlacchi Editore U.P. Prima edizione: 2016 Impaginazione, redazione e copertina: Jessica Cardaioli ISBN/EAN: 978-88-6074-788-4 Copyright © 2016 by Morlacchi Editore, Perugia. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, com- presa la copia fotostatica, non autorizzata. Finito di stampare nel mese di luglio 2016 presso la tipografia “Digital Print - Service”, Segrate (MI). -

Padre Agostino Gemelli and the Crusade to Rechristianize Italy, 1878–1959: Part One
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2010 Padre Agostino Gemelli and the crusade to rechristianize Italy, 1878–1959: Part one J. Casey Hammond Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the European History Commons, and the History of Religion Commons Recommended Citation Hammond, J. Casey, "Padre Agostino Gemelli and the crusade to rechristianize Italy, 1878–1959: Part one" (2010). Publicly Accessible Penn Dissertations. 3684. https://repository.upenn.edu/edissertations/3684 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/3684 For more information, please contact [email protected]. Padre Agostino Gemelli and the crusade to rechristianize Italy, 1878–1959: Part one Abstract Padre Agostino Gemelli (1878-1959) was an outstanding figure in Catholic culture and a shrewd operator on many levels in Italy, especially during the Fascist period. Yet he remains little examined or understood. Scholars tend to judge him solely in light of the Fascist regime and mark him as the archetypical clerical fascist. Gemelli founded the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan in 1921, the year before Mussolini came to power, in order to form a new leadership class for a future Catholic state. This religiously motivated political goal was intended to supersede the anticlerical Liberal state established by the unifiers of modern Italy in 1860. After Mussolini signed the Lateran Pacts with the Vatican in 1929, Catholicism became the officialeligion r of Italy and Gemelli’s university, under the patronage of Pope Pius XI (1922-1939), became a laboratory for Catholic social policies by means of which the church might bring the Fascist state in line with canon law and papal teachings. -

Travels Through Art
TUSCANY TRAVELS THROUGH ART Searching for brilliance in the footsteps of scientists, important historical figures, poets and musicians tuscany TRAVELS THROUGH ART Searching for brilliance in the footsteps of scientists, important historical figures, poets and musicians The first guide that leads to the discovery of poets, and musicians, scientists and religious figures, politicians and revolutionaries, great historical figures who, over the centuries, have made their home in Tuscany, and who have left an indel- ible mark of their presence in the region, making it famous worldwide. Page after page give visitors on the road an opportunity to discover a different Tuscany through the lives and achievements, the inventions, the words and mu- sic of these geniuses; new routes are revealed across cities and borghi, famous sites and hidden corners. A fresh interpretation of the area for locals too, to find out more about the great people of the past whose names now identify our squares and streets. Tuscany is a region that has always been a source of inspiration to great men and women: through their biographies, the places where they worked and lived, accompanied by a wealth of images, we find, in this travel guide, a new way to perceive the true soul of this extraordinary land that continues, century after century, to attract visitors from across the world. SOME PLACES ALONG THE ITINERARIES ARE MARKED FOR RELEVANCE. ** NOT TO BE MISSED * INTERESTING AND TO AVOID GETTING LOST ALONG THE WAY, EACH SECTION IS WELL MARKED SCIENTISTS HISTORICAL FIGURES -

Giuseppe Verdi
CASA CULTURALE DI SAN MINIATO BASSO WWW. CASACULTURALE – (Sezione Lettura) NOVEMBRE 2013 GIUSEPPE VERDI La vita del grande musicista dai libri di : Gustavo Marchesi e Frank Walker INFANZIA IN UN BORGO CONTADINO Quando i coniugi della famiglia Verdi di Sant’Agata si trasferirono a Busseto per comprare l’esercizio della conduzione di una osteria forse speravano di meglio nel futuro se, dopo otto figli, ne misero in servizio altri due. Carlo, il futuro babbo di Giuseppe Verdi, era il nono, ed ebbe la cura del locale appena fuori della minorità. Questo giovane aveva il carico di sua madre , rimasta vedova, e del decimo nato, il pupillo Marco. 1 Il 10 ottobre 1813 Napoleone, tornato “convalescente” dalla campagna di Russia, emette un editto per reclutare giovani della campagna nei pressi di Parma dicendo loro amabilmente che “Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi, Re d’Italia, in mezzo ai suoi trionfi ha gittato sopra di voi uno sguardo paterno. Sua Maestà ha voluto aprirvi tutte le sorgenti di gloria, di grandezza e di prosperità…. Fra le istituzioni sublimi dell’Impero francese, si distingue quello della Coscrizione; per lei si reclutano senza violenza e senza sforzi le armate”. Francesi ed austriaci si rincorsero per le contrade di Parma scambiandosi a turno il governo dello Stato. Finalmente il gioco fu risolto in favore degli austriaci che ottennero una sistemazione stabile e prepararono il terreno alla venuta dell’augusta sovrana, la ex moglie di Napoleone, Maria Luigia d’Asburgo. Per fortuna Carlo non aveva indossato l’uniforme perché il decreto esonerava dal servizio i coniugati. -

Giuseppe Giusti Poesie
Giuseppe Giusti Poesie www.liberliber.it Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di: E-text Editoria, Web design, Multimedia http://www.e-text.it/ QUESTO E-BOOK: TITOLO: Poesie AUTORE: Giusti, Giuseppe TRADUTTORE: CURATORE: Romussi, Carlo NOTE: Si è mantenuta l'impaginazione originale anche per le note, con indicazione del numero di pagina. Rispetto all'edizione cartacea sono state effettuate le seguenti correzioni: 1) pag 33 testo orig., è scritto "...poesia che che abbia prodotto..." : È stato tolto un "che" 2) pag 73 del testo orig., è scritto "SEQUISPEDALI", è stato sostituito con "SESQUIPEDALI" 3) pag 117 del testo orig., introduzione alla poesia 'La fiducia in Dio': l'avverbio è scritto "mollementente" è stato scritto "mollemente". DIRITTI D'AUTORE: no LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet: http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze/ TRATTO DA: "Poesie" di Giuseppe Giusti, con BIOGRAFIA, COMMENTI E NOTE di Carlo Romussi Società editrice Sonzogno Milano, 1899 CODICE ISBN: mancante 1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 14 gennaio 2003 INDICE DI AFFIDABILITA': 1 0: affidabilità bassa 1: affidabilità media 2: affidabilità buona 3: affidabilità ottima ALLA EDIZIONE ELETTRONICA HANNO CONTRIBUITO: Vittorio Volpi, [email protected] REVISIONE: Franz Rossini, [email protected] PUBBLICATO DA: Claudio Paganelli, [email protected] Stefania Ronci, [email protected] Informazioni sul "progetto Manuzio" Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet: http://www.liberliber.it/ Aiuta anche tu il "progetto Manuzio" Se questo "libro elettronico" è stato di tuo gradimento, o se condividi le finalità del "progetto Manuzio", invia una donazione a Liber Liber.