Strutture Termali Nel Salento Dal Passato Al Presente. Un Caso Di Studio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
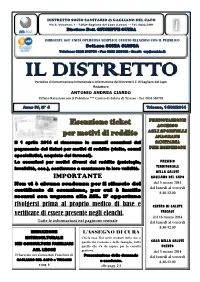
Esenzione Ticket Per Motivi Di Reddito
DISTRETTO SOCIO SANITARIO di GAGLIANO DEL CAPO Via S. Vincenzo, 1 – 73034 Gagliano del Capo (Lecce) ** Tel. 0833.5401 Direttore: Dott. GIUSEPPE GUIDA LECCE DIRIGENTE dell’ UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Dott.ssa SONIA GIAUSA Telefono: 0832 215701 - Fax 0832 226102 - Email: [email protected] IL DISTRETTO Periodico di Comunicazione Istituzionale e Informazione del Distretto S.S. di Gagliano del Capo Redattore ANTONIO ANDREA CIARDO Ufficio Relazioni con il Pubblico *** Centro di Salute di Tricase - Tel. 0833.540701 Anno IV, N° 4 Tricase, 14/03/2014 PRENOTAZIONE Esenzione ticket ACCESSO per motivi di reddito AGLI SPORTELLI ANAGRAFE Il 1 aprile 2014 si rinnovano le annuali esenzioni dal SANITARIA pagamento del ticket per motivi di reddito (visite, esami PER ESENZIONI specialistici, acquisto dei farmaci). Le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologia, PRESIDIO TERRITORIALE invalidità, ecc.), continuano a mantenere la loro validità. DELLA SALUTE IMPORTANTE GAGLIANO DEL CAPO Non vi è alcuna scadenza per il rilascio del dal 3 marzo 2014 certificato di esenzione, per cui è inutile dal lunedì al venerdì 8.30-12.00 recarsi con urgenza alla ASL. E' opportuno rivolgersi prima al proprio medico di base e CENTRO DI SALUTE TRICASE verificare di essere presente negli elenchi. dal 18 marzo 2014 Tutte le informazioni nel paginone centrale dal lunedì al venerdì 8.30-12.00 MEDIAZIONE L’ASSEGNO DI CURA INTERCULTURALE Chi fa cosa. Dal ruolo centrale della Asl, a quello dei Comuni e delle famiglie, tutto CASA DELLA SALUTE NEI CONSULTORI FAMILIARI quello che c’è da sapere per la corretta UGENTO ASL LECCE gestione. -

REGIONE PUGLIA Deliberazione Della Giunta Regionale
REGIONE PUGLIA Deliberazione della Giunta Regionale N.385 del 19/03/2020 del Registro delle Deliberazioni Codice CIFRA:SSS/DEL/2020/00014 OGGETTO: classìfìcazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2020, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. N. 116/2008, sulla base dei campionamenti effettuati dalPARPA Puglia - Territorio di LECCE e provincia. L*anno 2020 addì 19 del mese dì Marzo, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori: Sono presenti: Nessuno assente. Presidente Michele Emiliano V.Presidente Antonio Nunziante Assessore Cosimo Borraccino Assessore Loredana Capone Assessore Giovanni Giannini Assessore Sebastiano Leo Assessore Raffaele Piemontese Assessore Alfonsino Pisicchio Assessore Salvatore Ruggeri Assessore Giovanni F. Stea Assiste alla seduta i! Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. "Igiene Ambientale e screening oncologici" e confermata dal Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dal Dirigente della Sezione PSB, riferisce quanto segue: - con D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 si è data attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, innovando le norme recate dal D.P.R. n. 470/1982 relativo all'applicazione della direttiva 76/160/CEE; tali norme hanno cessato di avere efficacia mettendo in atto quelle innovate e, comunque, a decorrere dal 31/12/2014, come stabilito dall'art. 17 dello stesso D. Lgs. n. 116/2008; - con riferimento all'art. 17, comma 4 del richiamato D. -

Covid-19 in Provincia Di Lecce
COVID-19 IN PROVINCIA DI LECCE REPORT del 30 aprile 2020 Aggiornamento delle ore 10.30 Documento a cura di Fabrizio Quarta con la collaborazione di Angela Metallo Elaborazione dati Carlo Indino ASL Lecce - U.O.C. Epidemiologia e Statistica 1 Tabella 1. Distribuzione per comune dei casi di infezione da COVID-19. N° casi da inizio Attualmente Comune pandemia positivi ALEZIO 1 0 ALLISTE 2 1 ARADEO 3 1 ARNESANO 1 0 CALIMERA 3 1 CAMPI SALENTINA 9 5 CANNOLE 7 5 CARMIANO 14 3 CARPIGNANO SALENTINO 1 0 CASARANO 6 4 CASTRI' DI LECCE 2 0 CASTRIGNANO DEL CAPO 1 1 CAVALLINO 7 3 COLLEPASSO 1 1 COPERTINO 46 11 CORIGLIANO D'OTRANTO 1 1 CURSI 3 3 CUTROFIANO 1 1 GAGLIANO DEL CAPO 3 1 GALATINA 23 10 GALATONE 3 0 GALLIPOLI 14 8 GUAGNANO 7 4 LECCE 71 41 LEQUILE 1 1 LEVERANO 14 4 LIZZANELLO 3 1 MAGLIE 6 2 MARTANO 4 2 MATINO 2 0 MELENDUGNO 7 3 MELISSANO 4 1 MIGGIANO 1 0 MINERVINO DI LECCE 1 1 MONTERONI DI LECCE 20 9 MURO LECCESE 2 1 NARDO' 14 3 NEVIANO 5 5 NOCIGLIA 1 0 NOVOLI 3 1 OTRANTO 2 1 POGGIARDO 6 4 RACALE 2 2 SALICE SALENTINO 3 3 SALVE 1 0 ASL Lecce - U.O.C. Epidemiologia e Statistica 2 N° casi da inizio Attualmente Comune pandemia positivi SAN CESARIO DI LECCE 5 3 SAN DONATO DI LECCE 2 0 SANNICOLA 1 1 SAN PIETRO IN LAMA 3 0 SCORRANO 5 3 SOGLIANO CAVOUR 1 0 SOLETO 3 0 SQUINZANO 6 5 STERNATIA 1 0 SUPERSANO 1 0 SURBO 13 6 TAURISANO 5 2 TREPUZZI 2 0 TRICASE 2 1 UGENTO 1 0 VEGLIE 5 2 VERNOLE 6 5 PORTO CESAREO 1 0 RSA La Fontanella - Ospiti e 89 26 operatori (9) Non attribuito 3 3 TOTALI 487 206 Tabella 2. -

Sustainable Mobility Planning in Puglia (Southern Italy) N Puglia E PRT Manchester, 22 November 2018
Sustainable Mobility Planning in Puglia (Southern Italy) n Puglia e PRT Manchester, 22 November 2018 Raffaele Sforza Mobility Manager of Puglia Region Where is Apulia? Southern Italy MOBILITY IN PUGLIA Road tranport (2014) 14.000.000 trip/day by car of which: 21% within the provincial capitals (2.800.000) 3% among the provincial capitals (400.000) Public Transport (railway and automotive transport - 2013) 314.000 trip/day of which: • Trenitalia (trains and bus) 33.003 • Other regional railway company 42.596 • Automotive trasport (substitutive/integrative of railway services) 40.014 • Extra urban automotive services 104.413 • Urban automotive services 94.382 Total amount 314.408 Regional Guidelines for the drafting of SUMPs approved by the Apulian regional Council on 20/02/2018 CIP INTERREG IIIA ITALIA- ALBANIA 2000-2006 Measure 1.1 Transport – Mobility Management In Bari, Travel Plans for: Assistance and support Training courses for activities - municipal employees of the Mobility Managers in Bari headquarter institution in Mobility and Tirana Management - municipal school in support of the cities of - commercial road Bari and Tirana 5 INTERMODALITY BIKE AND TRAIN A memorandum of understanding was signed in 2007 among Apulia Region and all (5) regional railway companies, aimed to: • The reduction/elimination of infrastructural and organizational barriers; • The immediately elimination of ticket for the bike (quick-win). Since 2007 Apulia is the first region in Italy where the transport of bike on train is free 7 • Velostation: pilot action -

Geophysical and Stratigraphical Research Into Deep Groundwater and Intruding Seawater in the Mediterranean Area (The Salento Peninsula, Italy) S
Geophysical and stratigraphical research into deep groundwater and intruding seawater in the mediterranean area (the Salento Peninsula, Italy) S. Margiotta, S. Negri To cite this version: S. Margiotta, S. Negri. Geophysical and stratigraphical research into deep groundwater and intruding seawater in the mediterranean area (the Salento Peninsula, Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences, Copernicus Publ. / European Geosciences Union, 2005, 5 (1), pp.127-136. hal-00299131 HAL Id: hal-00299131 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00299131 Submitted on 25 Jan 2005 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Natural Hazards and Earth System Sciences (2005) 5: 127–136 SRef-ID: 1684-9981/nhess/2005-5-127 Natural Hazards European Geosciences Union and Earth © 2005 Author(s). This work is licensed System Sciences under a Creative Commons License. Geophysical and stratigraphical research into deep groundwater and intruding seawater in the mediterranean area (the Salento Peninsula, Italy) S. Margiotta and S. Negri Dipartimento di Scienze dei Materiali, Osservatorio di Chimica, Fisica e Geologia Ambientali, Universita` degli Studi di Lecce, Italy Received: 30 July 2004 – Revised: 22 November 2004 – Accepted: 23 December 2004 – Published: 25 January 2005 Part of Special Issue “Natural and anthropogenic hazards in karst areas” Abstract. -

Iscritti - Sospesi Albo Cognome E Nome Indirizzo, Data Iscrizione Cass.Ne Luogo E Data Di Nascita, Codice Fiscale, E-Mail, PEC Numero Telefonico E Fax Albo
AVVOCATI TUTTI - Iscritti - Sospesi albo cognome e nome indirizzo, data iscrizione cass.ne luogo e data di nascita, codice fiscale, e-mail, PEC numero telefonico e fax albo CALO' LEONARDO Via Manzoni 32 D 02-05-2007 San Pietro Vernotico, 17-04-1979 73100 Lecce LE CLA LRD 79D17 I119Q Tel. 0832/49.22.08 349/77.51.287 [email protected] Fax 0832/16.92.815 [email protected] CAPUTO ELENA LUCIA COSTANZA Via Agrigento, 32 15-01-2015 Nardo', 01-05-1980 73014 Gallipoli LE CPT LLC 80E41 F842M 329/98.50.315 [email protected] Fax 0833/ CARETTO ROSALBA Via Edificio Scolastico 79 A 28-01-2009 San Pietro Vernotico, 09-04-1980 73019 Trepuzzi LE CRT RLB 80D49 I119J Tel. 0832/18.30.575 349/64.86.560 [email protected] Fax 0832/76.02.59 [email protected] CHIRIACO' ALBERTO ENRICO Via Collepasso 105 30-06-1999 Gallipoli, 15-07-1967 73020 Cutrofiano LE CHR LRT 67L15 D883F 339/34.32.321 [email protected] V.le De Pietro, 23 [email protected] 73100 Lecce LE Tel. 0832/30.40.46 Fax 0832/30.81.99 CIMINO BARBARA Via Montessori 51 21-06-2017 Gallipoli, 10-04-1982 73057 Taviano LE CMN BBR 82D50 D883W Tel. 0833/91.58.52 347/06.59.444 [email protected] Fax 0833/91.58.52 [email protected] COLAPIETRO DANIELA Corte dei Lubelli 1 21-11-2007 Lecce, 15-09-1975 73100 Lecce LE CLP DNL 75P55 E506Y Tel. 0832/30.10.20 320/09.87.844 [email protected] Fax 0832/57.00.95 [email protected] COLELLA SABRINA Via San Martino, 38 30-01-2019 Gagliano Del Capo, 28-09-1980 73040 Morciano Di Leuca LE CLL SRN 80P68 D851D Tel. -

AVVOCATI ORDINARI - Iscritti Albo Cognome E Nome Indirizzo, Data Iscrizione Cass.Ne Luogo E Data Di Nascita, Codice Fiscale, E-Mail, PEC Numero Telefonico E Fax Albo
AVVOCATI ORDINARI - Iscritti albo cognome e nome indirizzo, data iscrizione cass.ne luogo e data di nascita, codice fiscale, e-mail, PEC numero telefonico e fax albo ABATE MARIA CHIARA Via Lago di Bolsena, 18 15-01-2015 Galatina, 03-05-1983 73013 Galatina LE BTA MCH 83E43 D862P Tel. 393/31.46.896 393/31.46.896 [email protected] Fax 0833/ [email protected] C ABATE PASQUALINA C.Da Crocefisso-case Sparse 24-06-1983 Gallipoli, 06-02-1954 73014 Gallipoli LE BTA PQL 54B46 D883V Tel. 0833/26.66.91 338/19.46.668 [email protected] Via G.A.Ferrari,3 [email protected] 73100 Lecce LE Tel. 0832/24.15.86 0832/24.15.87 Fax 0832/24.15.86 C ABATE SALVATORE Via Roma 113 19-10-1994 Maglie, 26-07-1967 73024 Maglie LE BTA SVT 67L26 E815R Tel. 0836/42.79.72 338/63.49.067 [email protected] Fax 0836/42.79.72 [email protected] Via Liguria,26 73100 Lecce LE Tel. 0832/18.81.74 ABATI ENRICO Via Luigi Ferilli 59 11-10-2017 Gagliano Del Capo, 15-08-1980 73034 Gagliano Del Capo LE BTA NRC 80M15 D851R Tel. 0833/54.86.66 328/39.51.240 [email protected] [email protected] ABATI FRANCESCO SAVERIO Via Crocefisso 19 17-01-2018 Galatina, 28-04-1980 73020 San Cassiano LE BTA FNC 80D28 D862X Tel. 0836/99.20.78 338/96.84.923 [email protected] ABATI MARIANNA Via del Bosco 56 21-12-2005 Poggiardo, 01-08-1973 73040 Collepasso LE BTA MNN 73M41 G751F Tel. -
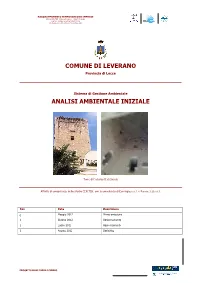
AAI Format Definitivo Leverano
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE STUDIO CEN.TER - ECO-LOGICA S. R.L. – PARSEC 3.26 SRL C/O ING . COSIMO SALVATORE MONTEFUSCO VIA GARIBALDI 2, 73015 SALICE SALENTINO (LE) COMUNE DI LEVERANO Provincia di Lecce ______________________________________________________ Sistema di Gestione Ambientale ANALISI AMBIENTALE INIZIALE Torre di Federico II di Svevia Attività di competenza dello Studio CEN.TER. con la consulenza di Eco-logica s.r.l. e Parsec 3.26 s.r.l. Rev. Data Descrizione 0 Maggio 2012 Prima emissione 1 Giugno 2012 Aggiornamento 2 Luglio 2012 Aggiornamento 3 Agosto 2012 Definitivo PROGETTO EMAS TERRA D’ARNEO COMUNE DI LEVERANO | SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ANALISI AMBIENTALE I NIZIALE Indice PREMESSA .............................................................................................................................................. 4 1. LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE NELLE ORGANIZZAZIONI COMUNALI .......................................... 5 2. METODOLOGIA ADOTTATA ........................................................................................................... 7 2.1. Fasi e strumenti di attuazione dell’intervento ............................................................................ 7 2.2. Gruppo che ha effettuato l’analisi ............................................................................................. 7 3. PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO ................................................................................................ 9 3.1. Inquadramento geografico ...................................................................................................... -

ASSETTO TERRITORIALE/Infrastrutturale 1:100.000 0 1 2 4 6 8 10 Km
PROVINCIA DI LECCE Presidente Antonio Maria GABELLONE SETTORE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE arch. Massimo EVANGELISTA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Fernando MOSCHETTINI VARIANTE GENERALE DI ADEGUAMENTO E DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI LECCE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI KARRER + 5 prof. arch. Francesco KARRER, ing. Claudio CONVERSANO, prof. arch. Antonio Alberto CLEMENTE, arch. Massimo PADRONE, arch. Elisa CONVERSANO, ing. Lorenzo CONVERSANO 4510000 SCHEMA DI PIANO - LUGLIO 2018 ASSETTO TERRITORIALE/infrastrutturale 1:100.000 0 1 2 4 6 8 10 km SISTEMI INFRASTRUTTURALI ADRIATICO (livello regionale/nazionale) Linea BOLOGNA-LECCE. Velocizzazione tratta Brindisi-Lecce Stazione di Lecce secondo fronte e potenziamento attestamento FSE Lecce - Terminal intermodale passeggeri ferro-gomma BRADANICO-SALENTINO (livello regionale) Linea Francavilla Fontana. Raddoppio selettivo tra Lecce e San Pancrazio 4500000 Linea Martina Franca-Lecce, elettrificazione tratto Manduria Lecce (DL 133/2014) BRINDISI SR8 - Realizzazione del tracciato in variante (nuova sede) tra via della Cancelleria/Lecce e la fraz. Merine, con sezione stradale tipo C1 SR8 - Adeguamento in sede e messa in sicurezza, tra tangenziale Est di Lecce e Vernole con sezione stradale tipo III (CNR 78/1980) SR8 - Realizzazione del tracciato in variante (nuova sede) tra Vernole e Melendugno, con sezione stradale tipo III (CNR 78/1980) SERRE (livello provinciale) Linea Gallipoli-Nardò-Novoli-Lecce. Bretella Monteroni-Ecotekne Lecce Linea Lecce-Gagliano del Capo. Raddoppio selettivo tra Lecce e Maglie Linea Lecce-Maglie, elettrificazione (DL 133/2014) Linea Maglie-Otranto e linea Maglie Gagliano del Capo, elettrificazione (DL 133/2014) Maglie stazione - Terminal intermodale passeggeri ferro-gomma MESAGNE SAN PIETRO VERNOTICO Metropolitana di superficie/Anello di Lecce. -

Candidati Per L'elezione Diretta Del Presidente Della Giunta Regionale
COMUNE DI GALATINA - c_d862 - 0032901 - Ingresso - 11/09/2020 - 17:03 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020 CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI LECCE CANDIDATI PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LISTE CIRCOSCRIZIONALI COLLEGATE PER L’ELEZIONE DI N. 5 CONSIGLIERI REGIONALI (Artt. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni) CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE 1. BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO 2. EMILIANO MICHELE 3. LARICCHIA ANTONELLA 4. FITTO RAFFAELE 5. CESARIA NICOLA 6. D’AGOSTO ANDREA 7. CONCA MARIO 8. SCALFAROTTO IVAN detto PIERFRANCO Bari 23-07-1959 Bari 01-05-1986 Maglie 28-08-1969 Milano 02-07-1959 Salerno 03-09-1964 Esslingen (Germania) 03-05-1971 Pescara 16-08-1965 San Lorenzo del Vallo 18-01-1955 LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE -

Ambito Territoriale Sociale Lecce
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE LECCE ARNESANO CAVALLINO LEQUILE LIZZANE MONTERONI DI SAN CESARIO SAN SAN PIETRO IN SURBO (capofila) LLO LECCE DI LECCE DONATO DI LAMA LECCE CAPITOLATO SPECIALE GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MePA (R.D.O.) CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE (SPECIALISTICA) IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (A.S. 2018/2019 E A.S. 2019/2020), AI SENSI DELL’ART. 92 DEL REG. REG. PUGLIA N. 4/2007”. PIANO DI ZONA 2018/2020 – CIG: 7693031A01. Articolo 1 Oggetto dell’appalto Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto del servizio per l’Integrazione Scolastica e Sociale (specialistica), ai sensi dell’art. 92 R.R. Puglia n. 04/2007, in favore di alunni diversamente abili residenti nell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce. Il servizio di integrazione scolastica è finalizzato a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie. Il servizio è realizzato in stretto raccordo con l’equipe della ASL, la scuola e la famiglia, sulla base del PEI attraverso il quale viene elaboratala proposta educativa, da realizzare attraverso l’intervento di tutte le risorse professionali e materiali, e tenuto conto delle specifiche esigenze di ciascun alunno. Articolo 2 Ammontare dell’appalto L’ammontare dell’appalto del servizio, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, è pari ad € € 179.849,16 (euro centosettantanovemilaottocentoquarantanove/16) oltre IVA come per legge. In caso di rinnovo contrattuale (eventuale) per l’A.S. 2019/2020 l’ammontare dell’appalto del servizio, ai sensi dell’art. -

Historic Records and GIS Applications for Flood Risk Analysis in the Salento
Natural Hazards and Earth System Sciences, 5, 833–844, 2005 SRef-ID: 1684-9981/nhess/2005-5-833 Natural Hazards European Geosciences Union and Earth © 2005 Author(s). This work is licensed System Sciences under a Creative Commons License. Historic records and GIS applications for flood risk analysis in the Salento peninsula (southern Italy) F. Forte1, L. Pennetta1, and R. O. Strobl2 1Sezione di Geografia fisica e Geomorfologia – Dipartimento di Geologia e Geofisica, Universita` degli Studi di Bari, via E. Orabona 4, 70125 Bari, Italy 2ITC – International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation, Hengelosestraat 99, 7514 AE Enschede, The Netherlands Received: 17 November 2004 – Revised: 13 October 2005 – Accepted: 19 October 2005 – Published: 2 November 2005 Abstract. The occurrence of calamitous meteoric events rep- ing and emergency states to the population and economic ac- resents a current problem of the Salento peninsula (Southern tivity. Italy). In fact, flash floods, generated by very intense rainfall, occur not only in autumn and winter, but at the end of sum- 1.2 Geological and geomorphological settings mer as well. These calamities are amplified by peculiar geo- logical and geomorphological characteristics of Salento and The Salento peninsula, the southeast portion of the Apulia by the pollution of sinkholes. Floodings affect often large region (southern Italy), covers 7000 km2 of area and stretches areas, especially in the impermeable lowering zones. These over 150 km between the Ionian and Adriatic seas (Fig. 1). events cause warnings and emergency states, involving peo- The peninsula includes two extreme geographical points: the ple as well as socio-economic goods.