Progetto Esecutivo Linea Ferroviaria Bari-Taranto
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Madonna Col Bambino E Melagrana
Progetto: C.R.S.E.C. BA/8 Via Perrese, 91/C- 70032 Bitonro Te!. - Fax 080/3743714 Coordinamento editoriale: Anna Galliani - Responsabile CRSEC BA/8 Gruppo Operativo BA/8 - Bitonro Organizzazione e segreteria a cura del gruppo operativo CRSEC BA/8 - Bitonto: l) Galliani Anna 2) Piacente Lillana 3) Magro Maria Carmela 4) Vitucci Maria 5) Fallacara Cecilia 6) Macchia Michele Consulenza, ricerca storica e testi: Luisa Palmisano Fotografie: Luisa Palmisano Consulenza Fotografica: Giuseppe Pavone Elaborazione Grafica e Stampa: Tipolito Vitetum - Bitetto Anno 2002 © sui testi e sulle fowgrafìe: Luisa Palmisano Diritti riservati alla REGIONE PUGLIA Ogni riproduzione totale o parziale è assolutamente vietata. Si ringrazia: don Francesco Acquafredda, parroco della parrocchia "S. Domenico" - Bitonto; I'Archeodub d'Italia- Sedi di Bitetto e Palo del Colle; la confraternita Maria SS.ma Annunziata e la Pia Associazione S. Antonio- Bitetto; la confraternita Maria SS.ma di Monteverde- Grumo Appula; l'ing. Savino Pellecchia per aver consentito l'accesso al suo archivio privato; il dott. Sebastiano Turchiano per la preziosa collaborazione. PRESENTAZIONE La realizzazione del presente lavoro testimonia come - ancora una volta - il lavoro editoriale a cura della Regione Puglia C.R.S.E.C. BN8 di Bitonto sia rivolto non solo alla divulgazione della storia e dei costumi locali cosl come astrattamente descritti nella maggior parte dei manuali stori co-artistici presenti sul mercato, ma anche e soprattutto alla valorizzazione e al recupero di luoghi e tradizioni degni di memoria. La testimonianza più preziosa e concreta della bontà dell'attività svolta è proprio in questa pubblicazione relativa ad una proposta di itinerario turistico-culturale dal titolo "Lungo la Strada dell'Olio: Madonne Pellegrini Cavalieri e Mercanti in Santa Maria la Veterana a Bitetto e . -

Orario Da Bari in Vigore Dal 1° Agosto 2016
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO ORARIO DA BARI IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 2016 segni convenzionali (15) (15) S - (1) (2) S - (3) S (15) S A - (15) S - (4) S - (4) (5) S-A-(5) S n. Corsa 501 201 101 505 203 509 105 513 511 205 515 253 563 517 519 207 209 521 211 521 bis 525 209 ante 151 151 bis 271 529 213 567 V. Masaniello (A.d'Aosta) V. Toscanini V. Caldarola (Polivalente) V. Turati (Mater Dei) 6.05 11.15 11.30 11.50 12.15 12.25 12.25 12.55 V. della Resistenza (FAMILA) 5.55 6.08 6.05 6.45 7.00 7.05 8.05 8.50 9.00 9.50 11.00 11.19 11.34 11.54 12.19 12.20 12.29 12.29 12.30 12.59 13.00 13.00 V. Amendola V. Peucetia 6.52 7.12 8.15 9.10 11.10 11.44 12.29 12.40 Lung. Di Crollalanza BARI 6.55 7.15 8.20 9.15 11.15 11.49 12.34 12.45 V. Brigata Regina - Via Crispi 7.04 7.24 8.31 9.26 11.26 12.00 12.45 12.56 V. Capruzzi 5.59 6.12 6.09 7.05 Policlinico 6.02 6.15 6.12 7.08 V. Giovanni XXIII ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ V. Camillo Rosalba 6.06 6.19 6.16 7.13 9.02 10.02 11.31 12.06 12.32 12.41 12.41 13.11 13.12 13.12 Villaggio 7.09 7.29 8.37 9.32 11.32 12.06 12.49 13.02 SS 96 - H. -
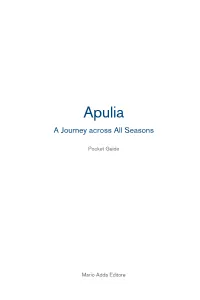
Apulia a Journey Across All Seasons
Apulia A Journey across All Seasons Pocket Guide Mario Adda Editore Regione Puglia AreA Politiche Per lA Promozione del territorio, dei sAPeri e dei tAlenti Servizio Turismo – Corso Sonnino, 177 – cap 70121 Bari Tel. +39 080.5404765 – Fax +39 080.5404721 e-mail: [email protected] www.viaggiareinpuglia.it Text: Stefania Mola Translation: Christina Jenkner Photographs: Nicola Amato and Sergio Leonardi Drawings: Saverio Romito Layout: Vincenzo Valerio ISBN 9788880829362 © Copyright 2011 Mario Adda Editore via Tanzi, 59 - Bari Tel. e fax +39 080 5539502 www.addaeditore.it [email protected] Contents A Journey across All Seasons ....................................................pag. 7 A History ............................................................................................ 9 Buried Treasures ....................................................................................... 11 Taranto’s Treasure ........................................................................ 12 Egnazia ....................................................................................... 12 The Bronzes of Brindisi ............................................................... 13 The Vases of Ruvo ....................................................................... 13 Between Legend and Reality on the Hill of Cannae ....................... 14 Ostuni – Pre-Classical Civilizations ............................................... 14 Caves and Prayers ....................................................................... -

Disponibilita' Ii Grado Sostegno Supplenze 20-21
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari PEC : [email protected] - PEO: [email protected] DISPONIBILITA' SUPPLENZE POSTO DI SOSTEGNO II GRADO PER L'A.S. CODICE 2020/21 DENOMINAZIONE COMUNE MECCANOGRAFICO CATTEDRE POSTI TOTALI CH DH DOMICILIARI BAIS026004 IISS CHIARULLI COLAMONICO ACQUAVIVA DELLE FONTI 12 1/4 BAIS033007 I.I.S.S. R. LUXEMBURG ACQUAVIVA DELLE FONTI 26 1 4 BAPM05000B I.M. DON MILANI ACQUAVIVA DELLE FONTI 8 1/2 BAIS004007 IISS DE NORA LORUSSO ALTAMURA 12 BATL07000T I.T.G. "P. L. NERVI" ALTAMURA ALTAMURA 2 BAPC030002 LICEO CLASSICO CAGNAZZI ALTAMURA 2 BAPS200003 LICEO SCIENTIFICO FEDERICO II ALTAMURA 0 BATD02000A ITC F.M. GENCO ALTAMURA 0 1/2 BAIS04300T IPSC R. LOTTI ANDRIA 15 3/4 BAIS04400N IPSS COLASANTO ANDRIA 37 3/4 BAIS05600X IM - ITES CARAFA ANDRIA 3 2 BAPC04000L L.C. TROYA ANDRIA 4 1/2 BAPS080006 L.S. NUZZI ANDRIA 1 1 BATF060003 ITIS JANNUZZI ANDRIA 7 3/4 BATH040009 IISS I EUCLIDE BARI 0 1/4 BARH11000E IISS MAJORANA BARI 24 1/4 BAIS047005 IISS DE NITTIS PASCALI BARI 23 1/2 BAIS04900R IISS SAVOIA CALAMANDREI BARI 20 BAIS05900B IISS MARCO POLO BARI 1 1/2 BAIS06100B L. S. G. CESARE BARI 2 BAIS062007 IISS D. ROMANAZZI BARI 0 BAIS063003 IISS G. MARCONI HACK BARI 7 BATF230001 ITT PANETTI / PITAGORA BARI 6 BAPC13000V LICEO CLASSICO O. FLACCO BARI 0 BAPC150004 LICEO CLASSICO SOCRATE BARI 0 BAPM010001 LICEI G.BIANCHI DOTTULA BARI 2 BAPS02000E LICEI annessi al Convitto D. CIRILLO BARI 3 1/2 BAPS05000A L.S. -

Acquaviva Delle Fonti Via Privata T. Francavilla, 4 70021 Acquaviva Delle Fonti Ba 0805767366 Adelfia Piazza Galtieri, 41-43
BARI CENTRI ELABORAZIONE ACQUAVIVA DELLE FONTI VIA PRIVATA T. FRANCAVILLA, 4 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA 0805767366 ADELFIA PIAZZA GALTIERI, 41-43 70010 ADELFIA BA 0805767392 ALBEROBELLO PIAZZA ROMA, 16/A 70011 ALBEROBELLO BA 0804322743 ALTAMURA VIA M. CONTINISIO, 9 70022 ALTAMURA BA 0805767363 BARI CARBONARA VIA P. VERRI, 5-5/A 70131 BARI BA 0805767356 BARI POGGIOFRANCO VIA V. DI CAGNO, 32 70124 BARI BA 0805648532 BARI JAPIGIA VIA NATALE LOIACONO, 20/B 70126 BARI BA 0805767533 BARI LIBERTA' VIA E. FIERAMOSCA, 75 70123 BARI BA 0805794296 BARI MADONNELLA VIA VOLPE, 4 70121 BARI BA 0805767695 BARI SAN PAOLO VIA LOMBARDIA, 43-47 70132 BARI BA 0805767352 BARI SANTA RITA VIA R. DI CILLO, 6/E 70131 BARI BA 0805657446 BARI S. SPIRITO VIA NAPOLI, 21/F 70127 BARI BA 0805767357 BITETTO VIA VESCOVADO, 9 70020 BITETTO BA 0805767384 BITONTO VIA N. FORNELLI, 43 70032 BITONTO BA 0805767365 BITRITTO LARGO ODEGITRIA, 9-10 70020 BITRITTO BA 0805767382 CAPURSO VIA ROMA, 33 70010 CAPURSO BA 0805767386 CASAMASSIMA VIA DANTE, 14 70010 CASAMASSIMA BA 0805767372 CASSANO DELLE MURGE VIA DEI MILLE, 7-9 70020 CASSANO DELLE MURGE BA 0805767367 CASTELLANA GROTTE VIA F. CORRIDONI, 15 70013 CASTELLANA GROTTE BA 0805767394 CELLAMARE CORSO ROMA, 45 70010 CELLAMARE BA 0805767393 CONVERSANO VIA G. MAZZINI, 30 70014 CONVERSANO BA 0805767383 CORATO VIA CANOVA, 6 70033 CORATO BA 0805767361 GIOIA DEL COLLE VIA DANTE ALIGHIERI, 30-32 70023 GIOIA DEL COLLE BA 0805767370 GIOVINAZZO VIA G. VERNICE, 35 70054 GIOVINAZZO BA 0805767350 GRAVINA IN PUGLIA VIA MATTEOTTI, 29 70024 GRAVINA IN PUGLIA BA 0805767362 GRUMO APPULA VIA CAPOSTRADA, 15 70025 GRUMO APPULA BA 0805767374 LOCOROTONDO VIA ABRUZZO, 4/6 70010 LOCOROTONDO BA 0805767387 MODUGNO VICO ALBEROTANZA, 8 70026 MODUGNO BA 0805767368 MOLA DI BARI VIA LUNGARO PORTO, 8 70042 MOLA DI BARI BA 0805767378 MOLFETTA VIA ORSINI, 5 70056 MOLFETTA BA 0805767354 MONOPOLI VIA VITT. -

[email protected] IL RESPONSABILE
PUGLIA CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI-BITETTO Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO con riferimento all’attività del Centro Federale Territoriale di Bari-Bitetto (BA) comunica l’elenco dei convocati per il giorno LUNEDI 13 GENNAIO 2020, presso il Campo Sportivo Comunale “A. Antonucci” S.P. 90 – Bitetto - BARI - I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l’attività agonistica (per chi non l’avesse consegnato), liberatoria minorenne compilata, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza. Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo: Maria DIDONNA Cell.: 3400567740 e-mail: [email protected] STAFF Responsabile Organizzativo C.F.T.: DIDONNA Maria Responsabile Tecnico C.F.T.: TAVARILLI Vincenzo Istruttore Under 15 F: TOMASICCHIO Nicola Istruttore Under 14 M: LANAVE Andrea Istruttore Under 13 M: PONTRELLI Gaetano Preparatore dei portieri: RAGUSO Giuseppe Preparatore Atletico: AVITTO Nicola Collaboratore Tecnico: BALDASSARRE Nicola Medici: ORTOLANO Vito e AMENDOLA Ferdinando Fisioterapista: VESPASIANI Marco Psicologo: GIANCASPRO Maria Luisa Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti. IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO REGIONALE Maurizio ORSINI IL -

VADEMECUM-VIAGGIATORE.Pdf
in collaborazione con Autolinee e Autoservizi COMUNE DI BITONTO “VVVVVVVVV V V V V” Mappe e Orari delle Autolinee Urbane ed Extraurbane Edizione 1/2014 Bitonto, Aprile 2014 Gentile utente, nelle tue mani hai un agile strumento per cono- scere percorsi, orari, fermate delle tratte urbane e extraurbane che attraversano la nostra città. Se usi i mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro, i luo- ghi di studio o per altra ragione, potrai trovare in questo opu- scoletto informazioni utili per spostarti sul territorio: le mappe per localizzare con facilità i luoghi; le biglietterie dove acquista- re biglietti e abbonamenti; i contatti delle aziende di trasporto per ulteriori informazioni. Stiamo perseguendo l’obiettivo di rendere il nostro centro ur- bano e le frazioni più vivibili, più sicure e più salubri, avviando azioni di mobilità sostenibile: ciò è possibile impegnandosi a usare sempre meno le auto private e incrementare sempre più l’uso dei mezzi pubblici, a beneficio delle tasche, della salute e dell’ambiente. Andare verso una mobilità alternativa è un punto di non ritorno per il benessere della nostra comunità. È la sfida da affrontare oggi e nei prossimi anni. Ti ringraziamo per il tuo prezioso contributo al cambiamento e ti chiediamo di segnalarci eventuali disagi. Rosa Calò Domenico Incantalupo Coordinamento Tecnico: Assessore Mobilità Sostenibile Assessore Ambiente Ten. Gaetano Paciullo (Settore Polizia Locale ) Michele Abbaticchio Progetto grafico e Impaginazione: Sindaco Dott. Arch. Serena Schiraldi Indice delle Autolinee -

Bari - Taranto + 12613 12613 12615 12615 765 1515 12611 12611 22405 22405 22415 22415 1513 12617 1 Si Effettua Il 21/12 E Il 22/12
L L L L A A L L L L L L A L A Fermata a: Via Benagiano Bari - Taranto + 12613 12613 12615 12615 765 1515 12611 12611 22405 22405 22415 22415 1513 12617 1 Si effettua il 21/12 e il 22/12. Sospeso il fj| fj| fj| fj| bcm bcm fj| fj| fj| fj| fj| fj| bcm fj| 22/12. 1 2 1 2 | | 1 2 5 6 1 2 | 1 2 Si effettua dal 23/12. Sospeso nei festivi 3 4 7 dal 25/12. Km Provenienza . Milano Milano . Milano . 3 Sospeso dal lunedì al venerdì dal 8/1 al 0 Bari Centrale 05.30 05.30 06.25 06.25 06.41 06.49 07.20 07.20 08.15 08.15 08.40 08.40 08.44 09.50 10/4 nonché il 29/12. 5 Villaggio Lav. | · | · | | | · | · | · | | 4 Si effettua dal lunedì al venerdì dal 8/1 al 10 Modugno (new) 05.42 · 06.37 · | | 07.32 · 08.27 · 08.52 · | 10.02 10/4. 15 Bitetto-Palo del Colle 05.46 05.46 06.41 06.41 | | 07.36 07.37 08.31 08.31 08.56 08.58 | 10.06 5 Si effettua il 22/12. 22 Grumo Appula 05.51 05.51 06.46 06.46 | | 07.41 07.41 08.36 08.36 09.01 09.03 | 10.11 6 Si effettua nei festivi dal 25/12. 41 Acquaviva delle Fonti 06.02 06.02 06.57 06.57 | | 07.52 07.52 08.47 08.47 09.12 09.14 | 10.22 7 Si effettua il 29/12. -

Presentazione Aziendale
PRESENTAZIONE AZIENDALE La KEYS CONTRACT è nata dall’idea di costituire una struttura snella, ma ad alta professionalità, dotata dei più moderni strumenti operativi, supportata da tecnici e maestranze di provata specializzazione che consentisse di proporre al Cliente il meglio dell’esecuzione con un costo competitivo. Il campo d'azione è stato scelto, per esperienza specifica, nell'ambito delle costruzioni e delle ristrutturazioni civili ed industriali con risultati che hanno confermato il favore del mercato. Le referenze sui lavori eseguiti costituiscono il nostro punto di forza, avendo lasciato Clienti soddisfatti e nessun contenzioso. La KEYS, da cui nasce la nostra azienda, è presente sul mercato dal 2010 fornendo al proprio Committente una struttura unica per i suoi problemi di ristrutturazione e costruzione con la soluzione moderna del "chiavi in mano". Con tali premesse riteniamo di offrire professionalità, soluzioni tecniche innovative, economicità e rapidità di esecuzione. Affidare la costruzione ad una sola struttura specializzata come la nostra consente di ottimizzare il rapporto costi-benefici, oltre che a dialogare con un solo interlocutore, responsabile di ogni fase dell'intervento. Siamo noi a coordinare vari specialisti che fanno parte del nostro personale diretto o indiretto, quali elettricisti, idraulici, falegnami, serramentisti, etc… Dialogare con la KEYS CONTRACT consente inoltre al Cliente di avere al fianco una Società in grado di supportarlo in tutto quello che è oggi la burocrazia nel settore edile, estremamente pesante per le svariate autorizzazioni e permessi che si devono acquisire oltre a qualità e sicurezza. Con noi i tempi di fornitura e di esecuzione, sono ridotti, non solo nella realizzazione, ma anche nella collaborazione agli aspetti tecnico-burocratico. -

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ AMICI DEL TEATRO” Via Vittorio Veneto, 9 – 70020 Bitetto (BA) – Tel
ASSOCIAZIONE CULTURALE “ AMICI DEL TEATRO” Via Vittorio Veneto, 9 – 70020 Bitetto (BA) – Tel. 3497298555 _____________________________________________________ La giuria del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa “ Città di Bitetto – XX^ edizione 2013 HA COSI’ DELIBERATO: SEZ. A: POESIA SINGOLA INEDITA IN LINGUA ITALIANA 1° Premio : a Annunziata Lionetti, di Bitetto (BA), per la lirica “ L’Attimo”. 2° Premio: a Anna Perrella, di Napoli, per l’opera: “ Quell’immenso esistere che ho di te”. 3° Premio : a Rosa Spera, di Barletta (BT), per la poesia: “ Dedica”. 3° Premio ex aequo: a Liliana Buongiorno, di Castellana Grotte (BA), per: “Il gelsomino”. PREMIO SCUOLA SEZ. A : Scuola secondaria di 1° grado: “ G. Modugno” di Bitetto (BA), a: Ilenia Lepenne e Dominga Fazio, 3^ F, per le liriche: “ Così inutile, così vero” e “ Io uomo” – Rossano Michele, 2^ C, per l’opera: “ Libero” – Percoco Giuseppe, 2^ D, per l’opera: “ Maggio”- Lanzillotta Ilaria, 2^ C, per la poesia: “ Io, tu…noi” – Cristiana Giannini, classe 2^ E, per la poesia: “ L’adolescenza” – Angela De Palo, 2^ E, per la lirica: “ Niente è per sempre” – Margherita Corriero, 1^ A, per la lirica: “ Solo un ricordo” – Laneve Diletta, 1^ A, per l’opera : “ La scuola”. Liceo Classico “ Orazio Flacco” – BARI: Premio Scuola a: Girone Ilaria, di Palo del Colle (BA), per l’opera: “ La dannata egemonia del potere”. MENZIONI D’ONORE SEZ: A: POESIA SINGOLA IN LINGUA ITALIANA CONFERITE A: Scarangella Simona, di Bari, per: “ Senza titolo”. Corsisti Laboratorio di Scrittura Creativa U.T.E. – Bitetto, per l’opera: “ Il sogno del poeta”. Rosanna Gabellone, di Putignano (BA), per la lirica: “ Soffi di vita”. -

A Perspective for Best Governance of the Bari Canyon Deep-Sea Ecosystems
water Article A Perspective for Best Governance of the Bari Canyon Deep-Sea Ecosystems Lorenzo Angeletti 1,* , Gianfranco D’Onghia 2,3, Maria del Mar Otero 4, Antonio Settanni 5, Maria Teresa Spedicato 6 and Marco Taviani 1,7 1 ISMAR-CNR, Via Gobetti 101, 40129 Bologna, Italy; [email protected] 2 Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Via E. Orabona 4, 70125 Bari, Italy; [email protected] 3 CoNISMa, Piazzale Flaminio 9, 00196 Roma, Italy 4 IUCN—Centre for Mediterranean Cooperation, C/Marie Curie No. 22 (PTA), 29590 Málaga, Spain; [email protected] 5 Strada Statale 16 Sud Complanare Ovest 92, 70126 Bari, Italy; [email protected] 6 COISPA Tecnologia & Ricerca, Stazione Sperimentale per lo Studio delle Risorse del Mare, Via dei Trulli 18/20, 70126 Bari, Italy; [email protected] 7 Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale, 80121 Napoli, Italy * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-051-639-8936 Abstract: There is growing awareness of the impact of fishery activities on fragile and vulnerable deep-sea ecosystems, stimulating actions devoted to their protection and best management by national and international organizations. The Bari Canyon in the Adriatic Sea represents a good case study of this, since it hosts vulnerable ecosystems, threatened species, as well as valuable commercial species, but virtually lacks substantial management plans for the sustainable use of resources. This study documents the high level of biodiversity of the Bari Canyon and the impact of Citation: Angeletti, L.; D’Onghia, G.; human activities by analyzing remotely operated vehicle surveys and benthic lander deployments. -

Monitoring of Volatile Organic Compounds in the Cities of the Metropolitan Area of Bari (Italy)
Available online at www.sciencedirect.com Procedia Environmental Sciences 4 (2011) 126–133126–xxx Urban Environmental Pollution 2010 Monitoring of volatile organic compounds in the cities of the metropolitan area of Bari (Italy) Martino Amodioa, Gianluigi de Gennaroa,b, Annalisa Marzoccab, Livia Trizioa,b, Maria Tutinob* a LenviroS srl, spin off of Università degli Studi di Bari, via Orabona 4, 70126 Bari, Italy bDipartimento di Chimica, Università degli Studi di Bari, via Orabona 4, 70126 Bari, Italy Received dateElsevier September use only: 30, 2010;Received revised date date here; January revised 30, date 2011; here; accepted accepted date date January here 30, 2011 Abstract A screening monitoring campaign of volatile organic compounds (VOC) was conducted in the main cities of the metropolitan area of Bari, south-eastern Italy, in order to evaluate the impact of the vehicular traffic on the urban air quality. VOC were sampled with diffusive samplers suitable for thermal desorption. The monitoring was planned considering the number of inhabitants and the intensity of the vehicular traffic in each city. The same concentration pattern and the correlation among benzene versus toluene levels in all sites confirmed the presence of a single source, the vehicular traffic, having a strong impact on urban air quality. © 20112009 Published by Elsevier BV Keywords: VOC, metropolitan area, vehicular traffic 1. Introduction In several large world cities air pollutants are increasing over time and sometimes exceed the levels set up by the national ambient air quality standards [1-3]. Among the different sources of air pollutants, the road transport is the sector which mostly contributes to the levels of pollutants in urban areas [4,5].