Regione Abruzzo Provincia Dell
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Updated Distribution of Osmoderma Eremita in Abruzzo (Italy) and Agro-Pastoral Practices Affecting Its Conservation (Coleoptera: Scarabaeidae)
Fragmenta entomologica, 47 (2): 139-146 (2015) eISSN: 2284-4880 (online version) pISSN: 0429-288X (print version) Research article Submitted: July 18th, 2015 - Accepted: November 16th, 2015 - Published: December 31st, 2015 Updated distribution of Osmoderma eremita in Abruzzo (Italy) and agro-pastoral practices affecting its conservation (Coleoptera: Scarabaeidae) Patrizia GIANGREGORIO 1, Paolo AUDISIO 2, Giuseppe Maria CARPANETO 3, Giuseppe MARCANTONIO 1, Emanuela MAURIZI 3,4, Fabio MOSCONI 2,4, Alessandro CAMPANARO 4,5,* 1 Parco Nazionale della Majella, Ufficio Agronomico e indennizzi danni fauna - Via Badia 28, I-67039 Sulmona (L’Aquila), Italy [email protected]; [email protected] 2 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” - Via A. Borelli 50, I-00161 Roma, Italy - [email protected] 3 Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze - Viale G. Marconi 446, I-00146, Roma, Italy - [email protected] 4 CREA-ABP Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, Centro di Ricerca per l’Agrobiologia e la Pedologia - Via di Lanciola 12/a, I-50125 Cascine del Riccio (Firenze), Italy - [email protected]; fabio.mosconi@ gmail.com; [email protected] 5 MiPAAF - National Forest Service, CNBF National Centre for Forestry Biodiversity “Bosco Fontana” - Strada Mantova 2, I-46045 Marmirolo (Mantova), Italy * Corresponding author Abstract New records of Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) are reported for Abruzzo (Italy), together with a review of its distribution in this region. O. eremita is a saproxylic beetle dependent on the presence of hollow deciduous trees with abundant wood mould in their cavities. -

Abruzzo: Europe’S 2 Greenest Region
en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 1 Abruzzo: Europe’s 2 greenest region Gran Sasso e Monti della Laga 6 National Park 12 Majella National Park Abruzzo, Lazio e Molise 20 National Park Sirente-Velino 26 Regional Park Regional Reserves and 30 Oases en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 2 ABRUZZO In Abruzzo nature is a protected resource. With a third of its territory set aside as Park, the region not only holds a cultural and civil record for protection of the environment, but also stands as the biggest nature area in Europe: the real green heart of the Mediterranean. en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 3 ABRUZZO ITALY 3 Europe’s greenest region In Abruzzo, a third of the territory is set aside in protected areas: three National Parks, a Regional Park and more than 30 Nature Reserves. A visionary and tough decision by those who have made the environment their resource and will project Abruzzo into a major and leading role in “green tourism”. Overall most of this legacy – but not all – is to be found in the mountains, where the landscapes and ecosystems change according to altitude, shifting from typically Mediterranean milieus to outright alpine scenarios, with mugo pine groves and high-altitude steppe. Of all the Apennine regions, Abruzzo is distinctive for its prevalently mountainous nature, with two thirds of its territory found at over 750 metres in altitude.This is due to the unique way that the Apennine develops in its central section, where it continues to proceed along the peninsula’s -

Ministero Della Salute, Risultati Dell
Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA UFFICIO III Si forniscono di seguito i risultati dell’analisi condotta sui dati 2012 della Regione Abruzzo rilevati attraverso il sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare (SIAD). Tale sistema istituito, nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), con decreto ministeriale del 17 dicembre 2008 e successive modificazioni (G.U. n. 6 del 9 gennaio 2009) mira a costruire una base dati integrata a livello nazionale, incentrata sul paziente, dalla quale rilevare informazioni in merito agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati in maniera programmata da operatori afferenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nell’ambito dell’assistenza domiciliare. L’analisi è stata condotta attraverso l’applicazione delle seguenti due misure ai dati trasmessi dalla regione Abruzzo relativamente ai Comuni individuati e ricompresi nelle macro aree: Valle Subequana, Val Fino – Vestina, Basso Sangro – Trigno, Valle Roveto. Misure Numero di persone con età maggiore o uguale a 65 anni/ 75 anni prese in carico (misura 1); Numero di accessi pro capite (misura 2). Aree di interesse: Valle Subequana – Comuni di: Acciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Navelli, Ofena, Prata d’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa Santa Lucia degli Abruzzi. Val Fino – Vestina – Comuni di: Arsita, Bisenti, Brittoli, Carpineto della Nora, Castel Castagna, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cermignano, Civitella Casanova, Corvara, Elice, Farindola, Isola del Gran Sasso d’Italia, Montebello di Bertona, Montefino, Penna Sant’Andrea, Vicoli, Villa Celiera. -

Avezzano - Roma
Sulmona – Avezzano - Roma ORARIO FERIALE FERMATE Feriale L/V (1) Feriale Feriale Feriale Feriale SULMONA 05.00 06.20 08.15 10.10 15.10 17.15 Pratola Peligna 05.18 06.38 08.29 10.26 15.26 17.31 AVEZZANO | | 09.15 11.14 16.10 18.19 Roma Portonaccio 07.05 08.25 10.30 12.25 17.25 19.40 ROMA Tiburtina 07.10 08.30 10.35 12.30 17.30 19.45 FERMATE Feriale Feriale Feriale L/V (1) Feriale Feriale ROMA Tiburtina 08.45 12.00 15.00 17.50 19.00 20.45 Roma Portonaccio 08.50 12.05 15.05 17.55 19.05 20.50 AVEZZANO 10.11 | | | | 22.11 Pratola Peligna 10.50 13.54 16.54 19.44 20.54 22.50 SULMONA 11.05 14.10 17.10 20.00 21.10 23.05 (1) Si effettua da lunedì a venerdì ATTENZIONE: i viaggiatori interessati alla tratta AVEZZANO-ROMA e viceversa, possono consultare anche gli orari delle corse Villavallelonga – Avezzano – Roma e Lecce dei Marsi – Avezzano – Roma Sulmona – Avezzano - Roma ORARIO FESTIVO FERMATE Festivo Festivo Festivo SULMONA 08.00 14.00 18.50 Pratola Peligna 08.16 14.16 19.08 AVEZZANO 09.04 15.04 | Roma Portonaccio 10.15 16.15 20.55 ROMA Tiburtina 10.20 16.20 21.00 FERMATE Festivo Festivo Festivo ROMA Tiburtina 16.00 18.00 21.15 Roma Portonaccio 16.05 18.05 21.20 AVEZZANO 17.26 19.26 22.41 Pratola Peligna 18.05 20.05 23.20 SULMONA 18.20 20.20 23.35 ATTENZIONE: i viaggiatori interessati alla tratta AVEZZANO-ROMA e viceversa, possono consultare anche gli orari delle corse Villavallelonga – Avezzano – Roma e Lecce nei Marsi – Avezzano – Roma Lecce nei Marsi – Avezzano - Roma ORARIO FERIALE FERMATE Feriale FERMATE Feriale LECCE NEI MARSI 05.25 ROMA Tiburtina 16.00 Gioia dei Marsi 05.30 Roma V. -

Genio Civile Dell'aquila
GENIO CIVILE DELL’AQUILA Divisione territoriale dei Comuni L’Ufficio Sismica L’Aquila è competente in materia sismica per i seguenti Comuni Acciano Castel del Monte Ocre Sant’Eusanio Forconese Barete Castelvecchio Calvisio Ofena Santo Stefano di Sessanio Barisciano Fagnano Alto Pizzoli Scoppito Cagnano Amiterno Fontecchio Poggio Picenze Tione degli Abruzzi Campotosto Fossa Prata d’Ansidonia Tornimparte Capestrano L’Aquila Rocca di Cambio Villa Santa Lucia Capitignano Lucoli Rocca di Mezzo Villa Sant’Angelo Caporciano Montereale San Demetrio ne’ Vestini Carapelle Calvisio Navelli San Pio delle Camere L’Ufficio Tecnico e Sismica Avezzano è competente in materia sismica e quale Autorità Idraulica per i seguenti Comuni Aielli Cerchio Massa d’Albe Rocca di Botte Avezzano Civita d’Antino Morino San Benedetto dei Marsi Balsorano Civitella Roveto Opi San Vincenzo Valle Roveto Bisegna Cocullo Oricola Sante Marie Canistro Collarmele Ortona dei Marsi Scurcola Marsicana Capistrello Collelongo Ortucchio Tagliacozzo Cappadocia Gioia dei Marsi Ovindoli Trasacco Carsoli Lecce dei Marsi Pereto Villavallelonga Castellafiume Luco dei Marsi Pescasseroli Celano Magliano dei Marsi Pescina L’Ufficio Tecnico e Sismica L’Aquila-Sulmona è competente in materia sismica per i seguenti Comuni Alfedena Castel di Sangro Pacentro Roccaraso Anversa degli Abruzzi Castelvecchio Subequo Pescocostanzo Scanno Ateleta Civitella Alfedena Pettorano sul Gizio Scontrone Barrea Collepietro Pratola Peligna Secinaro Bugnara Corfinio Prezza Sulmona Campo di Giove Gagliano Aterno Raiano -

Civitella Roveto Aq 45,35 15 3229 4,6 0,33
A.R.T.A. - Agenzia Regionale per la Tutela dellÕAmbiente CIVITELLA ROVETO AQ 45,35 15 3229 4,6 0,33 COCULLO AQ 31,72 28 228 122,8 0,88 COLLELONGO AQ 57,17 5 1540 3,2 0,09 FAGNANO ALTO AQ 24,48 11 454 24,2 0,45 GORIANO SICOLI AQ 21,77 15 622 24,1 0,69 LÕAQUILA AQ 466,96 71 70005 1,0 0,15 LECCE NEI MARSI AQ 65,98 7 1796 3,9 0,11 LUCOLI AQ 109,74 10 956 10,5 0,09 MONTEREALE AQ 104,39 19 2971 6,4 0,18 ORICOLA AQ 18,4 16 948 16,9 0,87 ORTONA DEI MARSI AQ 52,66 4 778 5,1 0,08 OVINDOLI AQ 58,84 16 1234 13,0 0,27 PERETO AQ 41,11 4 711 5,6 0,10 PESCASSEROLI AQ 92,54 11 2267 4,9 0,12 PESCINA AQ 37,51 7 4713 1,5 0,19 PRATOLA PELIGNA AQ 28,27 3 8011 0,4 0,11 PREZZA AQ 19,71 27 1110 24,3 1,37 RAIANO AQ 29,1 3 2972 1,0 0,10 RIVISONDOLI AQ 31,65 1 718 1,4 0,03 ROCCA DI CAMBIO AQ 27,62 11 495 22,2 0,40 ROCCA PIA AQ 44,8 9 210 42,9 0,20 ROCCARASO AQ 49,95 18 1608 11,2 0,36 S. BEN. IN PERIL. AQ 19,01 6 175 34,3 0,32 S. EUSANIO FORCONESE AQ 7,97 3 446 6,7 0,38 SCANNO AQ 134,04 18 2154 8,4 0,13 SCOPPITO AQ 53,04 3 2748 1,1 0,06 SULMONA AQ 58,33 14 25301 0,6 0,24 TIONE ABRUZZI AQ 40,24 6 413 14,5 0,15 TORNIMPARTE AQ 65,87 3 2994 1,0 0,05 TRASACCO AQ 51,41 1 6011 0,2 0,02 VILLALAGO AQ 35,29 3 631 4,8 0,09 ARCHI CH 28,18 10 2362 4,2 0,35 BOMBA CH 18,13 31 978 31,7 1,71 BUCCHIANICO CH 38,05 3 4913 0,6 0,08 CASACANDITELLA CH 12,41 3 1462 2,1 0,24 CHIETI CH 58,63 7 56615 0,1 0,12 FARA S. -

Edifici Scolastici
REGIONE ABRUZZO - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile EDIFICI SCOLASTICI : Elenco ricognitivo dello stato di attuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274/2003 aggiornato alla data del 20 giugno 2017 (da dati agli atti dell'Ufficio "Rischio Sismico" e/o da comunicazione degli Enti proprietari tramite "scheda ricognitiva 2017" in attuazione alla DGR n. 74/2017) Funzione Zona Comuni Categoria INDICE DI RISCHIO Edificio da Trasm. Funzione edificio da sismica mod. in All. 7 anno Anno di Tipo di INDICE DI RISCHIO dismettere scheda sismica n° (SLV) Livello di anno ultimo Edificio in Ente attuatore/proprietario primaria Piano di Denominazione scuola Comune di ubicazione indirizzo vigente class ag OPCM Volume [mc] esecuzione progettazione/c intervento (SLV) Area R4 USR ricognitiva Note NR previgente studenti conoscenza intervento uso Edificio Emergenza (DGR sismica 3907/10 verifica ostruzione post intervento 2017 (ante 2005) (3) PROVINCIA (1) 438/2005) (2) e smi (4) (5) (6) 1 AQ Comune di Avezzano scuola R Infanzia Caruscino Avezzano Via Caruscino 1 1 no 0,253496 si 42 1.408 0,240 2012 LC1 1950 - - - NO SI NO NO Infanzia - Asilo nido "Orsetto 2 AQ Comune di Avezzano scuola R Avezzano Via Trento n. 66 1 1 no 0,253496 si np 1.850 0,262 2013 - 1980 - - - NO NO - NO Bernardo" Intervento di miglioramento sismico in corso di appalto. Fondi 3 AQ Comune di Avezzano scuola R Infanzia Via De Gasperi Avezzano Via De Gasperi 1 1 no -

Elenco Prodotti Minori, Di Nicchia E/O Tipici, Anche
Allegato 1 Bando Misura 4.1 – Sottomisura 4.1.1 – Azione 1 PSL del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro – PSR Regione Abruzzo 2007 – 2013 “Comuni dell’area GAL” COMUNI Area Peligna Anversa degli Abruzzi; Bugnara; Campo di Giove, Cansano; Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio; Pratola Peligna; Prezza; Raiano Roccacasale; Scanno; Villalago; Vittorito; Area Alto Sangro Alfedena; Ateleta, Barrea, Castel di Sangro; Civitella Alfedena; Opi; Pescasseroli; Pescocostanzo; Rivisondoli; Roccapia; Roccaraso; Scontrone; Villetta Barrea Valle dell’Aterno Castel di Ieri, Castel vecchio Subequo; Gagliano Aterno; Goriano Sicoli; Molina Aterno; Secinaro; Area Marsicana Villavallelonga; Collelongo; Valle del Giovenco Bisegna; Gioia dei Marsi; Ortona dei Marsi; Ortucchio; Lecce dei Marsi Sulmona (parzialmente eleggibile) GAL Abruzzo Italico Alto Sangro Pagina 1 Allegato 1 Bando Misura 4.1 – Sottomisura 4.1.1 – Azione 1 PSL del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro – PSR Regione Abruzzo 2007 – 2013 “Comuni dell’area GAL” Comune Parco Nazionale Parco Parco Aree SIC d'Abruzzo, Lazio e Nazionale Regionale ZPS Natura Molise della Majella Sirente Velino 2000 Alfedena X X Anversa degli Abruzzi X Ateleta X X Barrea X X Bisegna X X Bugnara X Campo di Giove X X Cansano X X Castel di Ieri X X Castel di Sangro X Castelvecchio Subequo X X Civitella Alfedena X X Cocullo X Collelongo X Corfinio X X Gagliano Aterno X X Gioia dei Marsi X Goriano Sicoli X X Introdacqua X Lecce nei Marsi X X Molina Aterno X X Opi X X Ortona dei Marsi X X Ortucchio X Pacentro X X Pescasseroli X X Pescocostanzo X X Pettorano sul Gizio X X Pratola Peligna X X Prezza Raiano X Rivisondoli X X Rocca Pia X X Roccacasale X X Roccaraso X X Scanno X X Scontrone X Secinaro X X Sulmona – in parte (*) X X Villalago X Villavallelonga X X Villetta Barrea X X Vittorito X GAL Abruzzo Italico Alto Sangro Pagina 2 . -

DETERMINAZIONE N. DPD022/24 Del 08/06/2018 Progressivo N.6301
GIUNTA REGIONALE DETERMINAZIONE n. DPD022/24 del 08/06/2018 Progressivo n.6301 DIPARTIMENTO: POLITICHEDELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA SERVIZIO: DPD022 - Servizio Promozione della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura UFFICIO: Cooperazione finalizzata alle Macro e Micro Filiere, ai Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI), Interventi di Formazione, Consulenza e Azioni Dimostrative a favore delle Aziende Agricole OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo. Misura M01 – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”. Bando approvato con Determinazione DPD022/40 del 23.12.2016 - Fase B) - Approvazione graduatorie provvisorie dei beneficiari dei voucher distinte per focus area. IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO RICHIAMATA la D.G.R. n. 65/2018 di riorganizzazione parziale dei Servizi del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca con effetto dal 01/03/2018; VISTO il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2014-2020 attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015) 7994 del 13 novembre 2015; VISTA la DGR n. 1056 del 19/12/2015 recante: “Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). -

Ministero Della Salute, Risultati Dell'analisi Condotta Sui Dati Dati
Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA Ufficio di Statistica Oggetto: Regione Abruzzo – Analisi della rete assistenza ambulatoriale nelle aree interne. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili dal Servizio sanitario nazionale costituiscono il livello essenziale di assistenza garantito dal sistema di sanità pubblica in questo regime di erogazione. Si forniscono di seguito i risultati dell’analisi condotta sui dati sui dati relativi alla rete di assistenza ambulatoriale delle aree interne selezionate dalla Regione Abruzzo, rilevati per l’anno 2012 attraverso le seguenti fonti informative: - Modelli di rilevazione Decreto Ministro della salute 5 dicembre 2006 STS.11 - Dati anagrafici delle strutture sanitarie; STS.21 - Assistenza specialistica territoriale: attività clinica, di laboratorio, di diagnostica per immagini e di diagnostica strumentale. Le informazioni tratte dalle suddette fonti informative consentono di caratterizzare la rete di offerta di assistenza ambulatoriale dei Comuni oggetto di analisi, con riferimento alle strutture sanitarie presenti nelle aree interne (Fonte STS.11) e ai relativi dati di attività (Fonte STS.21 – quadro F). L’analisi è stata condotta sulla base dei dati trasmessi dalla Regione Abruzzo al Ministero della salute, relativamente ai Comuni ricompresi nelle seguenti aree del territorio regionale: BASSO SANGRO – TRIGNO: Borrello, Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, -

Archivio Storico Del Parco Nazionale D'abruzzo, Lazio E
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Archivio Storico Catalogo/Categoria XIV ARCHIVIO STORICO DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE CATEGORIA XIV – Rapporti con il territorio (Classe I : Rapporti con le popolazioni locali) .................................................................................................. 2 (Classe II : Sovvenzioni dal Parco) ................................................................................................................. 15 (Classe III : Realizzazioni sul territorio) ......................................................................................................... 22 (Classe IV : Rapporti istituzioni fasciste) ........................................................................................................ 30 (Classe V : Rimandi alle guerre) ..................................................................................................................... 34 1 Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Archivio Storico Catalogo/Categoria XIV CATEGORIA XIV - Rapporti con il territorio (Classe I : Rapporti con le popolazioni locali) Cat. Cl. B. Fasc. Contenuto Estremi cronologici Cc. XIV I 1 1 Corrispondenza tra il presidente del 1923 – 1924 2 Parco e la Congregazione di Carità di Pescasseroli. Quest’ultima dichiara di aver ricevuto il pagamento dell’affitto dei suoi locali utilizzati come uffici della direzione dello stesso Parco XIV I 1 2 I sindaci di Villavallelonga e di San 30.05.1923 3 Donato Val Comino scrivono a Erminio Sipari comunicando l’avvenuta affissione -
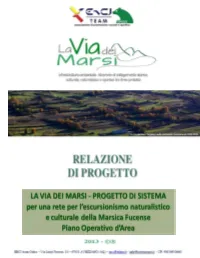
Via Dei Marsi
1 2 Progetto La Via dei Marsi: Allegato tecnico Il Progetto “La Via dei Marsi” è centrato sulla integrazione tematica e territoriale dell’area della Marsica Fucense vista come Rete Marsicana della Mobilità di fruizione strutturata intorno a La Via dei Marsi ed alle Aree Protette (Nazionali e Regionali) quali ambiti di eccellenza per la qualità dell’ambiente, l’attrattività per un turismo sostenibile e la fornitura di servizi, sviluppando anche le connessioni con le Regioni ed Aree Protette confinanti. L’obiettivo è irrobustire e diffondere un processo, già in parte avviato in alcune realtà, in grado di coniugare la conservazione – e ove occorre anche la riqualificazione - dell’ambiente con la promozione socio-economica delle comunità più svantaggiate dell’interno, tenendo conto che la sofferente, realtà turistica di montagna, può trarre benefici dalla estensione dell’offerta nel territorio e nell’arco dell’anno. E’ stato quindi costruito un quadro generale sulla progettualità della proposta “La Via dei Marsi” nel Sistema della Rete Marsicana della Mobilità e le Aree Protette della Marsica 3 Fucense interessate [Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Regionale Sirente Velino, la Riserva del Monte Salviano e le altre Riserve Regionali presenti nel territorio, da Carsoli a Canistro (Valle del Liri), ad Ortona e Bisegna (Valle del Giovenco), fino a Pescasseroli (dall’Alta Vallelonga e Cicerana) e cosi via], la cui realizzazione prevede interventi finanziabili attraverso diversi canali, europei, statali e regionali. La base di partenza è stata costituita da: il Progetto La Via dei Marsi, articolato nelle sue diverse componenti e i progetti settoriali, veri e propri Poli Strategici, Presidi territoriali; i Piani dei Parchi e delle Riserve ed i Piani Pluriennali Socioeconomici; i diversi atti di programmazione degli Enti di gestione delle Aree Protette e della Regione stessa, tra cui le annuali deliberazioni della Giunta regionale di riparto delle risorse per le aree protette, con individuazione dei progetti prioritari.