ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DOCUMENTO ... -.: Liceo Veronese
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

André Derain Stoppenbach & Delestre
ANDR É DERAIN ANDRÉ DERAIN STOPPENBACH & DELESTRE 17 Ryder Street St James’s London SW1Y 6PY www.artfrancais.com t. 020 7930 9304 email. [email protected] ANDRÉ DERAIN 1880 – 1954 FROM FAUVISM TO CLASSICISM January 24 – February 21, 2020 WHEN THE FAUVES... SOME MEMORIES BY ANDRÉ DERAIN At the end of July 1895, carrying a drawing prize and the first prize for natural science, I left Chaptal College with no regrets, leaving behind the reputation of a bad student, lazy and disorderly. Having been a brilliant pupil of the Fathers of the Holy Cross, I had never got used to lay education. The teachers, the caretakers, the students all left me with memories which remained more bitter than the worst moments of my military service. The son of Villiers de l’Isle-Adam was in my class. His mother, a very modest and retiring lady in black, waited for him at the end of the day. I had another friend in that sinister place, Linaret. We were the favourites of M. Milhaud, the drawing master, who considered each of us as good as the other. We used to mark our classmates’s drawings and stayed behind a few minutes in the drawing class to put away the casts and the easels. This brought us together in a stronger friendship than students normally enjoy at that sort of school. I left Chaptal and went into an establishment which, by hasty and rarely effective methods, prepared students for the great technical colleges. It was an odd class there, a lot of colonials and architects. -

CABANEL ALEXANDRE (Francia) Nato Montpellier, 28 Settembre 1823
CABANEL ALEXANDRE (Francia) Nato Montpellier, 28 settembre 1823. Morto a Parigi, 23 gennaio 1889. Allievo di François-Édouard Picot all'École des Beaux-Arts, ottenne il secondo Prix de Rome nel 1845, passando così cinque anni a Villa Medici a Roma. Ottenne grande fama con la Nascita di Venere, acquistata da Napoleone III nel 1863. Lo stesso anno fu nominato professore all'École des Beaux-Arts e membro dell'Académie des Beaux-Arts. Membro di giuria per 17 volte dal 1868 al 1888 del Salon, ne ricevette la medaglia d'onore nel 1865, 1867 e 1878. Fu pittore di storia, di genere e ritrattista: conteso dai collezionisti d'Europa e d'America, richiesto come ritrattista, fu nemico del Naturalismo e dell'Impressionismo, e fu attaccato da Émile Zola e da tutti coloro che difendevano la necessità di un'arte meno soave e più realista. Il collega Edouard Manet lo disprezzava. La tela Nascita di Venere gli valse grande notorietà e numerose committenze. Durante l’Ottocento al tema del nudo sdraiato si dedicarono pittori affermati come Renoir e Courbet, Ingres e Gauguin e Van Gogh. Molto ricercato come ritrattista, ebbe moltissimi allievi, fra cui alcuni raggiunsero la notorietà. FILATELIA BENIN Anno 2003, CENTRO AFRICANA REP. Anno 2014 (BF 752), GUINEA BISSAU Anno 2013 (5216), MALI Anno 2011, SPAGNA Anno 2013 Busta Postale. SAO TOME’ 2000 SPAGNA BUSTE POSTALI CABOT FRANCISCO SANS (Spagna) Nato il 9 aprile 1828 a Girona. Morto il 5 Maggio 1881 a Madrid.- Pittore catalano diresse il Museo del Prado dal 1873 al 1881 Figlio di un navigatore della Royal Navy spagnola, frequentò la Escola de la Llotja (1850-1855), dove, all’inizio, seguì corsi di oreficeria (per volon- tà della sua famiglia), ma li interruppe per dedicarsi alla pittura. -

Cézanne Portraits
© Copyright, Princeton University Press. No part of this book may be distributed, posted, or reproduced in any form by digital or mechanical means without prior written permission of the publisher. Introduction: The Reading of the Model JOHN ELDERFIELD La lecture du modèle, et sa réalization, est quelquefois très lent à venir pour l’artiste. Cézanne to Charles Camoin, 9 December 19041 Paul Cézanne was born in Aix-en-Provence on 19 January 1839, and died there aged sixty-seven on 23 October 1906. He made almost 1,000 paintings, of which around 160 are portraits.2 This publication accompanies the only exhibition exclusively devoted to these works since 1910, when Ambroise Vollard, who had been the artist’s dealer, showed twenty-four ‘Figures de Cézanne’. The present, much larger selection was chosen with the aims of providing a guide to the range and development of Cézanne’s portraits, the methods of their making, and the choice of their sitters. Also, more broadly, it is intended to raise the question of what the practice of portraiture meant for Cézanne when he was painting – or, as he said, reading and ‘realising’ – the model. Old Rules When Cézanne began painting portraits in the early 1860s, portraiture in France had long been acknowledged as a genre second in importance only to paintings of historical and mythological subjects. It was growing in popularity, and it would continue to do so during the period of Cézanne’s career: in the late 1880s, a National Portrait Gallery would be proposed for Paris, as well as a special gallery for portraits in the Louvre.3 It was during the 1860s and 1870s, however, that many ambitious painters found themselves enquiring what a portrait should aim to do. -

Ambroise Vollard, Le Cubisme, Par PC
Langue Vivante Régionale Activité : 45 minutes, artistique et culturelle Thème : kan i rès la kaz, i gingn pi sortir Objectifs : découvrir une personnalité de la Réunion, Ambroise Vollard découvrir un artiste qu’il a mis en lumière : Pablo Picasso et le mouvement cubiste réaliser un portrait cubiste en suivant des étapes Henri Louis Ambroise Vollard Ambroise Vollard est un marchand d'art, 1galeriste, éditeur et écrivain français né à Saint-Denis de La Réunion le 3 juillet 1866 et mort à Versailles le 22 juillet 1939. Il révéla des peintres comme : Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Henri Matisse, Pablo Picasso. 2Avant-gardiste en matière d'art moderne, il se lia d'amitié avec les plus grands peintres de la fin du XIXe siècle (19ème siècle) et du début du XXe siècle (20ème siècle). Fils de notaire, le jeune Ambroise quitte la Réunion pour poursuivre des études à Montpellier, mais c'est à Paris qu'il fera finalement des études de droit. Il y développe une passion pour la peinture qui l'amène à ouvrir sa galerie d'art dès 1890. Il ouvre sa première galerie parisienne en 1893. Vollard expose par la suite de nombreux artistes majeurs comme Gauguin ou Matisse, ce dernier en 1904. Il en fréquente beaucoup d'autres, notamment Paul Cézanne ou Auguste Renoir, qui peindront son portrait. En 1898, Pierre Bonnard, Ker-Xavier Roussel et Édouard Vuillard exécutent à sa demande des 3lithographies en couleur. Vollard se lance dès 1889 dans l'édition et publie de nombreux poètes dans des recueils illustrés. C'est chez lui qu'a lieu en juin 1901 la première exposition de Pablo Picasso, jeune peintre espagnol alors récemment installé à Paris (et qui peindra également son portrait). -

Brief Report on Technology and Condition
Brief Report on Technology and Condition Camille Pissarro (1830-1903) L‘Hermitag near Pontoise (L‘Hermitage à Pontoise) 1867 signed and dated bottom right: “C. Pissarro. 1867” Oil on canvas h 91.0 cm x b 150.5 cm WRM 3119 Camille Pissarro – L’Hermitage near Pontoise Brief Report on Technology and Condition Brief Report Pissarro’s large-scale painting L’Hermitage near The reason why Pissarro rejected this first motif is Pontoise is among his early masterpieces and be- unclear, and may be linked to his financial situation longs to a group of pictures intended for the Paris at the time. Without adding a separating layer, he Salon exhibition of 1868. It cannot be ascertained very carefully overpainted the first motif with the with certainty, however, whether this painting was scene we see today. It is impossible to say how much in fact exhibited there [Tinterow/Loyrette 1994, time elapsed between the first painting and the p. 446; Pissarro/Durand-Ruel Snollaerts 2005, Vol. II, present one. It is striking, though, that very few ear- no. 119, p. 111]. In about 1930 the picture was pur- ly shrinkage cracks developed, and these, together chased by Ambroise Vollard from Pissarro’s son, with occasional unpainted areas in the new picture, Georges Manzana-Pissarro, and it is perhaps in provide valuable evidence regarding the coloration connexion with this purchase that the lining of the of the rejected composition: the dominant tones stable, twill-weave canvas is to be understood. Even were a bright pale blue in the sky, green, dull yellow- with the unaided eye, and strikingly so under rak- ish-green and ochre in the foreground and blackish- ing light, it is evident that the robust canvas had grey along the horizon (figs. -

The National Gallery Immunity from Seizure
Immunity from Seizure THE NATIONAL GALLERY IMMUNITY FROM SEIZURE Delacroix and the Rise of Modern Art 17 Feb 2016 - 22 May 2016 The National Gallery, London, Trafalgar Square, London, WC2N 5DN Immunity from Seizure IMMUNITY FROM SEIZURE Delacroix and the Rise of Modern Art 17 Feb 2016 - 22 May 2016 The National Gallery, London, Trafalgar Square, London, WC2N 5DN The National Gallery is able to provide immunity from seizure under part 6 of the Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007. This Act provides protection from seizure for cultural objects from abroad on loan to temporary exhibitions in approved museums and galleries in the UK. The conditions are: The object is usually kept outside the UK It is not owned by a person resident in the UK Its import does not contravene any import regulations It is brought to the UK for public display in a temporary exhibition at a museum or gallery The borrowing museum or gallery is approved under the Act The borrowing museum has published information about the object For further enquiries, please contact [email protected] Protection under the Act is sought for the objects listed in this document, which are intended to form part of the forthcoming exhibition, Delacroix and the Rise of Modern Art. Copyright Notice: no images from these pages should be reproduced without permission. Immunity from Seizure Delacroix and the Rise of Modern Art 17 Feb 2016 - 22 May 2016 Protection under the Act is sought for the objects listed below: Eugène Delacroix (1798 - 1863) © The Art Institute of Chicago, -
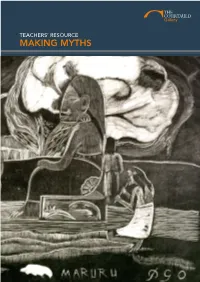
Making Myths Contents
TEACHERS’ RESOURCE MAKING MYTHS CONTENTS 1: MAKING MYTHS: THE STORIES TOLD BY ARTISTS, CURATORS, COLLECTORS AND CONSERVATORS 2: COLLECTING GAUGUIN: CURATOR’S QUESTIONS 3: RE-INVENTING MYTH: FORM AND FUNCTION IN SOME EARLY MODERN ‘MYTHOLOGICAL’ WORKS FROM THE COURTAULD GALLERY 4: MANET, DEGAS, RENOIR AND THE THEATRE OF EVERYDAY LIFE 5: TAKEN AT FACE VALUE? SELF-STAGING AND MYTH-MAKING IN THE WORK OF GAUGUIN AND VAN GOGH 6: THE MATERIAL LANGUAGE OF PAINTINGS: CONSERVATION AND TECHNICAL ART HISTORY 7: REGARDE! FRENCH LANGUAGE RESOURCE: GAUGUIN ET LA POLYNÉSIE 8: GLOSSARY 9: SUGGESTIONS FOR RESEARCH AND PRACTICAL ACTIVITIES IN THE CLASSROOM 10: TEACHING RESOURCE IMAGE CD Compiled and produced by Carolin Levitt and Sarah Green Design by JWDesigns SUGGESTED CURRICULUM LINKS FOR EACH ESSAY ARE MARKED IN RED TERMS REFERRED TO IN THE GLOSSARY ARE MARKED IN BLUE To book a visit to the gallery or to discuss any of the education projects at The Courtauld Gallery please contact: e: [email protected] t: 0207 848 1058 WELCOME The Courtauld Institute of Art runs an exceptional programme of activities suitable for young people, school teachers and members of the public, whatever their age or background. We offer resources which contribute to the understanding, knowledge and enjoyment of art history based upon the world-renowned art collection and the expertise of our students and scholars. I hope the material will prove to be both useful and inspiring. Henrietta Hine Head of Public Programmes The Courtauld Institute of Art This resource offers teachers and their students an opportunity to explore the wealth of The Courtauld Gallery’s permanent collection by expanding on a key idea drawn from our exhibition programme. -

Impressionism and Post-Impressionism: Highlights from the Philadelphia Museum of Art'
H-Pennsylvania Locke on Thompson and Rishel and Owens and Rub, 'Impressionism and Post-Impressionism: Highlights from the Philadelphia Museum of Art' Review published on Monday, January 4, 2021 Jennifer A. Thompson, Joseph J. Rishel, Eileen Owens, Timothy Rub, eds. Impressionism and Post-Impressionism: Highlights from the Philadelphia Museum of Art. New Haven: Yale University Press, 2019. 216 pp. $35.00 (cloth), ISBN 978-0-87633-289-4. Reviewed by Nancy Locke (Pennsylvania State University) Published on H-Pennsylvania (January, 2021) Commissioned by Jeanine Mazak-Kahne (Indiana University of Pennsylvania) Printable Version: https://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=55313 The collection of Impressionist and Post-Impressionist art at the Philadelphia Museum of Art stands as one of the richest in the nation. It is not surprising that the institution would want to document it in book form. The questions that arise, however, concern the form that such a book should take. Curators necessarily considered how much of the vast collection should be included, and how many works should be illustrated. If these movements are primarily French, how many non-French artists should appear? What should the balance be between painting and other art forms? And is the audience for the book primarily members of the museum-going public, scholars specializing in the artists featured, or perhaps readers discovering the art for the first time? There may be no correct answers to these questions, and I would like to stress that as I sketch the way I think Jennifer A. Thompson and her collaborators chose to structureImpressionism and Post-Impressionism: Highlights from the Philadelphia Museum of Art. -

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Articolo 17, Comma 1, Decreto Legislativo 13 Aprile 2017, N
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (articolo 17, comma 1, Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) SCUOLA Liceo Classico “Barbarigo” Indirizzo Via Rogati, 17 - Padova Tel. 049-8246911 E-Mail [email protected] Prof. Giovanni Enrico CLASSE III A Anno scolastico 2019/’20 Coordinatore di classe Scorzon Il Consiglio di Classe Contarini prof. Cesarino Dirigente Scolastico Cattelan prof. Diego Insegnamento Religione Cattolica Beghin prof.ssa Lorena Italiano Mazzaro prof.ssa Greta Latino e Greco Andolfo prof.ssa Gloria Inglese Scorzon prof. Giovanni Enrico Storia e Filosofia Da Re prof. Antonio Matematica e Fisica Zabeo prof. Valter Scienze Naturali Ballarin prof.ssa Silvia Storia dell’Arte Zotti prof.ssa Carla Scienze Motorie Squarcina prof. Davide Pianoforte SITUAZIONE DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO La classe all’inizio dell’anno scolastico era composta da 18 alunni, di cui 2 trasferiti da altre scuole e 4 che hanno frequentato tutto l’anno o il secondo quadrimestre dell’anno scorso all’estero (Olanda e Canada). Nel corso dei primi mesi, per motivi personali, 3 studenti si sono ritirati, portando così il numero attuale a 15. All’interno del corpo docenti all’inizio dell’anno si sono verificati i seguenti avvicendamenti: - La prof.ssa di Greco e Latino è stata sostituita dalla prof.ssa Mazzaro; - La prof.ssa di Storia dell’Arte è rientrata dal congedo per maternità. La continuità didattica è stata pertanto pressoché garantita, contribuendo a rendere l’anno scolastico molto positivo. L’ampia e consolidata esperienza dei docenti ai quali è stato affidato l’incarico del quinto anno, nonché il loro spessore umano, unita alla positiva e collaborativa risposta del gruppo classe, hanno consentito di sviluppare un percorso ricco ed articolato in tutte le materie. -

Impressions of Modernity Prints from 1870 to 1945
Impressions of Modernity Prints from 1870 to 1945 rints are often overlooked in histories of Modernism, Palthough many painters and sculptors in the late nineteenth and early twentieth centuries were also printmakers. This focus exhibition presents a roster of notable avant-garde artists and investigates how their prints challenged conventions of subject-matter, style, and technique and presented unique visions of an ever-changing world. The period often aligned with Modernism, ca. 1870 to 1945, saw some of the most drastic shifts in the political, economic, social, and cultural frameworks of societies across the globe. The rise of capitalism, the escalation of nationalism, the rapid development of technology and industry, as well as the calamitous devastation and repercussions of multiple wars irrevocably altered Europe, the Americas, and the world. Representing diverse perspectives and movements—including Realism, Impressionism, Fauvism, and Expressionism—these prints not only reflect artists’ impressions of their times, but also convey the ethos of perpetual transformation that defines modernity. Édouard Manet (French, 1832−1883) Le Guitarrero (The Guitar Player), 1867 or later Etching and drypoint on paper Gift of Dorothy Small (85.166) Best known today as a Realist and Impressionist painter, Manet was also an active printmaker. He began making etchings around 1860 at a time when he and others sought to revive the medium as a fine art. In 1862 Manet and other artists and printers formed the Société des Aquafortistes (Society of Etchers), a group that promoted Old Master print techniques and issued monthly installments of members’ works. Le Guitarrero is based on Manet’s 1860 painting The Spanish Singer (Metropolitan Museum of Art), one of two submissions that was accepted at the Paris Salon in 1861, his debut year. -

Le Dossier De Présentation
Musée Léon Dierx Dossier de présentation à l’attention des enseignants Page | 1 Sommaire La notion de « musée » « Le musée est une institution permanente sans but lucratif, au service de la société et de son Histoire du musée Léon Dierx…………………………… p. 3 développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, Histoire des collections du musée…………………….. p. 7 étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et Les personnages du musée………………………………. P. 10 immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation et de Préparer sa visite et outils de médiation…………… p. 14 délectation. » Informations pratiques…………………………………….. p. 17 Définition de l’ICOM Page | 2 Histoire du musée Avant la création du musée L'emplacement occupé actuellement par le musée fait autrefois partie d'un terrain plus vaste, borné au nord par la rue de l'Arsenal (rue Roland Garros), au sud par la rue Sainte-Marie, à l'est par la rue Royale (rue de Paris) et à l'ouest par un sentier qui deviendra plus tard la rue Fénélon. Cette concession est morcelée en 1842 en six lots. L'un d'entre eux est celui qui nous intéresse ; il s'agit d'une parcelle de 2 400 m2, située à l’angle de la rue de Paris et de la rue Sainte-Marie, acquise le 7 octobre 1843 par Gustave Manès, propriétaire terrien à Sainte-Marie, pour y faire construire sa maison. La maison Manès Les plans de la demeure sont dessinés par les architectes Félix et Joseph Fraixe suivant les indications du nouveau propriétaire. Le bâtiment est livré en 1846. -

Classe VA Indirizzo Turistico AS 2020-2021
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Tecnico Statale VINCENZO ARANGIO RUIZ Viale Africa, 109 - 00144 ROMA - Distretto XX - C.F. 80218570580 tel. 06 121124080 fax 06 5918357 http: //www.arangioruiz.gov.it/ [email protected] [email protected] DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (art. 5 del D.P.R. n. 323/98) Classe V A Indirizzo Turistico ESAME DI STATO A.S. 2020-2021 1 INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE pag. 3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE pag. 4 PROFILO DELLA CLASSE pag. 6 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO pag. 7 PERCORSI INTERDISCIPLINARI pag. 11 TRACCE ELABORATI ESAME DI STATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO pag. 12 ELENCO TESTI PROGRAMMA DI ITALIANO Pag. 14 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER pag. 15 L’ORIENTAMENTO TABELLA DELLE COMPETENZE PCTO pag. 16 ATTIVITÀ’ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA pag. 17 ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari singole materie e relazioni finali pag. 18 ALLEGATO 2 – Griglie di valutazione colloquio pag. 51 COMMISSARI INTERNI pag. 52 FIRME COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE pag. 53 2 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE MATERIA NOME E COGNOME Discipline turistiche e aziendali Paolo Angelucci Lingua e letteratura italiana Laura D’Arpino Storia Laura D’Arpino Lingua e cultura straniera 1: Inglese Maria Anna Meccio Lingua e cultura straniera 2: Spagnolo Anna Sardaro Lingua e cultura straniera 3: Tedesco Maria Civitelli Arte e Territorio Cinzia Staforte Matematica Francesca Salvi Scienze Motorie Giuliano Ciaprini Geografia turistica Silvia Spagnolo Diritto e legislazione turistica Cinzia Di Prisco Materia alternativa Fabio Tinti Religione Jacopo Trionfera Sostegno Carmela Maria Burdieri Coordinatore della classe Prof.ssa Maria Civitelli 3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE La classe inizialmente composta da un numero elevato di studenti, è attualmente formata da 12 alunni, di cui 4 ragazzi e 8 ragazze.