I Viaggi E Le Ricerche Di Vitaliano Donati Di Giuse SCALVA
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Curriculum Di Stefano Zaggia
Curriculum Stefano Zaggia – p. 1 Curriculum di Stefano Zaggia Professore Associato in «Storia dell’Architettura» (ICAR/18) Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Università degli Studi di Padova. e-mail: [email protected] mobile: 331 1735072 Ufficio: Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale Università degli studi di Padova via Venezia 1, 35131 Padova Titoli di Studio: Laurea in Architettura, conseguita il 26 luglio 1990 presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. La tesi di Laurea dedicata a Il Ghetto di Padova, è stata premiata all’VIII edizione dei “Premi Brunacci – Monselice”. Dottorato di ricerca in «Storia dell'architettura e dell'urbanistica», conseguito in data 17/10/1996. Nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione nazionale alla Docenza di Prima Fascia. Borse di studio finalizzate alla ricerca: Borsa di studio presso il Centro Internazionale Studi di Architettura A. Palladio di Vicenza per la frequenza al Seminario su Michele Sanmicheli (24-28 ago. 1992). Ha conseguito due volte, nel 1996 e nel 1997, l’idoneità per il conferimento di borse di ricerca CNR (Comitato Nazionale per le Scienze d’Ingegneria e Architettura). Borsa di ricerca post-dottorato biennale (1997-1999), presso l'Istituto di Architettura e Urbanistica della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova. È stato titolare di Assegno di ricerca biennale presso il Dipartimento di Storia dell’Architettura IUAV (2001 - 2003). È stato titolare di Assegno di Ricerca biennale presso il Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento dell’Università di Padova (2003- 2004). Curriculum Stefano Zaggia – p. 2 Attività didattica: Dal 1996 al 2000 ha prestato attività di servizio come insegnante in: «Storia dell’Arte», con incarichi annuali, presso Istituti Statali d’Istruzione Secondaria Superiore di Padova. -
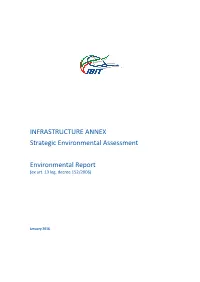
Strategic Environmental Assessment of the Infrastructure Annex to the Def
INFRASTRUCTURE ANNEX Strategic Environmental Assessment Environmental Report (ex art. 13 leg. decree 152/2006) January 2016 STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE INFRASTRUCTURE ANNEX TO THE DEF Environmental Report Table of Contents 1 INTRODUCTION: ...............................................................................................................1 1.1 .. SUMMARY ILLUSTRATION OF THE ENVIRONMENTAL REPORT (ER) ....................................................... 1 1.2 .. FINDING CONTENTS OF ANNEX V) TO THE LEG. DECREE 152/2006 IN THIS ER ....................................... 2 2 THE SEA PROCESS IN THE INFRASTRUCTURE ANNEX .........................................................4 2.1 .. REGULATORY REFERENCES FOR SEA AND VINCA ............................................................................. 4 2.2 .. CONTRIBUTIONS PROVIDED BY SUBJECTS WITH COMPETENCE ON THE ENVIRONMENT (SCA) DURING THE PRELIMINARY CONSULTATION PHASE. ............................................................................................ 5 3 ILLUSTRATION OF INFRASTRUCTURE ANNEX .................................................................. 23 3.1 .. NATURE OF THE INFRASTRUCTURE ANNEX IN THE FRAMEWORK OF A DEVELOPING PROGRAMME ............... 23 3.2 .. THE CONTENTS OF THE INFRASTRUCTURE ANNEX TO THE ECONOMIC AND FINANCE DOCUMENT 2015 ........ 24 4 THE ADOPTED ASSESSMENT MODEL .............................................................................. 27 4.1 .. MAIN METHODOLOGICAL REFERENCES ......................................................................................... -

Gli Orti Botanici Universitari
Pignatti pag 79-89_RIVISTA ANMS DEF 08/04/11 14:07 Pagina 79 MUSEOLOGIA SCIENTIFICA MEMORIE • N. 7/2011 • 79-89 Musei Scientifici Universitari. Una grande risorsa culturale da valorizzare. Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 6 maggio 2009 a cura di Ernesto Capanna, Giancarla Malerba, Vincenzo Vomero Gli Orti Botanici Universitari Sandro Pignatti Orto Botanico, Università di Roma “La Sapienza”, largo Cristina di Svezia, 24. I-00165 Roma. E-mail: [email protected] RIASSUNTO I primi orti botanici universitari sono stati fondati in Italia nel sec. XVI e quello di Padova (Hortus Primigenius sec. Linneo) è ora Sito Patrimonio dell’Umanità. Si delinea lo sviluppo storico degli orti botanici universitari come istituti di insegnamento e ricerca, in Italia e nel mondo, in parallelo con lo sviluppo dell’architettura dei giardini (giardino all’italiana, alla francese, all’inglese) e le relazioni tra orti botanici e giardini. La missione dell’orto bota- nico ha subito una continua evoluzione da struttura didattica a luogo di ricerca ed ora tende (sul modello dei mag- giori orti botanici mondiali) a concentrarsi soprattutto sull’educazione ambientale. Parallelamente, l’utenza si è allargata, dagli studenti di materie mediche ai naturalisti e ricercatori, ed ora ad una componente sempre più ampia della comunità locale. Viene analizzato se - ed entro quali limiti - gli orti botanici universitari in Italia siano in grado di assolvere i nuovi compiti che si stanno delineando. Una discussione non conformista mette in luce gravi carenze e problemi irrisolti (primo tra tutti la necessità di uno o due orti botanici di vero livello internazio- nale), ma anche sviluppi interessanti, dovuti soprattutto all’iniziativa e creatività di singoli. -

I Musei Scientifici E L'orto Botanico Dell'università Di Padova
Minelli pag 69-78_RIVISTA ANMS DEF 08/04/11 14:06 Pagina 69 MUSEOLOGIA SCIENTIFICA MEMORIE • N. 7/2011 • 69-78 Musei Scientifici Universitari. Una grande risorsa culturale da valorizzare. Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 6 maggio 2009 a cura di Ernesto Capanna, Giancarla Malerba, Vincenzo Vomero I Musei scientifici e l’Orto Botanico dell’Università di Padova Alessandro Minelli Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Padova, via Ugo Bassi, 58 B. I-35131 Padova. E-mail: [email protected] RIASSUNTO Il giardino botanico dell’Università di Padova, fondato nel 1545, è il più antico del mondo. Era originariamente dedicato alla coltivazione di piante di importanza medica e all’insegnamento della botanica in relazione alla medicina. Fra i direttori dell’istituzione, i primi a studiare le piante come oggetti di storia naturale, piuttosto che come fonti di medicinali, sono stati Giulio Pontedera (praefectus Horti 1719-1757) e Giovanni Marsili (praefec- tus Horti 1760-1794). L’Orto ospita la palma di Goethe, piantata nel 1585. Un erbario di fanerogame, alghe e funghi è annesso. Le altre collezioni naturalistiche derivano dal museo di Antonio Vallisneri (inizio sec. XVIII), donato all’Università da suo figlio, il primo ad occupare la cattedra di Storia Naturale istituita nel 1734. Musei dedicati alle singole discipline sono derivati da esso quando sono state istituite le cattedre corrispondenti: Zoologia e Anatomia Comparata nel 1869, Geologia nello stesso anno, ma poi divisa nel 1880 in Geologia e Mineralogia; Antropologia nel 1904. Ci sono anche importanti collezioni che riguardano la medicina, l’astrono- mia, la geografia, la fisica, l’ingegneria, e collezioni molto importanti di manoscritti e libri antichi, in particolare nel campo della medicina e della botanica, oltre ad una raccolta di biologia marina presso la stazione di biologia marina di Chioggia. -

Siti Unesco in Italia
SITI UNESCO IN ITALIA Di seguito sono elencati i siti Unesco in ordine cronologico di assegnazione: 1. Arte rupestre della Val Camonica (1979) 25. Porto Venere, le Cinque Terre e le isole di 2. Chiesa e convento domenicano di Santa Palmaria, Tino e Tinetto (1997) Maria delle Grazie con L’ultima cena di 26. Costiera amalfitana 1997( ) Leonardo da Vinci, Milano (1980) 27. Area Archeologica della Valle dei Templi di 3. Centro storico di Roma, le proprietà Agrigento (1997) extraterritoriali della Santa Sede nella città e 28. Area archeologica e Basilica Patriarcale di la Basilica di San Paolo fuori le mura (1980- Aquileia (1997) 1990). Estensione del Patrimonio di Roma ai 29. Centro storico di Urbino (1998) beni compresi entro le mura di Papa Urbano VII (1990) 30. Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la 4. Centro storico di Firenze (1982) Certosa di Padula (1998) 5. Venezia e la sua Laguna (1987) 31. Villa Adriana a Tivoli (1998) 6. Piazza del Duomo di Pisa (1987) 32. Città di Verona (2000) 7. Centro storico di San Gimignano (1990) 33. Isole Eolie (2000) 8. Sassi e Parco delle Chiese Rupestri di Matera 34. Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti (1993) francescani (2000) 9. Città di Vicenza e le Ville del Palladio (1994- 35. Villa d’Este a Tivoli (2001) 1996) 36. Città tardo barocche della Val di Noto (Sicilia 10. Centro storico di Siena (1995) sud-orientale) (2002) 11. Centro storico di Napoli (1995) 37. Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia 12. -

Scarica La Brochure
VERSIONE ITALIANA Per maggiori informazioni www.mirabilianetwork.eu Brindisi Genova La Spezia Matera Messina Padova Perugia Salerno Udine Vicenza Una rete che mette in collegamento luoghi inaspettati di significato storico, culturale ed ambientale nei siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO MIRABILIA - EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES Con il Patrocinio di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo Promozione dei siti UNESCO, dei territori e dei percorsi a cura delle Camere di Commercio MIRABILIA - EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES IL PARTENARIATO Le Camere di Commercio a sistema per la promozione del turismo culturale a livello internazionale BRINDISI GENOVA LA SPEZIA MATERA MESSINA PROMOBRINDISI WTC GENOA CAMERA DI COMMERCIO DELLA CESP - CENTRO SERVIZI PER LE CAMERA DI COMMERCIO DI Azienda Speciale della Camera di Azienda Speciale della Camera di SPEZIA PICCOLE E MEDIE IMPRESE MESSINA Commercio di Brindisi Commercio di Genova per Tel: +39 0187 728264 Azienda Speciale della Camera di Tel. +39 090 7772222 Tel: +39 0831 562994 l'Internazionalizzazione Email: [email protected] Commercio di Matera Email: Email: [email protected] Tel: +39 010 23591 Web: www.sp.camcom.it Tel. +39 0835 338441 [email protected] Web: www.promobrindisi.com Email: [email protected] Web: www.speziafiere.it Email: [email protected] Web: www.me.camcom.it Web: www.wtc.genova.it Web: www.cesp.it PADOVA PERUGIA SALERNO UDINE VICENZA PADOVA PROMEX CAMERA DI COMMERCIO DI INTERTRADE CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE CONSORZIO VICENZA È Azienda Speciale della Camera di PERUGIA Azienda Speciale della Camera di Azienda Speciale Imprese e Territorio Tel: +39 0444 994770 Commercio di Padova Email: [email protected] Commercio di Salerno - Area Marketing I.ter Email: [email protected] Territoriale Tel. -

Six Papiruses from the Turin Egyptian Museum by Davide Mana
Six papiruses from the Turin Egyptian Museum by Davide Mana Originally presented as final activity for the MOOC “Ancient Egypt: A history in six objects” by the University of Manchester 2015 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/. Introduction This project focuses on a number of artifacts from the collections of the Museo Egizio (Egyptian Museum) in Turin, Italy. The choice of the Museo Egizio as a source of the materials covered in this article is twofold. The scientific reason is, the Museo Egizio is considered the second most important collection of Egyptian artifacts in the word, after the Cairo Museum. The Museum holds a number of unique pieces, some of which will be featured in this article. There is also a sentimental reason for the choice: the author grew up in Turin, and spent many hours as a kid in the halls of the Egyptian Museum, developing a life-long interest for the history and archeology of Egypt. The Egyptian Museum in Turin, an overview. The House of Savoy fascination for Egyptian antiquities predates the foundation of the museum in Turin; the first items in what was to become the museum collection were excavated in 1759 by Vitaliano Donati, and presented as gift to king Charles Emmanuel III. The Museo Egizio proper was founded by King Charles Felix of Savoy 1824, after the crown acquired the collection of Egyptian artifacts belonging to Bernardino Drovetti, amateur antiquarian and French consul in Egypt under Napoleon. -

Lista Dei Patrimoni UNESCO ITALIA
Lista dei patrimoni dell'umanità in Italia Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Vai a: navigazione , ricerca Voce principale: Lista dei patrimoni dell'umanità . Mappa della concentrazione dei siti Unesco in Italia, sono esclusi i siti condivisi con altri stati. La lista dei patrimoni dell'umanità in Italia è un elenco di tutti i patrimoni dell'umanità , riconosciuti dall' UNESCO , presenti sul territorio italiano, suddivisi per regione di appartenenza. La lista comprende i 51 siti fisici (tangibili), i 6 Patrimoni orali e immateriali dell'umanità e i 6 beni inseriti nel Registro della Memoria del Mondo . Alcuni di questi patrimoni sono condivisi tra più regioni o anche con altri stati esteri. Pertanto, nell'elenco di ogni regione, viene riportata solamente la parte del patrimonio effettivamente localizzata in quella determinata regione con, tra parentesi, il comune (o i comuni) di appartenenza. La lista è aggiornata al 3 luglio 2015. Patrimoni dell'umanità ITALIA per regione : I Sassi di Matera Abruzzo [modifica | modifica wikitesto ] Nessun patrimonio . Basilicata [modifica | modifica wikitesto ] • I Sassi e il parco delle chiese rupestri di Matera (Matera ) - 1993 • Parco nazionale del Pollino - 2015 (Potenza, Matera, Cosenza) Calabria [modifica | modifica wikitesto ] • Parco Nazionale del Pollino - 2015 (Potenza, Matera, Cosenza) Campania [modifica | modifica wikitesto ] La Reggia di Caserta La Costiera amalfitana • Centro storico di Napoli - 1995: o Centro storico di Napoli (Napoli ); o Parco di Capodimonte e Reggia di Capodimonte (Napoli); o Castel Sant'Elmo (Napoli); o Certosa di San Martino (Napoli); o Villa e Parco Floridiana (Napoli); o Villa Rosebery (Napoli); o Villa comunale di Napoli (Napoli); o Real Orto Botanico (Napoli); o Distretto di Villa Manzo , Santa Maria della Consolazione (Napoli); o Marechiaro (Napoli); o Distretto del Casale e Santo Strato (Napoli). -

BSTS Newsletter No. 70
WHAT ELSE TO DO IN TURIN As we all know, the Shroud will be on show in May next year – speaking from past experience, it is well worth making the effort to visit Turin and see the cloth we are all interested in with our own eyes. However, this is not all there is to do in Turin: and so my intention here is just to take a quick look at some of the other things to do in the city apart from seeing the Shroud itself. There is of course the Shroud museum, which has figured in past articles in the newsletter. This is of course a must if you go to Turin to see the Shroud. The museum was born in 1936 to run through the history of the cloth in which Jesus' mortal remains were reputedly placed, scientific research on the image and the relics kept by the Confraternity of the Shroud. The new museum was opened on 15 April 1998. Now the crypt is lit up by virtual frescoes of the Passion, screened by 15 machines onto the vault and niches, continuously following the visitor. Visitors to the museum can see the official plates of the photographs taken by Secondo Pia in 1888 and those taken in 1931 by Giuseppe Enrie, on which were based the first scientific investigations. They reach their peak in the amazing three- dimensional image of the face of the Holy Shroud, elaborated by Giovanni Tamburelli in 1978. A large space is dedicated to further studies on the material and on its weaving, on the micro-marks (pollen, blood, aloe, myrrh, aragonite), on forensic investigation, on the prints of the coins left on the cloth on the iconographic analysis. -

Siti UNESCO Italiani (53, in Ordine Cronologico) E Descrizione Dei Criteri Per Cui Sono Stati Selezionati Ed Iscritti Nella Lista Del Patrimonio Mondiale UNESCO
Siti UNESCO Italiani (53, in ordine cronologico) e descrizione dei criteri per cui sono stati selezionati ed iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO Sommario VALLE CAMONICA – L’Arte Rupestre (1979).................................................................................................................................................................. 2 MILANO – Il “Cenacolo” di Leonardo da Vinci in Santa Maria delle Grazie (1980) .................................................................................................... 2 ROMA –Centro storico di Roma, le Proprietà Extraterritoriali della Santa Sede nella Città e San Paolo fuori le Mura (1980-1990) .................... 2 FIRENZE – Il Centro Storico (1982) ................................................................................................................................................................................. 3 PISA – La Piazza del Duomo (1987) ................................................................................................................................................................................ 4 VENEZIA E LA SUA LAGUNA (1987) ................................................................................................................................................................................ 4 SAN GIMIGNANO – Il Centro Storico (1990) .................................................................................................................................................................. 5 MATERA – -

Botanical Garden: Il Giardino Della Biodiversità
BOTANICAL GARDEN PADOVA IL GIARDINO DELLA BIODIVERSITÀ Progetto di VS Associati. Testo di Giorgio Strappazzon Con un percorso avviato nel 2010 sono stati The recently inaugurated restoration and expansion inaugurati, lo scorso ottobre, l’ampliamento e il of the oldest Botanic Garden in the world, was restauro del primo Orto Botanico universitario esistente initiated in 2010, eight years after the design al mondo. Patrimonio dell’Unesco, l’Orto Botanico di competition was held. A World Heritage Patrimony, Padova è stato oggetto di un ambizioso progetto the Padua Botanic Garden was the subject of an promosso dall’Università e realizzato dallo studio ambitious makeover promoted by the University and vicentino VS Associati. Con il recupero delle visuali designed by the the competition winners, VS prospettiche verso la città e l’inserimento di cinque Associati of Vicenza. With the recovery of visual nuove serre nel contesto di un paesaggio che recupera corridors towards the city and five new green houses l’antico reticolo agricolo urbano, il “Giardino della inserted in landscape using the ancient urban biodiversità” lancia una sfida alla modernità, agricultural rectangle, the new botanic garden completando l’offerta con tecniche di divulgazione challenges the future and includes modern didactic scientifica sia in situ sia digitali, con le quali si prepara and scientific techniques, both onsite and digital. The a diventare punto di attrazione anche per i percorsi di Botanic Garden will no doubt be an attraction for visita legati all’Expo 2015. visitors to the upcoming Expo 2015. 102 TOPSCAPE 15 Nella pagina precedente: Progettisti VS Associati Studio fondato nel 1992 i cui soci, gli architetti Fabrizio Volpato e Giorgio vista complessiva della “Vetrina Strappazzon, proseguono tuttora la loro collaborazione professionale. -

Europe: a History of Medicine & Pharmacy
Europe: A History of Medicine & Pharmacy 11 SEP – 3 OCT 2015 Code: 21528 Tour Leaders Em. Prof. Robert Clancy AM, Christine Clancy, David Henderson Physical Ratings A sweeping history of medieval to modern medicine visiting historic hospitals & pharmacies, universities, lazarettos, libraries and museums weaving together developments in medical & art history. Overview Tour Highlights Travel with Emeritus Professor Robert Clancy AM, Christine Clancy and art history lecturer David Henderson who will highlight many aspects of the interaction of medicine, pharmacy and art. A comprehensive program presenting a thorough history of European medicine in tandem with a rich investigation of some of the greatest styles of European art from the Renaissance to French Impressionism and early Modernism. Visits to many of Europe's most famous and historic medical institutions, many of which are rarely visited by travellers, such as Venice's San Servolo Psychiatric Hospital, the Anatomy Theatre in Padua, the Ospedale di Santa Maria Nuova and the Ospedale degli Innocenti, Florence, the Hôtel- Dieu, Beaune, the Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu-le-Comte, Troyes, the Old Operating Theatre (St Thomas' Hospital) and Apothecaries' Hall in London. Lectures by and meetings with eminent authorities on the history of medicine, such as Professor Donatella Lippi, Director of the Centre of Medical Humanities, University of Florence. A thorough exploration of the contribution of botany to medicine and pharmacy through visits to a number of the world's oldest and most famous botanical gardens at Pisa, Montpellier and the Chelsea Physic Garden. Insights into the very latest research in medical archaeology including the investigation of the Quarantine Island of Venice Fine dining in renowned urban and rustic restaurants including Restaurant Mirazur, Menton, La Petite Maison de Cucuron, Les Ombres Restaurant and La Coupole, Paris and 2 Veneti Restaurant, London.