Migranti Africani Di Castel Volturno
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Elettorato Attivo Del Dip. Di Giurisprudenza Al 21 05 2018
Codice Corso Cognome Nome Data nascita Comune nascita 068 ATRIA VANIA 30/08/1974 NAPOLI 068 MATERAZZO FERDINANDO 16/01/1956 CASERTA 068 TOSCANO MAURA 10/09/1968 PIETRAMELARA 068 PERSICI ROSA 01/04/1975 NAPOLI 068 PALMIERI ROSITA 22/04/1974 CASERTA 068 ORIO LUCIA 10/02/1975 MADDALONI 068 DELLA MEDAGLIA ANGELINA 21/08/1974 RECALE 068 CIMMINO ERNESTO 12/04/1974 CASERTA 068 ROLLI ELVIRA 03/10/1974 CASERTA 068 VILLANO ANGELA 07/08/1975 NAPOLI 068 CAPUANO ANTONIO 02/07/1972 MONDRAGONE 068 MONTESANO ANTONIO 25/09/1973 CASERTA 068 MARTONE ROSA 20/09/1972 PORTICO DI CASERTA 068 TESSARI PAOLA 15/07/1967 NAPOLI 068 TAGLIAFIERRO ORNELLA 25/07/1971 CASERTA 068 DI SALVO DIEGO GIANLUIGI 02/08/1975 CONCA DELLA CAMPANIA 068 BASCO GIUSEPPINA 11/05/1976 SAN MARCELLINO 068 CASSANDRA ERNESTO 29/10/1968 CASERTA 068 LAURENZA MARIANNA 13/07/1976 FORMIA 068 CAPALDO MONICA 30/04/1976 NAPOLI 068 GRIMALDI ANTONELLA 26/05/1975 CAPUA 068 CIARAFFA ASSUNTA 22/01/1976 CASERTA 068 GELOSO MARIA PIA 16/07/1975 CASERTA 068 TAVETTA ROSSELLA 04/03/1976 NAPOLI 068 ZITO ANTONELLA 12/09/1974 CASERTA 068 VERAZZO DANIELA 30/04/1976 CASERTA 068 D'ELIA RAFFAELLA 18/10/1973 CASERTA 068 FUOCO VALERIA 05/12/1974 CARATE BRIANZA 068 MAIONE EMMANUEL 15/04/1974 CASERTA 068 DI FRATTA LUCIA 05/07/1976 CASERTA 068 BALBO AIDA 22/05/1976 CASERTA 068 MARATTA ANGELA 21/12/1976 FORMIA 068 DIOMAIUTO ANNA 04/10/1976 AVERSA 068 GRIMALDI GIANCARLO 01/09/1966 CAPUA 068 DI SALVO ANGELOMARIO 01/02/1976 AVELLINO 068 CAVALLO ALDO 07/10/1975 CASERTA 068 FLORIO CARMELA 01/05/1976 CAPUA 068 CARFORA MARIA 18/10/1976 -

Campania – Curiosando Nel Parco Del Matese
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA Unpli SCN cod. Accr. UNSC NZ01922 Ufficio per il Servizio Civile Nazionale Via Roma,21 - 83020 Contrada (Av) ENTE 1) Ente proponente il progetto: UNPLI NAZIONALE 2) Codice di accreditamento: EZ01922 3) Albo e classe di iscrizione: NAZIONALE 1 1 CARATTERISTICHE PROGETTO 4) Titolo del progetto: CURIOSANDO NEL PARCO DEL MATESE 5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E-10 INTERVENTI DI ANIMAZIONE NEL TERRITORIO 6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE Questo progetto prevede un lavoro integrato tra le Pro Loco sedi di servizio civile della provincia di Caserta afferenti all’UNPLI, ente proponente del progetto. L’UNPLI è iscritta nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale - legge 7 dicembre 2000, n.383, all’Albo nazionale del Servizio Civile Nazionale - Legge 6 marzo 2001, n. 64. ed è inoltre riconosciuta dalla Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO quale Associazione che persegue con forte impegno, la promozione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Dell’Unione Pro Loco d’Italia oggi è ampiamente riconosciuto e valorizzato il ruolo sociale da parte del Ministero della Solidarietà Sociale, del Ministero dei Beni Culturali, da quello degli Interni e dalla Presidenza del Consiglio, con i quali intrattiene continui e fruttuosi rapporti di collaborazione. L’UNPLI conta oggi circa 600.000 soci suddivisi in più di 6.000 Pro Loco iscritte in tutta Italia, delle quali 101 registrate al 2017 nella sola provincia di Caserta. -

Decreto Dirigenziale N. 35 Del 22/12/2017
n. 93 del 27 Dicembre 2017 Decreto Dirigenziale n. 35 del 22/12/2017 Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo Oggetto dell'Atto: D.D. 1281/2016 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI PROPRIETA' PRIVATA - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E CONFERMA PRENOTAZIONI DI IMPEGN0 fonte: http://burc.regione.campania.it n. 93 del 27 Dicembre 2017 IL DIRIGENTE PREMESSO a. che l’art. 11 della L. 24/06/09 n.77 (conv. D.L. n. 39 del 28/04/2009) ha istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico, assegnando alla Regione Campania una risorsa complessiva pari ad € 122.974.623,56; b. che l’attivazione della seconda annualità (2011) è avvenuta con la pubblicazione dell’OPCM n. 4007 del 29/02/12 (G.U. n. 56 del 07/03/12) e l’emanazione del DPCM del 16/03/12 (G.U. n.138 del 15/06/12), con cui è stata assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria di € 19.319.249,71 di cui 17.939.303,30 agli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica e edifici privati - lett. b) e c); c. che per l’annualità 2011 la Regione Campania ha approvato la D.G.R. n.118 del 27/05/13 (BURC n.29 del 03/06/13), con cui è stata determinata la ripartizione delle risorse assegnate dal Dipartimento alla Regione Campania, per le tre tipologie di interventi – art. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie
Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -

Comune Di Mignano Monte Lungo Provincia Di Caserta
Comune di Mignano Monte Lungo Provincia di Caserta PUC (ai sensi della LR.n.16/2004 e regolamento d'attuazione n.5/2011) sindaco dr. Antonio Verdone resp. ufficio di piano geom. Carmine Mariotti i progettisti arch. Cinzia Della Cioppa ing. Mariano Negri collaboratore studio arch. della Cioppa : arch. Antonio Rocchio studi tematici: Q4 Q1 Stazzi arch. Antonia Iride studio acustico Moscuso geol. Giuseppe D'Onofrio studio geologico MIGNANO MONTE LUNGO agrm. Umberto Camparone studio agronomico Q3 Q2 Campozillone Casale Annolise Caspoli arch. Daria Dellino vas e vi Pietrocolle RP.A0 scala 1:100.000 Rapporto Ambientale scala 1:10.000 scala 1:5.000 0.0 INTRODUZIONE 3 1.0 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 4 1.1 Quadro normativo di riferimento .....................................................................................................4 1.2 Metodologia utilizzata nella redazione del Rapporto ambientale .................................................6 1.3 Resoconto della fase di scoping. Modalità ed esiti del processo partecipativo .........................7 2.0 - IL PIANO URBANISTICO COMUNALE: ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO E DEL RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI (PUNTO A, ALL. VI D.LGS. 4/2008) 11 2.1 - Riferimenti normativi .................................................................................................................... 11 2.2 - Gli obiettivi generali del PUC ....................................................................................................... 12 -

Carta Dei Servizi
Carta dei Servizi Teano Ente Capofila, Caianello, Cellole, Conca della Campania, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pietravairano, Presenzano, Roccamonfina, Rocca D’Evandro, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Tora e Piccilli e Vairano Patenora. Presentazione La riforma del welfare locale, basata su una gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali, è stata perseguita da tutti i soggetti dell’Ambito territoriale C03 in modo forte e deciso. E ’ stato avviato, infatti, con un processo, innanzitutto culturale, di attenzione alle politiche sociali non più pensate come una somma di interventi generalizzati, ma come sistema capace di lavorare per la garanzia dei diritti, la qualità dei servizi, la tutela dei minori e la crescita responsabile delle comunità. I nostri interventi hanno mirato e continueranno a mirare ad accompagnare gli individui e le famiglie lungo tutto il corso della vita, riconoscendone i bisogni legati alle diverse fasi e a particolari circostanze biografiche, sostenendo e promuovendo le capacità individuali e delle reti familiari, nonché favorendo le iniziative di aiuto e di mutuo soccorso. La programmazione sociale messa in atto dai Comuni e dagli Ambiti territoriali rappresenta un periodo intenso per le opportunità che offre ai sistemi locali di ripensare la struttura del welfare. Ma è molto intenso anche per i forti cambiamenti che ha portato con sé e per i processi di innovazione organizzativa e procedurale che ha attivato nei sistemi amministrativi locali, consentendo una sostanziale rivisitazione delle funzioni di programmazione e monitoraggio delle politiche sociali ed un forte rinnovamento dei rapporti tra gli Enti locali e tutti i soggetti del Terzo Settore, gli altri soggetti privati e le altre istituzioni pubbliche. -

68; Residente in Via D. Santoro, N° 17, Marcianise (CE) - CAP 81025; Tel
Curriculum CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DEL DOTT. D'ADDIO FRANCESCO Nato a Caserta il 04/11/'68; residente in via D. Santoro, n° 17, Marcianise (CE) - CAP 81025; tel. 0823/825819, cell. 340/2825270; e-mail [email protected]. Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli in data 09/11/'95 con voti 110/110 e lode. Tirocinio Post-Laurea svolto presso l'Ospedale "Incurabili" di Napoli. Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo nella Seconda Sessione dell'anno 1995 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caserta in data 16/01/'96 (numero d'ordine 5109). Specializzazione in Medicina Interna - indirizzo Medicina d'Urgenza presso la Seconda Università degli Studi di Napoli in data 14/11/'00 con voti 50/50; formazione specialistica teorico-pratica presso la VI Divisione di Medicina Interna e Immunoallergologia della Seconda Università e presso il Pronto Soccorso e la Divisione di Medicina d'Urgenza dell'Ospedale San Paolo di Napoli. Iscritto alla "Società Italiana di Immunologia e Immunologia Clinica" (SIIIC) negli anni 1998 e 1999, alla "Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica" (SIAIC) negli anni 2000, 2001 e 2002, all’“Associazione Allergologi ed Immunologi Territoriali ed Ospedalieri” (AAITO) nell’anno 2003; alla "Federazione delle Associazioni degli Internisti Ospedalieri" (FADOI) dall'anno 2006. Partecipazione a Convegni e Seminari Scientifici di argomento Internistico (Cardiologia, Allergologia ed Immunologia Clinica, Pneumologia, Gastroenterologia ed Epatologia, Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Reumatologia, Medicina d'Urgenza). Lavori scientifici di argomento allergologico, immunologico e diabetologico, pubblicati in forma di abstract ed in extenso negli atti congressuali di Società Scientifiche o su riviste scientifiche italiane. -

Si Invita La Gentile Utenza a Consultare La Sezione "Avvisi Al Pubblico"
Orario in vigore dal 01.09.2021 02 - CE - CASERTA F.S. - RECALE - CAPODRISE - MARCIANISE - PORTICO DI CASERTA - MACERATA - SANTA MARIA CAPUA VETERE Orari validi nei giorni feriali Periodo CA6 CA6 CA6 CA6 CA6 CA6 CA6 CA6 CA6 CS1 CA6 CS1 CA6 CA6 CA6 CA6 CA6 CA6 CA6 CA6 Cadenza FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 FE6 Fermata CASERTA, VIA CILEA - I.P.S.I.A. (IST. ALBERGHIERO "G. FERRARIS") 13.10 14.15 VIA BORSELLINO - VIA S. AUGUSTO I.T.I.S. "GIORDANI" 13.15 14.18 CASERTA, STAZIONE F.S. 5.45 6.30 7.20 8.30 9.30 10.30 11.30 12.40 13.20 13.35 14.20 14.35 15.30 16.35 17.30 18.30 19.30 20.35 21.20 SOTTOPASSO VIALE CARLO III - RAMPA AUTOST. MARCIANISE - VIALE EUROPA SOTTOPASSO VIALE CARLO III - VIA PONTESELICE (M.T.C.) (DX) 5.49 6.34 7.25 8.35 9.35 10.35 11.35 12.45 13.25 13.40 14.25 14.40 15.35 16.40 17.35 18.35 19.35 20.40 21.25 RECALE, VIA ROMA - PIAZZA MATTEOTTI 5.53 6.38 7.30 8.40 9.40 10.40 11.40 12.50 13.30 13.45 14.30 14.45 15.40 16.45 17.40 18.40 19.40 20.45 21.30 VIA S. SALVATORE (IN FONDO A DX) - VIA MUNICIPIO (SX) 5.55 6.40 7.33 8.43 9.43 10.43 11.43 12.53 13.33 13.48 14.33 14.48 15.43 16.48 17.43 18.43 19.43 20.48 21.33 CAPODRISE, VIA SANTA CROCE - PIAZZA DE FILIPPO 5.57 6.42 7.35 8.45 9.45 10.45 11.45 12.55 13.35 13.50 14.35 14.50 15.45 16.50 17.45 18.45 19.45 20.50 21.35 VIA GIANNINI - MARCIANISE, VIA G. -

Daily Eastern News: January 15, 2009 Eastern Illinois University
Eastern Illinois University The Keep January 2009 1-15-2009 Daily Eastern News: January 15, 2009 Eastern Illinois University Follow this and additional works at: http://thekeep.eiu.edu/den_2009_jan Recommended Citation Eastern Illinois University, "Daily Eastern News: January 15, 2009" (2009). January. 4. http://thekeep.eiu.edu/den_2009_jan/4 This Article is brought to you for free and open access by the 2009 at The Keep. It has been accepted for inclusion in January by an authorized administrator of The Keep. For more information, please contact [email protected]. “TELL THE TRUTH AND DON’T BE AFRAID” WWW.DENNEWS.COM EASTERN ILLINOIS UNIVERSI T Y , C H A R L E S T ON The DAILY EASTERN NEWS THURSDAY, JANuaRY 15, 2009 VOL. 93 | ISSUE 78 CitY | Roads Salt prices climb to record levels Street department limits salting to stop-intersections, main arteries in city By JOE ASTROUSKI City Editor As another snowstorm blows across central Illinois, road crews are busy clearing streets in Charles- ton. But with a recent spike in the price of road salt and a shrinking salt supply, that process may take longer than usual. “The road conditions aren’t going to clear up as quickly,” said Quincy Combs of the Charleston Street Department. “We’ve really had to conserve (salt).” Before last year’s snow sea- son, one ton of road salt cost $49, Combs said. At the beginning of this season, that price had climbed to $90.50 per ton and is now near $168 per ton. To reduce salt use, Combs said the city is salting only targeted streets and intersections. -

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Indirizzo COLLOCATI a RIPOSO (ART
N.B. - A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo e data di nascita PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Indirizzo COLLOCATI A RIPOSO (ART. 7) Con decreti in data 23 gennaio 2008 Commendatore Ciocci Sig.ra Maria Rosaria Forano 24/05/1942 Pulcinelli Sig. Giulio Cristoforo Ronciglione 13/01/1941 Sabatino Dott. Francesco Borgia 15/09/1940 Ufficiale Piasenti Sig.ra Renata Fiume 03/04/1946 Cavaliere Marini Sig. Giovanni Roma 27/07/1940 Torelli Sig. Enzo Castiglione del Lago 06/03/1944 Con decreti in data 2 giugno 2008 Cavaliere di Gran Croce Di Martino Dott. Vincenzo La Spezia 16/02/1933 Fiduccia Dott. Gaetano Firenze 27/08/1932 Scandurra Dott. Giuseppe Messina 07/05/1932 Grande Ufficiale Bruni Avv. Italo Catanzaro 21/10/1940 Vitale Rag. Silvestro Silvio Carlentini 31/03/1941 STRANIERI (ART. 7) Con decreti in data 2 giugno 2008 Cavaliere di Gran Croce Matsubara S.E. Sig.ra Nobuko Tokio 09/01/1941 Taccetti S.E. Victorio Maria José Buenos Aires 22/01/1943 Commendatore Fox Dott. Richard J. New York 24/02/1947 Pagina 1di 29 Indirizzo Metzger Ing. Jean-Marie Clichy 11/07/1951 Thellier-Thompson Sig. Gilles Boulogne sur Mer 24/06/1957 Cavaliere Clerc Sig. Alain Tunisi 19/11/1942 NORMALI Con decreti in data 2 giugno 2008 Cavaliere di Gran Croce Armellini Sig. Manlio Porto San Giorgio 09/10/1937 Cabigiosu Gen. C. d' A. Carlo Brunico 22/06/1939 Courtial Dott. Hans Albert Dietkirchen 17/05/1946 Di Fonso Dott. Aldo Lorenzo Pettorano sul Gizio 10/08/1932 Manganelli Dott. -

Comune Portico Di Caserta= 154.40
Giuseppe Oliviero PC: Portico 154.40 (UTC) Aa023 07 07:39 (UTC) Comune di Caserta=Organizzazione CA ArubaPEC S.p.A. ay maiEA SRL ORDINANZA DEL SINDACO N. 17 DEL 23-11-2020 OGGETTO0: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA PER LA sCUOLA DELLL'INFANZIA E DELLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA L'anno duemilaventi addi ventitre del mese di novembre, il Sig. Oliviero Giuseppe, nella sua qualità di SINDAC0, Premesso che: con Ordinanza del Ministro della Salute la Regione Campania è stata classificata come zona ad alto rischio di contagio (zona rossa); - con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15.11.2020 si disponeva la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia e la prima classe della scuola primaria (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) al 24.11.2020; Rilevato che: - nel territorio comunale ricorre purtroppo una documentata ascesa del contagio da Sars 2 Covid 19 per cui, in base al principio di precauzione, è necessario adottare ogni misura necessaria al contrasto ed al contenimento della diffusione del Virus COVID-19 nel territorio comunale; - appare, altresi, opportuno consentire al personale docente e non docente. agli alunni e ai loro genitori, nonché ai loro familiari conviventi di effettuare. su base volontaria, i tamponi antigenici cosi come previsto e favorito dalla predetta ordinanza regionale a far data dal 24.11.2020; Visti il D.P.C.M. del 03.11.2020; .l'Ordinanzadel Ministero della Salute del 13.11.2020; .l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sullr Ordinamento degli Enti Locali. -
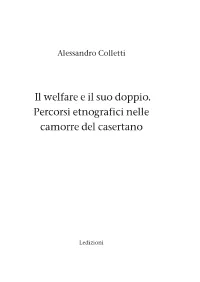
Il Welfare E Il Suo Doppio. Percorsi Etnografici Nelle Camorre Del Casertano
Alessandro Colletti Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano Ledizioni © 2016 Ledizioni LediPublishing Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy www.ledizioni.it [email protected] Alessandro Colletti, Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano Prima edizione: febbraio 2016 ISBN Cartaceo: 978-88-6705-426-8 Copertina e progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni I ricavi dai diritti d’autore saranno devoluti al Comitato Don Peppe Diana di Casal di Principe Indice Prefazione di Antonio La Spina 5 Introduzione 11 Metodi e fonti 17 Parte Prima. Un’analisi delle forme di egemonia delle mafie: tra controllo e assistenza 27 1. Il controllo territoriale nella storia delle camorre 29 Il riconoscimento istituzionale del potere camorrista 34 Il controllo territoriale nell’area campana 39 2. Forme organizzative e redistributive: la “cassa comune” 49 Le mafie come organizzazioni professionali 50 Il funzionamento della “cassa comune” 53 I capi cambiano, la struttura resta: dal “clan Bardellino-Iovine” al “clan dei casalesi” 63 3. La protezione sociale delle camorre casertane 73 Il clan La Torre 76 Il clan Belforte 82 I clan Schiavone e Bidognetti: alleati, federati, separati 89 Gerarchia e livelli stipendiali: il clan Schiavone 94 Forme di assistenza nei clan del casertano 101 Parte Seconda. Le politiche socio-assistenziali nella provincia di Caserta: un welfare (s)finito 113 1. Analisi delle forme di welfare pubblico: il sistema italiano 115 I territori del welfare: dallo Stato agli enti locali 118 Il livello territoriale dei servizi sociali 123 2. Zona di contatto: servizi alla persona nella provincia casertana 135 La dimensione territoriale dei servizi nella governance regionale 140 Uno sguardo alle pratiche locali di welfare nell’area casertana 143 Il welfare raccontato da chi lo dirige: le interviste ai coordinatori degli Uffici di Piano 148 3.