Itinerari Alessiani
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Virtual Train Journey Along the Mare Ligure from Ventimiglia to Rome
Italian Culture Newsletter Number 22 A Virtual Train Journey along the Mare Ligure from Ventimiglia to Rome. Marie and I have made this journey on a number of occasions. In doing so we have either made the journey in a single day albeit with a change of train, usually at Genova. On other occasions, we have spent an evening or even a few days at Genova and/or at Livorno or Pisa. The journey described will involve more stops on the way but could be more interesting on that account. The trip begins in Ventimiglia where we stayed overnight on our last day of our last holiday in Italy. This had been occasioned by the French railway strike which prevented any trains from running from Ventimiglia to Nice on the day of our arrival from Rome into the city at the Italian- French border in Liguria. Our first visit to Ventimiglia was in 2006 when some Italian friends from Cuneo, due north of Ventimiglia, in Piemonte, met us at the rail station in Ventimiglia to take us for a short stay at their apartment in Nice. On that occasion we didn’t see much of the city except for part of the old medieval town, which now mostly is the home of many of the southerners from Naples, Calabria and Sicily who moved north seeking employment after WWII. The old town is perched high above the new city with its long sea-front promenade and railway station. Ventimiglia is the ancient Albium Intemelium, the capital of the Intemelii, a Ligurian tribe which long resisted the Romans, until in 115 BC it was forced to submit to Marcus Aemilius Scaurus. -

Galeazzo Alessi E La Tipologia Del Palazzo Rinascimentale
Originalveröffentlichung in: Galeazzo Alessi e l'architettura del cinquecento : atti del Convegno Christoph Luitpold Frommel Internazionale di Studi [su Galeazzo Alessi e l'Architettura del Cinquecento], Genova, 16 - 20 aprile 1974, Genova 1975, S. 167-171 Galeazzo Alessi e la tipologia del palazzo rinascimentale Illustrare la tipologia dei palazzi dell’Alessi vuol dire in come lo è la disposizione interna. È il risultato finale di primo luogo parlare di due edifici, cioè della Villa Giusti- un lungo sviluppo delle facciate dei palazzi rinascimentali niani-Cambiaso e del Palazzo Marino. Gli altri palazzi e come ho dimostrato altrove. Infatti troviamo la stessa so ville genovesi infatti non sono sicuramente documentati vrapposizione di due piani principali con mezzanini, a Roma come opere dell’Alessi; e dei palazzi attribuibili nell’Um nel Palazzo della Valle-Capranica del 1530 circa, nella casa bria manca ancora la documentazione (’). Inoltre, facendo del Sangallo, cominciata dopo il 1534, o nel contempo un’analisi tipologica debbo concentrarmi sull’aspetto sto raneo Palazzo Farnese a Gradoli (6). Nei palazzi anteriori rico e non su quello artistico. Non tenterò perciò una al Sacco di Roma i due mezzanini non hanno ancora una analisi comprensiva delle strutture stesse, ma cercherò di importanza uguale nel contesto della facciata. individuarne alcune radici storiche. Astratti tipi diventano Se tutto questo sembra di netta ispirazione sangallesca, opere personali attraverso la forma, lo stile di un archi l’articolazione della Villa Giustiniani differisce dalle archi tetto. E così non posso non parlare dello stile personale tetture perugine dell’Alessi. Già nella pianta troviamo una dell’Alessi e del suo sviluppo tra il 1548 ed il 1560.maggiore articolazione plastica, specialmente nelle semico Cominciamo con la Villa Giustiniani (Tav. -

Bodily Vision and the Reconstitution of Viewer/Image Relationships at the Sacro Monte Di Varallo
Image as Relic: Bodily Vision and the Reconstitution of Viewer/Image Relationships at the Sacro Monte di Varallo Margaret F. Bell “Without a doubt, I have never seen anything more religious, more pious, that more touched our hearts […] and I, having recorded everything three, four times and then again [could] not put an end to either my visit or my wonder.”1 These are the words of humanist Girolamo Morone, who wrote to a friend from the Sacro Monte di Varallo in 1507. The Sacro Monte, established by Franciscan friar Bernardino Caimi in 1486, was designed to be a topographically mimetic reconstruction of the Holy Land in the foothills of the Alps northwest of Milan. The complex, consisting of recreated sites like Mount Calvary and the Holy Sepulcher, was intended for pilgrims unable to make the much longer and more hazardous trip to Jerusalem itself. As Girolamo’s words indicate, the Sacro Monte presents challenges for those attempting to describe the complicated and emotionally provocative site. Though he records what he witnessed “three, four times and then again,” it is not enough to convey what he saw and felt while walking through the simulated loci sacri. In the early sixteenth century, the experience of the recreated Holy Land became increasingly immersive as life-size terracotta and wooden figures representing biblical figures were added to the sacred sites. The figures vivified the represented religious scenes, not only because they were situated in a New Jerusalem, but also because of the remarkable fact that visitors to Varallo could move among and touch them as if they were living beings. -

El Barón Marturano Y Las Trazas Italianas Para La Basílica Del Escorial: Su Estancia En Nápoles Con El Virrey Granvela
El barón Marturano y las trazas italianas para la Basílica del Escorial: su estancia en Nápoles con el virrey Granvela. Almudena PÉREZ DE TUDELA Patrimonio Nacional San Lorenzo del Escorial 0 Uno de los problemas más debatidos a la hora de la construcción del Monasterio del Escorial fue el de la basílica. Las primitivas tra- zas de Juan Bautista de Toledo fueron duramente criticadas por Pac- ciotto y, en una fecha tan adelantada como 1571, aún no se tiene de- cidido cómo va a ser esta parte central del edificio. Tras la muerte del primer arquitecto, Juan Bautista de Toledo, en 1567, una serie de diseños para la futura iglesia son enviados a Italia, acompañados por un cuestionario, para ser juzgados por la Academia del Diseño Florentina 1 . Es en estos momentos de indecisión cuando vamos a centrar nuestro estudio, intentando reconstruir las noticias que tenemos de la expedición italiana de un curioso personaje, el ba- rón Giovanni Tomasso Marturano, o Martirano, por Italia, presumible- mente enviado por Felipe II. Además, queremos completar este pano- rama general con algunas breves noticias inéditas que pensamos pue- den arrojar luz sobre este periplo del barón. Es poco lo que sabemos aún sobre este curioso e interesante per- sonaje y aún quedan confundidas las identidades de tío Bernardino y sobrino Gian Tomasso. Según la biografía que hace Egnazio Danti 2 de Vignola, el barón Martirano fue por asuntos propios a la corte española y, habiendo en- trado.en contacto con el rey, éste queda impresionado por sus cono- cimientos en Matemáticas y en Arquitectura. -

La Misura Alessiana Di Perugia the Alessi
DISEGNARECON volume 8/n.15 - luglio 2015 LE MISURE DELL’ARCHITETTURA ISSN 1828-5961 Paolo Belardi Ingegnere civile, insegna “Progettazio- ne digitale” e “Laboratorio di Rilievo dell’architettura” nell’ambito del cor- so di laurea magistrale in Ingegneria edile-Architettura dell’Università di Pe- rugia. Ha insegnato anche nella Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli. È allievo di Vittorio De Feo e, dal gennaio 2013, è Direttore dell’Ac- cademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia. Luca Martini Ingegnere civile, nel 2012 ha consegui- to il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Perugia (tutor professor Paolo Belardi). È docente a contratto di “Progettazione di interventi urbani e territoriali” e “Di- segno per la decorazione” presso l’Ac- cademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia. LA MISURA ALESSIANA DI PERUGIA THE ALESSI MEASURE IN PERUGIA “fare secondo (…) le cose nove, purche elle non “fare secondo (…) le cose nove, purche elle non se se tolgano dalle regole e termini dell’Architettu- tolgano dalle regole e termini dell’Architettura” ra”. L’inciso, vergato da Galeazzo Alessi in un pas- wrote Galeazzo Alessi (1512-1572) in a letter to saggio di una lettera inviata nel 1570 al cardinale Cardinal Fulvio della Corgna in 1570. The cita- Fulvio della Corgna, tradisce in modo più che elo- tion eloquently illustrates the profoundly clas- quente il DNA profondamente classico del mae- sical DNA in the Umbrian master architect’s stro umbro. In tal senso, il contributo proposto -

Territoriality, Fortifications and Port Cities in Early Modern
Term Paper 4.663! Locating Capitalism: Producing Early Modern Cities and Objects! Prof. Lauren Jacobi! History, Theory and Criticism of Art and Architecture! Massachusetts Institute of Technology! Marking the Water: Territoriality, Fortifications and Port Cities in Early Modern Italy! ! In 1608, the Dutch jurist Hugo the Groot contended in his book Mare Liberum that land and sea were two incommensurable entities; the sea was fluid, changeable and lacked plasticity, the land was fixed. The sea was an indeterminable space, without strict boundaries, whereas boundaries on land could be firmly inscribed into the earth. “The question at issue,” De Groot wrote, “is the outer sea, the ocean, that expanse of water which antiquity describes as immense, the infinite, only bounded by the heavens… [it] can neither be seized nor enclosed.”1 Sparked by the rivalry between the maritime empires of the Spanish and the Portuguese, their incessant circulation of trading ships around the globe, and the treaty of Tordesillas, in which Portugal and Spain divided the oceans, drawing an imaginary line, De Groot ridiculed the basis for the arguments of the Iberian hegemony of the seas; “The [Portuguese] are so far from having [occupied the ocean] that when they divide up the world to the disadvantage of the other nations, they cannot even defend !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Hugo de Groot cited in Steinberg 2001: 9. On Hugo de Groot, also known as Grotius, see: M.J. van Ittersum. Profit and principle. Hugo Grotius, natural rights theories and the rise of Dutch power in the East Indies 1595 - 1651. Leiden and Boston: Brill, 2006 or Hamilton Vreedman, Hugo Grotius: The Father of the Modern Science of International Law. -

Architecture in Italy 1400 to 1600
LUDWIG H. HEYDENREICH AND WOLFGANG LOTZ ARCHITECTURE IN ITALY 1400 TO 1600 Translated by Mary Hottinger PUBLISHED BY PENGUIN BOOKS CONTENTS LIST OF FIGURES XI LIST OF PLATES XV FOREWORD XXV MAP xxvii Part One The Quattrocento BY LUDWIG H. HEYDENREICH I. BRUNELLESCHI 2. BRUNELLESCHI S CONTEMPORARIES AND SUCCESSORS IN FLORENCE: MICHELOZZO DI BARTOLOMEO l8 3. BRUNELLESCHl's CONTEMPORARIES AND SUCCESSORS IN FLORENCE: GHIBERTI AND DONATELLO 24 4. ALBERTI 27 5. FLORENCE 1450-1480 39 6. ROME 48 The City: The Capitol, the Lateran, and the Vatican 49 Ecclesiastical Buildings 53 Palazzi 64 7. URBINO 71 8. MANTUA 80 9. VENICE 83 10. LOMBARDY 96 11. EMILIA AND ROMAGNA 114 12. THE FRINGES NORTH AND SOUTH 122 Piedmont and Liguria 122 The South 124 Naples 124 13. FROM THE QUATTROCENTO TO THE CINQUECENTO 130 Epilogue: Leonardo da Vinci 143 vii CONTENTS Part Two The Cinquecento BY WOLFGANG LOTZ 14. CLASSICAL ARCHITECTURE IN ROME: BRAMANTE 149 ~ The Tempietto of S. Pietro in Montorio 150 - The Cloister of S. Maria della Pace 152 Buildings for Julius II 152 The Belvedere Court of the Vatican 153 The Logge 156 - New St Peter's 157 The Choir of S. Maria del Popolo 162 The Palazzo Caprini (Raphael's House) 163 The Santa Casa of Loreto 163 Summary 164 The Designs for St Peter's after Bramante's Death 164 15. CLASSICAL ARCHITECTURE IN ROME: RAPHAEL 167 The Chigi Chapel in S. Maria del Popolo 167 Palazzi 169 The Villa Madama 171 ' St Peter's 173 16. OTHER EARLY-SIXTEENTH-CENTURY BUILDINGS IN ROME AND CENTRAL ITALY 178 ROME 178 Palazzi 178 Churches 181 CENTRAL ITALY 182 S. -

The Royal Monastery of San Lorenzo at El Escorial
THE ROYAL MONASTERY OF SAN LORENZO AT EL ESCORIAL Text PEDRO NAVASCUES PALACIO Photography FÉLIX LORRIO THE IDEA OF THE PRUDENT KING "Prudent foundei; ivell did you employ Your very great prudence; For you made your House eternal with the everlasting House you founded." (F. de Morata, 1664) n his well-known Dichos y hechos del rey D. ly being built, so he will often be quoted in this book: Felipe II (1632), Baltasar Porreño wrote that the "So I seek, therefore, in the last book of this history, monarch liad built a temple at El Escorial to show the truth and proof of this, giving full news of "which alongside the seven wonders of the the illustrious fabric of the monastery of San Lorenzo world is one of them and merits first place". In other el Real, which, without offence to any other, I shall words, very early on the great work rivalled the great make so bold as to say is one of the best understood architecture of Antiquity as the eighth wonder, for and considered that has been seen in many centuries, Porreño's wishes notwithstanding this was the place and we can set it alongside the most beautiful of the that fell to it. Others were more uncompromising. ancient ones, and so similar to them, that they seem Father Francisco de los Santos for example in his to have been born from one and the same idea. In Descripción breve del Monasterio de San lorenzo grandeur and majesty it surpasses all those we are now (1657) had no hesitation in cutting short the argument acquainted with..." by describing the work of Philip II as Opus miracu- This extraordinary achievement had a principal lum orbis and the only wonder of the ivorld, thus rul- author, King Philip II, who in a short time skilfully ing out all others. -

CATHERINE WILKINSON ZERNER Professor BROWN UNIVERSITY Department of History of Art and Architecture, Box 1855
CATHERINE WILKINSON ZERNER Professor BROWN UNIVERSITY Department of History of Art and Architecture, Box 1855 Email: [email protected] [email protected] US Citizen Languages: English, French, Spanish (rws) Reading: Italian, Portuguese, Catalan, German EDUCATION Ph.D., Yale University, 1969 (Renaissance art; history of architecture; Hispanic and Precolumbian art and architecture. Dissertation Topic: "The Hospital of Cardinal Tavera in Toledo"; advisor George A. Kubler; A.M., Smith College, 1963 (architectural history, advisor Henry Russell Hitchcock) A.B., University of Oregon, 1961 ( class of 1963; Honors College) PROFESSIONAL APPOINTMENTS Chair, Department of the History of Art and Architecture, 2005--2009 Visiting Professor, Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance and Université François Rabelais, Tours, France, 2000-2001 Acting Chair, Department of History of Art and Architecture, Brown University, 1998-99 Chair, Department of History of Art and Architecture, Brown University, 1992-95 Director, Program in the History of Art and Architecture, 1980-82; 1989-90 Director, Program in the History of Art and Architecture, Brown University, 1979-1981, 1987-1988 Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance, Tours, Visiting Full Professor, Chair of Early Modern art history, 1990-1992 L'Université François Rabelais, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Departement de l'Histoire de l'Art, Tours, Visiting Professor, 1990-1992 Brown University, Professor, 1985-present Brown University, Associate Professor, 1978-1984 Stanford University, -

Sacrality & Modernity at Villa Giustiniani-Cambiaso
1 Wesleyan University The Honors College Sacrality and Modernity at Villa Giustiniani-Cambiaso by Whitten Overby Class of 2010 A thesis submitted to the faculty of Wesleyan University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Bachelor of Arts with Departmental Honors in Art History Middletown, Connecticut April, 2010 2 Table of Contents Acknowledgements / 4 Preface. Philology and the Distant Past / 5 Introduction. Rethinking the Historiographies of Villa Giustiniani-Cambiaso, the Architect Galeazzo Alessi, and the Genoese Context / 9 Chapter 1. The Myths and Realities of Genoese Topography: A Historical Sketch of Genoa and Its Villeggiatura / 24 (a) Introducing Genoa: Turkish Invasion, Petrarchan Adoration and Trojan Origins / 24 (b) The Genoese Imago Urbis: Perspectives on the City’s Urban and Fiscal Growth / 31 (c) Luca Cambiaso: A Case Study of Mid-Cinquecento Genoese Painting at Villa Giustiniani- Cambiaso / 42 (d) Genoese Villa Typology and Villeggiatura: Prefacing Alessian Invenzione at Villa Giustiniani-Cambiaso / 44 Chapter 2. A Pious Landscape for Luca Giustiniani: Patronage at Villa Giustiniani- Cambiaso / 59 (a) The Gallery of Maps: Ligurian Monks and Mountains under the Papal Gaze / 59 (b) Luca Giustiniani: Family History, Devotion, and the Late Renaissance Upstart in Suburban Genoa / 64 (c) Failed Revolution, Franciscan Piety, and Petrarchan Leisure in Albaro: Potential Motives for Luca Giustiniani’s Chosen Site / 72 (d) An Axial and Ideological Progression of Luca Giustiniani through Villa Giustiniani- -

The Role of Internal Politics in American Diplomacy
Francesco di Giorgio and the Formation of the Renaissance Architect Elizabeth Mays Merrill Evanston, Illinois B.A., Columbia College, Columbia University, New York, 2007 M.A., History of Art and Architecture, University of Virginia, 2010 A Dissertation presented to the Graduate Faculty of Art and Architectural History at the University of Virginia for the Degree of Doctor of Philosophy McIntire Department of Art University of Virginia May, 2015 TABLE OF CONTENTS Acknowledgements ............................................................................................................ i Abstract .............................................................................................................................. ii Introduction ....................................................................................................................... 1 Francesco di Giorgio Martini (1439 – 1501): A chronology ....................................... 14 Chapter I: Critical Biography of Francesco di Giorgio, Architect of Siena.............. 19 Beginnings in Siena: 1439 – 1464................................................................................. 22 Early success, Siena: 1464 – 1475 ................................................................................ 28 Transfer to Urbino: 1475 – 1482 ................................................................................... 35 Political service: Siena, Urbino and Naples (1475 – 1482) .......................................... 39 “Purveyor” to the Court of Urbino: 1483 – -
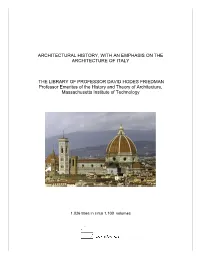
Friedmanlibrary.Pdf
ARCHITECTURAL HISTORY, WITH AN EMPHASIS ON THE ARCHITECTURE OF ITALY THE LIBRARY OF PROFESSOR DAVID HODES FRIEDMAN Professor Emeritus of the History and Theory of Architecture, Massachusetts Institute of Technology 1,026 titles in circa 1,100 volumes MIT School of Architecture + Planning July 2013 Celebrating 'deeper History' In Appreciation of David Friedman In June, SA+P’s program in the History, Theory and Criticism of Art and Architecture sponsored a symposium to reaffirm the program’s commitment to histories of architecture and the arts before the 20th century – what they termed Deeper History – and to celebrate the work of Professor David Friedman on the occasion of his retirement. Friedman’s work has centered on the history of urban form and Italian Renaissance architecture at the birth of capitalism, exploring how public spaces were produced through civic and architectural actions during an era when the interests of the financial world were focused largely on making property private. In examining an era of history that is not customarily studied in professional architecture schools, the symposium not only reaffirmed the place of ‘deeper history’ here but also demonstrated Friedman’s impact over the years on his students, many of whom have gone on to teach this kind of history elsewhere. The day began with PhD students who are currently working on topics related to Friedman’s work, followed by some of Friedman’s students and others now teaching in schools around the country and internationally, and culminated with Friedman in conversation with Henry Millon, one of the founders of the HTC Program and Dean Emeritus of the Center for Advanced Study in the Visual Arts at the National Gallery, Washington DC.