Progetto Discipulus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guardia Di Finanza Savignano Irpino
Provincia di Avellino Settore Pianificazione e Attività sul Territorio Servizio Protezione Civile Greci Montaguto Casalbore Guardia di Finanza Savignano Irpino Montecalvo Irpino Ariano Irpino Competenza territoriale Zungoli Villanova del Battista Melito Irpino COMPAGNIA AVELLINO Bonito San Sossio Baronia Scampitella Flumeri Vallesaccarda Grottaminarda TENENZA ARIANO IRPINO Venticano San Nicola Baronia Pietradefusi Mirabella Eclano Chianche Castel Lacedonia Montefusco Baronia Trevico TENENZA BAIANO Rotondi Roccabascerana Petruro Torrioni Torre le Vallata Irpino Nocelle Fontanarosa Sturno Tufo Carife Cervinara Santa Paolina Taurasi Monteverde San Martino Sant'Angelo all' Esca TENENZA SANT'ANGELO DEI LOMBARDI Altavilla Prata di Montemiletto Frigento Bisaccia Valle Irpina Gesualdo Aquilonia Caudina Pietrastornina Principato Grottolella Ultra Lapio Luogosano Avella Pratola Serra Guardia TENENZA SOLOFRA Sant'Angelo a Scala Villamaina Rocca Lombardi Montefalcione San Sirignano Summonte Montefredane Paternopoli San Mango sul Calore Felice Quadrelle Capriglia Irpina Mugnano del Cardinale Ospedaletto Candida Torella dei Andretta Sede Reparti Guardia di Finanza Manocalzati Castelvetere sul Calore Sperone d'Alpinolo Parolise Lombardi Chiusano San Domenico Sant'Angelo Mercogliano Avellino San Potito Ultra dei Lombardi Morra de Baiano Castelfranci Calitri Atripalda Salza Irpina Sanctis Marzano Montemarano Sorbo Serpico di Nola Taurano Monteforte Cesinali Cairano Pago del Vallo di Lauro Irpino Santo Stefano del Sole Cassano Aiello del Sabato Conza Lauro -

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA Provincia Di Avellino MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel
N. settoriale 64 COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA Provincia di Avellino MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 –Fax. 0827/39380 www.comune.conzadellacampania.av.it - e-mail: [email protected] AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E SEGRETERIA DETERMINAZIONE N° 244 DEL 04.09.2017 COPIA Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E LETTERA DI INVITO A N. 5 DITTE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - CIG: Z4E1FC5CFE L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese settembre, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Capo Area Rag. Giuseppe Vito Veneziano , nell'esercizio delle proprie funzioni, VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comuna le n. 51 del 28/04/2004, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione, aggiornato con delibera di G.C. n. 75 del 17/09/2008; VISTO il Decreto del Sindaco n° 3/2017 di attribuzione della Responsabilità dell'Area "B" – Economico – Finanziaria e Segreteria; ADOTTA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO Premesso che: • Con DGC n. 12 del 15/02/2017 è stato deliberato di dare indirizzo al responsabile del servizio interessato di porre in essere gli atti necessari per attivare la procedura di affidamento del servizio di pulizia della sede municipale tramite procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n.50/2016; Considerato che occorre attivare una procedura procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 per servizio di pulizia sede municipale, riservata a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art. -

Progetto CARG Per Il Servizio Geologico D’Italia - ISPRA: F
I S P R A Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA Organo Cartografi co dello Stato (legge n°68 del 2.2.1960) NOTE ILLUSTRATIVE della CARTA GEOLOGICA D’ITALIA alla scala 1:50.000 foglio 450 SANT’ANGELO DEI LOMBARDI A cura di: T. S. Pescatore1†, F. Pinto1 Con contributi di: P. Galli2 (Sismicità e Strutture Sismogeniche) S. I. Giano3 (Geologia del Quaternario e Geomorfologia) R. Quarantiello1 (Geologia Applicata) M. Schiattarella3 (Tettonica e Morfotettonica) PROGETTORedazione scientifica: M.L. Putignano4 1 Dipartimento di Scienze per la Biologia, Geologia e l’Ambiente, Università degli Studi del Sannio - Benevento 2 Dipartimento di Protezione Civile Nazionale - Roma 3 Dipartimento Scienze Geologiche, Università degli Studi della Basilicata - Potenza 4 Istituto di Geologia Ambientali e Geoingegneria - IGAG - CNR - RomaCARG CNR Ente realizzatore: Consiglio Nazionale delle Ricerche NoteIllustrative F450_S.Angelo dei Lomabardi_17_01_2020_cc.indd 1 17/01/2020 16:20:53 Direttore del Servizio Geologico d’Italia - ISPRA: C. Campobasso Responsabile del Progetto CARG per il Servizio Geologico d’Italia - ISPRA: F. Galluzzo Responsabile del Progetto CARG per il CNR: R. Polino (IGG), fino al 2009, P. Messina (IGAG) Gestione operativa del Progetto CARG per il Servizio Geologico d’Italia - ISPRA: M.T. Lettieri per il Consiglo Nazionale delle Ricerche - CNR: P. Messina (IGAG) PER IL SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA - ISPRA: Revisione scientifica: R. Di Stefano (†), A. Fiorentino, F. Papasodaro, P. Perini Coordinamento cartografico: D. Tacchia (coord.), S. Grossi Revisione informatizzazione dei dati geologici: L. Battaglini, R. Carta, A. Fiorentino (ASC) Coordinamento editoriale: D. Tacchia (coord.), S. Grossi PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE: Funz. -

“Irpinia Madre Contemporanea” Da Gesualdo a Teora …
(Articolo pubblicato sul sito “Palazzo Tenta 39” di Bagnoli Irpino il 19.08.2016) “Irpinia Madre contemporanea” da Gesualdo a Teora … 19.08.2016, Articolo di Giuseppe Pagnotta (dal sito www.orticalab.it) … la transustanziazione del Principe Madrigale ne li Squacqualacchiun! La Regione Campania ha pubblicato, non più tardi di una settimana fa, l’elenco degli eventi turistici e culturali finanziati con fondi per lo sviluppo turistico, anche l’Irpinia avrà i suoi cartelloni ricchi di iniziative tese a far uscire la nostra terra dal suo atavico isolamento. E così, tra illustri esclusi e qualche sorprendente new entry, ecco spuntare due progetti approvati sui quali in questi giorni si concentra in particolar modo l’attenzione degli analisti e di ogni branca del sapere. Innanzitutto, la rassegna “Irpinia Madre – Contemporanea” trova sì una riconferma ma, udite udite, non avrà più come paese capofila né ospitante il Comune di Gesualdo bensì Teora, amena località divenuta miracolosamente da qualche tempo destinataria di innumerevoli finanziamenti provinciali e ora anche regionali dopo le elezioni amministrative. L’altro cartellone, denominato “Terra, grano, sapori nell’Irpinia della devozione”, vede come paese capofila nientepopodimenoche Mirabella Eclano, noto centro agricolo (a quanto pare!) e in particolar modo cerealicolo con importanti santuari meta di pellegrinaggi da secoli! Ora, tralasciando l’ultima kermesse della quale poco o nulla ancora si sa, è il primo evento che ha destato non poco scalpore, in particolare se lo si ricollega agli strali che non più di due mesi fa Antonia De Mita rivolse al Sindaco di Gesualdo, reo di aver oscurato per qualche millisecondo la magnificenza della bell’Antonia e, probabilmente, di non essersi inchinato abbastanza durante il rito della proscinèsi in quel di Nusco. -

6777 Campania Avellino Aiello Del Sabato 869.172,00 € 6778
6777 CAMPANIA AVELLINO AIELLO DEL SABATO 869.172,00 € 6778 CAMPANIA AVELLINO ALTAVILLA IRPINA 400.000,00€ 6779 CAMPANIA AVELLINO ALTAVILLA IRPINA 600.000,00 € 6780 CAMPANIA AVELLINO ANDRETTA 1.000.000,00 € 6781 CAMPANIA AVELLINO AVELLA 750.000,00 € 6782 CAMPANIA AVELLINO AVELLA AV 1.748.450,00€ 6783 CAMPANIA AVELLINO AVELLINO AV 971.128,00 € 6784 CAMPANIA AVELLINO AVELLINO AV 989.464,00 € 6785 CAMPANIA AVELLINO AVELLINO AV 777.336,00 € 6786 CAMPANIA AVELLINO AVELLINO AV 999.576,00 € 6787 CAMPANIA AVELLINO AVELLINO AV 748.888,00 € 6788 CAMPANIA AVELLINO AVELLINO AV 511.760,00 € 6789 CAMPANIA AVELLINO BAGNOLI IRPINO 870.000,00 € 6790 CAMPANIA AVELLINO BAIANO AV 996.860,00€ 6791 CAMPANIA AVELLINO BISACCIA 982.730,16€ 6792 CAMPANIA AVELLINO BONITO 345.000,00€ 6793 CAMPANIA AVELLINO BONITO 350.000,00 € 6795 CAMPANIA AVELLINO CALABRITTO 998.837,97 € 6796 CAMPANIA AVELLINO CALITRI 500.000,00€ 6798 CAMPANIA AVELLINO CAPOSELE 999.681,00€ 6799 CAMPANIA AVELLINO CAPRIGLIA IRPINA 332.834,47€ 6800 CAMPANIA AVELLINO CAPRIGLIA IRPINA AV 289.143,97€ 6801 CAMPANIA AVELLINO CAPRIGLIA IRPINA 375.749,73€ 6802 CAMPANIA AVELLINO CARIFE AV 710.000,00 € 6803 CAMPANIA AVELLINO CASALBORE AV 1.000.000,00€ 6805 CAMPANIA AVELLINO CASTELV. SUL CALORE 998.842,22€ 6806 CAMPANIA AVELLINO CERVINARA AV 904.022,98€ 6807 CAMPANIA AVELLINO CESINALI AV 280.000,00€ 6808 CAMPANIA AVELLINO CESINALI AV 391.752,00 € 6809 CAMPANIA AVELLINO CHIANCHE AV 704.346,84€ 6810 CAMPANIA AVELLINO CHIUSANO DI SAN DOMENICO 996.636,11€ 6811 CAMPANIA AVELLINO CONTRADA AV 999.753,78€ 6813 CAMPANIA -

Comunità Montane Savignano Irpino
Provincia di Avellino Settore Pianificazione e Attività sul Territorio Servizio Protezione Civile Greci Montaguto Casalbore Comunità Montane Savignano Irpino Montecalvo Irpino Ariano Irpino Competenza territoriale Zungoli Villanova del Battista Melito Irpino Comunità Montana Ufita Bonito San Sossio Baronia Scampitella Flumeri Vallesaccarda Comunità Montana Alta Irpinia Grottaminarda Venticano San Nicola Baronia Pietradefusi Mirabella Eclano Chianche Castel Lacedonia Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro Montefusco Baronia Trevico Rotondi Roccabascerana Petruro Torrioni Torre le Vallata Irpino Nocelle Fontanarosa Sturno Tufo Carife Cervinara Santa Paolina Taurasi Monteverde Comunità Montana Irno - Solofrana San Martino Sant'Angelo all' Esca Altavilla Prata di Montemiletto Frigento Bisaccia Valle Irpina Gesualdo Aquilonia Caudina Pietrastornina Principato Grottolella Ultra Lapio Luogosano Comunità Montana Termino Cervialto Avella Pratola Serra Guardia Sant'Angelo a Scala Villamaina Rocca Lombardi Montefalcione San Sirignano Summonte Montefredane Paternopoli San Mango sul Calore Felice Quadrelle Capriglia Irpina Comuni non appartenenti Mugnano del Cardinale Ospedaletto Candida Torella dei Andretta Manocalzati Castelvetere sul Calore Sperone d'Alpinolo Parolise Lombardi Chiusano San Domenico Sant'Angelo Mercogliano Avellino San Potito Ultra dei Lombardi Morra de Baiano Castelfranci Calitri Atripalda Salza Irpina Sanctis Marzano Montemarano Sorbo Serpico di Nola Taurano Monteforte Cesinali Cairano Pago del Vallo di Lauro Irpino Santo -

Idrocarburi in Lrpinia E Moratoria Per -La Realizzazione Di Una V.L.A
Alla Rerlone Campania Al Presldente di Regione Al Vlcepresidente di Re8ione Al Presldente del Consiglio Regionale Alla Giunta Regionale Al Consiglio Regionale A tutte le Commissioni AlGoverno ltaliano Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Ministero dello Sviluppo Economico Al Ministero Affari regionali ed autonomie Al Ministero per l'ambiente A tutti i Deputati A tutti iSenatori A tutte le Commissioni Parlamentari Al Presidente della Repubblica OGGETTO: Petizione per la rinuncia alla ricerca di idrocarburi in lrpinia e moratoria per -la realizzazione di una V.l.A. adeeuata Premessa ll permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, convenzionalmente denominato permesso "NUSCO", d stato rilasciato in data 18 luglio del 2002 alla societa ltalmin Exploration s.r.l. dal Ministero dello Sviluppo Economico. Attraverso la successiva delibera n. 549 del 9 luglio 2010 della Giunta della Regione campania E stata incautamente espressa l'intesa al conferimento del permesso di ricerca "NUSCO". Tale conferimento diviene effettivo col decreto ministeriale del z1.ltoltot da questa data, la ltalmin Exploration s.r.l., ha a disposizione 5 anni per attuare il permesso "NUSCO". La superficie esplorativa E inizialmente di 69,85 kmq; successivamente viene estesa a 695 kmq nella Provincia di Avellino (ed altri 2,5 kmq nella Provincia di Benevento), con rettifica attraverso il decreto del 25/O2ht. I comuni lrpini interessati direttamente dal permesso "NUSCO" sono: Andretta, Ariano lrpino, Bagnoli lrpino, Bonito, Caposele, Carife, Castel Baronia, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Chiusano di San Domenico, Conza della Campania, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Guardia dei Lombardi, Lapio, Lioni, Luogosano, Melito lrpino, Mirabella Eclano, Montella, Montemarano, Morra De Sanctis, Nusco, Paternopoli, Rocca San Felice, San Mango sul Calore, San Nicola Baronia, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo dei Lombardi, Sturno, Taurasi, Teora, Torella dei Lombardi, Trevico, Vallata, Villamaina e Villanova del Battista. -
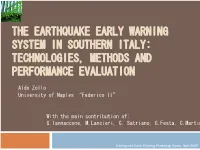
Real Time Processing and Seismic Alert With
THE EARTHQUAKE EARLY WARNING SYSTEM IN SOUTHERN ITALY: TECHNOLOGIES, METHODS AND PERFORMANCE EVALUATION Aldo Zollo University of Naples “Federico II” With the main contribution of: G.Iannaccone, M.Lancieri, C. Satriano, G.Festa, C.Martino and L.Elia Earthquake Early Warning Workshop, Kyoto, April 2009 An EEW system in Southern Italy A real-time seismic alert management system is under testing 50 km in southern Italy. It is based on a dense, wide dynamics INGV red AMRA green seismic DPC blue network monitoring one of the highest earthquake hazardous areas in Italy. Earthquake Early Warning Workshop, Kyoto, April 2009 Historical Earthquakes This region has experienced in the past several destructive 1980 events the Irpinia earthquake, most recent Ms=6.9 one, with magnitude 6.9, occurred in 1980, producing extended damaging and a large number of Earthquake Early Warning Workshop, Kyoto, April 2009 Tectonic regime Montone et al., JGR,1999 Focal mechanisms Stress orientations Earthquake Early Warning Workshop, Kyoto, April 2009 Present-day seismicity The current low- magnitude seismicity occurs along the Apenninic belt, normal fault system 1980 earthquake fault system within the Dic2007-Feb2009 ISNet (Irpinia Seismic Network) upper 20 km of the crust Earthquake Early Warning Workshop, Kyoto, April 2009 The Irpinia Seismic Network (ISNet) Seismic Stations and Local Control Centers Rocchetta S. Antonio 50 Km S. SossioBaronia Trevico Bisaccia Lapio Rocca S. Felice S. Angelo dei Lombardi Andretta Calitri Ruvo del Monte Lioni Nusco ToppodiCastelgrandeToppodiCastelgrande Teora Montella Senerchia Avigliano MuroLucano 1 San Fele Colliano Bella Campagna Picerno Contursi MuroLucano 2 Monte LiFoi Vietridi Potenza CNR-IMAA Caggiano Pignola Seismic Station Wi-Fi Radio Link Postiglione S. -

Anno Sportivo 2020/2021
ANNO SPORTIVO 2020/2021 CAMPIONATO PROMOZIONE - GIRONE "B" 1ª GIORNATA 2ª GIORNATA 3ª GIORNATA A. 04.10.2020 R. 17.01.2021 A. 11.10.2020 R. 24.01.2021 A. 18.10.2020 R. 31.01.2021 ABELLINUM CALCIO 2012 MERCOGLIANO 1999 CIMITILE MONTORO ABELLINUM CALCIO 2012 POLISPORTIVA BISACCESE BAIANO MANOCALZATI FOOTBALL CLUB AVELLINO SAN VITALIANO BAIANO MERCOGLIANO 1999 GESUALDO FOOTBALL CLUB AVELLINO G. CAROTENUTO ABELLINUM CALCIO 2012 FOOTBALL CLUB AVELLINO CIMITILE MONTESARCHIO G. CAROTENUTO MANOCALZATI GESUALDO GESUALDO SOLOFRA CALCIO MONTORO POLISPORTIVA BISACCESE MERCOGLIANO 1999 TEORA MONTESARCHIO MONTORO SAN VITALIANO CIMITILE POLISPORTIVA BISACCESE MONTESARCHIO SAN VITALIANO MANOCALZATI TEORA SOLOFRA CALCIO SOLOFRA CALCIO BAIANO TEORA G. CAROTENUTO 4ª GIORNATA 5ª GIORNATA 6ª GIORNATA A. 25.10.2020 R. 07.02.2021 A. 01.11.2020 R. 14.02.2021 A. 08.11.2020 R. 21.02.2021 CIMITILE MONTESARCHIO ABELLINUM CALCIO 2012 MONTESARCHIO CIMITILE ABELLINUM CALCIO 2012 G. CAROTENUTO BAIANO BAIANO POLISPORTIVA BISACCESE G. CAROTENUTO SAN VITALIANO MANOCALZATI FOOTBALL CLUB AVELLINO FOOTBALL CLUB AVELLINO SOLOFRA CALCIO MERCOGLIANO 1999 FOOTBALL CLUB AVELLINO MERCOGLIANO 1999 GESUALDO GESUALDO G. CAROTENUTO MONTESARCHIO TEORA MONTORO ABELLINUM CALCIO 2012 MANOCALZATI CIMITILE MONTORO BAIANO POLISPORTIVA BISACCESE TEORA SAN VITALIANO MERCOGLIANO 1999 POLISPORTIVA BISACCESE GESUALDO SOLOFRA CALCIO SAN VITALIANO TEORA MONTORO SOLOFRA CALCIO MANOCALZATI 7ª GIORNATA 8ª GIORNATA 9ª GIORNATA A. 15.11.2020 R. 28.02.2021 A. 22.11.2020 R. 07.03.2021 A. 29.11.2020 R. -

Earthquake in Campania-Basilicataj Italy
EARTHQUAKE IN CAMPANIA-BASILICATA J ITALY NOVEMBER 23 J 1980 ARECONNAISSANCE REPORT by James L. Stratta, Consulting Structural Engineer, Menlo Park, California Luis E. Escalante, Los Angeles Department of Water and Power, California Ellis L. Krinitzsky, Waterways Experiment ·Station, Vicksburg, Mississippi Ugo Morelli, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C. Sponsored Jointly by the Committee on Natural Disasters Commission on Sociotechnical Systems National Research Council and the Earthquake Engineering Research Institute Berkeley, California NATIONAL ACADEMY PRESS Washington, D.C. 1981 NOTICE: The Committee on Natural Disasters project, under which this report was prepared, was approved by the Governing Board of the National Research CCluncil, whose members are drawn from the councils of the National Academy of SciE!nces, the National Academy of Engineering, and the Institute of Medicine. The members of the committee responsible for the report were chosen for their special compet:ences and with regard for appropriate balance. This report has been reviewed by a group other than the authors accoJ:ding to procedures approved by a Report Review Committee consisting of members 01: the National Academy of Sciences, the National Academy of Engineering, and the Institute of Medicine. It has also been reviewed for the Earthquake Engineering Research Institute (EERI) by a group under the procedures approved by thE! EERI Board of Directors. The National Research Council was established by the National Academ~r of Sciences in 1916 to associate the broad community of science and technolc~y with the Academy's purposes of furthering knowledge and of advising the federCll government. The Council operates in accordance with general policies det:ermined by the Academy under the authority of its congressional charter of 1863, which establishes the Academy as a private, nonprofit, self-governing membership corporation. -

14601-Pdf12.Pdf
COMUNI APPARTENENTI COM SEDE ABITANTI FAMIGLIE n° COMUNI COMUNI APPARTENENTI COM 1-SA SALERNO 192,539 78,072 2 SALERNO, CAVA DE' TIRRENI COM SEDE ABITANTI FAMIGLIE SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, ROCCAPIEMONTE, SCAFATI, NOCERA INFERIORE, NOCERA n° COMUNI COMUNI APPARTENENTI COM SEDE ABITANTI FAMIGLIE SUPERIORE, SARNO, PAGANI, SAN VALENTINO TORIO, ANGRI, CORBARA, CASTEL SAN GIORGIO, SAN COM 1-CE CASERTA 118,580 45,569 4 CASAGIOVE, SAN NICOLA LA STRADA, CASTEL MORRONE, CASERTA COMUNI APPARTENENTI n° COMUNI COM 2-SA SARNO 275,217 93,403 12 MARZANO SUL SARNO COM SEDE ABITANTI FAMIGLIE COM 2-CE SAN FELICE A CANCELLO 37,249 12,147 3 SANTA MARIA A VICO, ARIENZO, SAN FELICE A CANCELLO n° COMUNI ALTAVILLA IRPINA, CAPRIGLIA IRPINA, CHIANCHE, GROTTOLELLA, PETRURO IRPINO, VIETRI SUL MARE, PRAIANO, FURORE, MAIORI, SCALA, RAVELLO, ATRANI, CETARA, CONCA DEI COM 1-AV ALTAVILLA IRPINA 13,381 5,433 9 PIETRASTORNINA, SANT'ANGELO A SCALA, TORRIONI, TUFO COM 3-SA TRAMONTI 41,149 15,422 13 MARINI, MINORI, AMALFI, TRAMONTI, POSITANO COM 3-CE MADDALONI 46,548 14,836 3 MADDALONI, CERVINO, VALLE DI MADDALONI COM 1-NA POZZUOLI 134,663 46,235 4 MONTE DI PROCIDA, PROCIDA, BACOLI, POZZUOLI ARIANOIRPINO,CASALBORE,GRECI,MONTAGUTO,MONTECALVOIRPINO,SAVIGNANOIRPINO, COM 4-CE TEANO 28,896 10,875 5 VAIRANO PATENORA, FRANCOLISE, TEANO, CAIANELLO, PIETRAVAIRANO COM 2-NA GIUGLIANO IN CAMPANIA 212,067 68,501 4 MELITO DI NAPOLI, VILLARICCA, GIUGLIANO IN CAMPANIA, QUALIANO COM 2-AV ARIANO IRPINO 34,479 13,895 8 VILLANOVA DEL BATTISTA, ZUNGOLI COM 4-SA BRACIGLIANO 80,545 28,668 7 -

Decdir63 08Mish.Pdf
PSR Campania 2000-2006 Misura H e precedenti misure di imboschimento - Elenco dei Beneficiari della Campagna 2006 Domande liquidate Sigla Importo proposto in Prov Importo liquidato Codice Fiscale Partita IVA Ragione Sociale/ Cognome e Nome Comune di residenza liquidazione dalla Residenz da AGEA (€) Regione (€) a 00689100626 00689100626 A.FE.BA. S.R.L. SAN NICOLA MANFREDI BN 8.634,64 8.634,64 BBTSVT42E22D801H 00557250610 ABBATE SALVATORE VILLA DI BRIANO CE 11.000,00 11.000,00 BBNDNC36L23D798Q 02091770640 ABBONDANDOLO DOMENICO FRIGENTO AV 1.043,76 1.043,76 BBRRSR51A67I451L ABBRUZZESE ROSARIA PADULA SA 4.513,52 4.513,52 BRZFNC39M08E206O ABRUZZESE FRANCESCO CIRIACO GROTTAMINARDA AV 208,28 208,28 BRZLCU52E65F203G 02434980617 ABRUZZESE LUCIA MIGNANO MONTE LUNGO CE 5.868,72 5.868,72 CMPLFR53P07B963C ACAMPORA LANFRANCO CASERTA CE 652,08 652,08 CCLGPP69C65Z401N 01950470649 ACOCELLA GIUSEPPINA ANDRETTA AV 11.503,72 11.503,72 CCLPTR55P06I281K 02387360643 ACOCELLA PIETRO TEORA AV 6.113,36 6.113,36 CNZRFL66T21I234O 02352230615 ACUNZO RAFFAELE CAPUA CE 961,84 961,84 DDSNTN37T15A495F 03029610650 ADDESSO ANTONIO AULETTA SA 1.173,52 1.173,52 DDSDNT67B52A495X ADDESSO DONATA PERTOSA SA 239,08 239,08 DDSRSR65M09A495C 02749460651 ADDESSO ROSARIO AULETTA SA 469,04 469,04 00689220648 AGRICOLA IRPINA DEI F.LLI DE SIMONE S.S. DI FORES GUARDIA LOMBARDI AV 1.874,72 1.874,72 00297760639 00297760639 AGRICOLA VISOCCHI S.R.L. NAPOLI NA 4.347,00 4.347,00 02806990616 02806990616 AGRIVER DI LUCIA PUGLISI E C CAPUA CE 8.500,00 8.500,00 LRADLN57T56A509A 02180700649 ALARIO