Lago Di Como
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
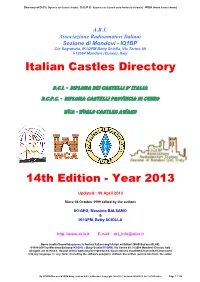
14Th Edition - Year 2013
Directory of D.C.I. Diploma dei Castelli d'Italia) - D.C.P.C. (Diploma dei Castelli della Provincia di Cuneo) - WCA (World Castles Award) A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Mondovì - IQ1BP C/o Segreteria, IK1QFM Betty Sciolla, Via Torino 89 I-12084 Mondovì (Cuneo), Italy Italian Castles Directory D.C.I. - DIPLOMA DEI CASTELLI D’ ITALIA D.C.P.C. - DIPLOMA CASTELLI PROVINCIA DI CUNEO WCA - WORLD CASTLES AWARD 14th Edition - Year 2013 Updated : 09 April 2013 Since 04 October 1999 edited by the authors IK1GPG, Massimo BALSAMO & IK1QFM, Betty SCIOLLA http://www.dcia.it E-mail: [email protected] Opera Inedita Depositata presso la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE-Sezione OLAF). ®1999-2016 by Massimo Balsamo IK1GPG e Betty Sciolla IK1QFM, Via Torino 89, I-12084 Mondovì (Cuneo), Italy All rights are reserved. No part of this work may be reproduced, disassembled, trasmitted, transcribed, translated into any language in any form (including the software program) without the written permission from the editor. By IK1GPG Max and IK1QFM Betty, Sezione A.R.I. di Mondovì, Copyright 1999-2016, Updated 09/04/2013. No.12.634 Castles Page 1 / 135 Directory of D.C.I. Diploma dei Castelli d'Italia) - D.C.P.C. (Diploma dei Castelli della Provincia di Cuneo) - WCA (World Castles Award) № DCI № WCA NAME OF CASTLES PREFIX PROVINCE DCI-AG001 I-00001 Porta di Ponte o Atenea di Agrigento IT9 Agrigento DCI-AG002 I-00002 Castello di Burgio IT9 Agrigento DCI-AG003 I-00003 Torre di Castellazzo a Camastra IT9 Agrigento DCI-AG004 I-00004 Forte -
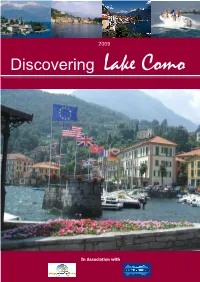
Discovering Lake Como
2009 Discovering Lake Como In Association with Welcome to Lake Como Homes About our Company Lake Como Homes in and can provide helpful Lake Como FREE conjunction with our partners assistance whatever your Advantage Card with every Happy Holiday Homes are now needs. rental booking! established as the leading property management and The Happy Holiday Homes letting company covering Lake team is here to assist you in Como. having a memorable holiday Advantage Card 2009 experience in one of the most Lake Como We are proud to offer a fully beautiful Lakes in the world. comprehensive service to our www.happyholidayhomes.net +39 0344 31723 customers and are equally Try our Happy Service which delighted in being able to offer specialises in sourcing our clients a wide and diverse exceptional good value deals on selection of holiday homes local events and activities and from contemporary studio passing the savings directly apartments to Luxurious onto you. This represents a discount to modern and period style Villas. many of the attractions and We thank you in selecting Lake Eateries about the lake. Happy Holiday Homes, based Como Homes and Happy in Menaggio have an Holiday Homes for your holiday enthusiastic multi-lingual team in the Italian Lakes. providing a personal service Happy Holiday Homes©, Via IV Novembre 39, 22017, Menaggio, Lake Como – www.happyholidayhomes.net - Tel: +39 034431723 Beauty in every sense of the word The Lake is shaped rather like an inverted 'Y', with two 'legs' starting at Como in the South- West and Lecco in the South-East, which join together half way up and the lake continues up to Colico in the North. -

Il Lago Di Como Il Lago Di Como
IlIl lagolago didi ComoComo percorsipercorsi sull’acquasull’acqua Storia e storie Itinerari Ritratti Notizie di viaggio Numeri utili Servizio per i residenti, meraviglia per i turisti Da sempre i laghi del nord del nostro Paese, costituiscono forte attrazione per il gradevole contesto ambientale e paesaggistico in cui sono inseriti. Il lago di Como, di manzoniana memoria, colpisce per la singolarità delle rive, “a fiordo”, e per il graduale incunearsi del bacino lacustre in zona montana, accompagnato nel suo percorso dalla “Regina”, l’antica strada che ne delinea la sponda occidentale. Il lago di Garda è adagiato in una conca attorniata da colline ricche di uliveti e limoneti che prosperano grazie alla mitezza del microclima gardesano contribuendo a fare del lago un polo di significativo interesse turistico. Il lago Maggiore conserva un’elegante atmosfera “fin de siècle”, enfatizzata dall’eleganza delle ville rivierasche e dalla particolare bellezza delle Isole Borromee. La forte urbanizzazione sviluppatasi nelle aree dei laghi ha originato un esponenziale aumento della domanda di servizi come quello, prioritario, del trasporto pubblico locale a seguito della congestione del traffico nelle arterie stradali limitrofe ai bacini lacustri. Da qui l’importanza, sempre più crescente, di trasporto alternativo come quello offerto dalla Navigazione Laghi, presente da più di un secolo come realtà aziendale prima privata e poi pubblica, i cui battelli collegano proficuamente le sponde dei nostri laghi. A seguito dello sviluppo registrato nel contesto socio-produttivo delle nostre zone, la Navigazione Laghi ha ritenuto utile la realizzazione di queste nuove guide che si propongono come ausilio per i residenti e i visitatori delle nostre belle regioni augurandosi che possano fornire un valido servizio per l’utenza. -

NORTHERN ITALY TOUR “A” 7 Nights in Florence and 6 Nights in Verona Starts 6 MAY, 2014 (13 Nights) with David Beauchamp & Anita Curtis
NORTHERN ITALY TOUR “A” 7 nights in Florence and 6 nights in Verona Starts 6 MAY, 2014 (13 nights) with David Beauchamp & Anita Curtis http://farm5.staticflickr.com/4040/4663126091_b1d7419c89.jpg http://farm1.staticflickr.com/4/8522115_ff9b1f0403.jpg The cost of the Northern Italy Bridge Tour “A” is $3,656 per person LAND COST ONLY based on twin share/double accommodation, excluding airfare and travel costs before/after the tour. The single supplement is $992. Non-bridge players are also welcome. The price includes: 13 nights accommodation in 4 star hotels (7 nights in Florence; 6 nights in Verona) All breakfasts Welcome and farewell drinks (beer, wine, soft drinks) 4 dinners (welcome dinner - Florence, farewell dinner – Verona and 2 others) 3 lunches Private coach transfer from Florence to our hotel in Verona Full day private coach tour with English speaking guide to Siena/San Gimignano area Full day coach trip to Bolzano including cable car Private coach wine tour with guide Italian cooking class We suggest that you fly into either All transport with the group (train, bus, cable car) Milan or Rome airport and catch a Vaporetto pass in Venice train to Florence. Entrance fees to attractions listed (not including optional excursions) The beginning of the tour is the 2 bridge workshops Welcome dinner and drinks in 4 sessions at Italian bridge clubs. Florence. The tour ends in Verona on Day 14 after breakfast. To secure your place, send a deposit of $1,000 per person to G.E.T Tours (see payment details form) and a booking form to Anita Curtis. -

Villas and Gardens in the Centre of Lake Como
VILLAS AND GARDENS IN THE CENTRE OF LAKE COMO VILLA CARLOTTA Via Regina 2b, 22019 Tremezzo (CO) Info: +39 0344 40405 - [email protected] - www.villacarlotta.it Villa Carlotta is a place of rare beauty, where masterpieces of nature and art live together in perfect harmony in over 70.000 square metres of gardens and museum. The beautiful villa was built at the end of XVII century in a natural basin between lake and mountains. The architect created for the Clericis an important but sober building, with an Italian garden decorated with sculptures, stairs and fountains. In 1801 Gian Battista Sommariva, famous politician, businessman and patron of arts, bought the villa. Thanks to him, the villa attained the summit of its splendour and became one of the most important halting-place of the Grand Tour with its collection of art (masterpieces of Canova, Thorvaldsen and Hayez) and its fascinating romantic garden. In the second half of the century Princess Marianne of Nassau bought the villa and gave it as a present to her daughter Carlotta in occasion of her wedding. Her husband was passionate about botany and made a lot of improvements and new additions to the park that became more famous for its botanical richness and the rhododendrons’ and azaleas spring flowering. Opening hours: Prices (reduced fees with ID card): Adults: € 10.00 From 2nd October until 5th November: 9.30am-5pm Seniors (over 65): € 8.00 Ticket office closes at 4pm Students (up to 26 y.): € 5.00 (with student card) Children (0-5): free entrance 11th-12th-18th-19th-25th-26th November and 8th-9th-10th Family (2 adults + minors): € 20.00 December: 10am – 4.30pm • Dogs are allowed only in the garden, on Ticket office closes at 4pm leash and with “dog toilet bag” VILLA BALBIANELLO Via Comoedia 5, 22016 Lenno (CO) Info: +39 0344 56110 - [email protected] - www.fondoambiente.it Built in 1787, incorporating an ancient monastery, it is one of the most beautiful and romantic villas on Lake Como. -

Milan and the Lakes Travel Guide
MILAN AND THE LAKES TRAVEL GUIDE Made by dk. 04. November 2009 PERSONAL GUIDES POWERED BY traveldk.com 1 Top 10 Attractions Milan and the Lakes Travel Guide Leonardo’s Last Supper The Last Supper , Leonardo da Vinci’s 1495–7 masterpiece, is a touchstone of Renaissance painting. Since the day it was finished, art students have journeyed to Milan to view the work, which takes up a refectory wall in a Dominican convent next to the church of Santa Maria delle Grazie. The 20th-century writer Aldous Huxley called it “the saddest work of art in the world”: he was referring not to the impact of the scene – the moment when Christ tells his disciples “one of you will betray me” – but to the fresco’s state of deterioration. More on Leonardo da Vinci (1452–1519) Crucifixion on Opposite Wall Top 10 Features 9 Most people spend so much time gazing at the Last Groupings Supper that they never notice the 1495 fresco by Donato 1 Leonardo was at the time studying the effects of Montorfano on the opposite wall, still rich with colour sound and physical waves. The groups of figures reflect and vivid detail. the triangular Trinity concept (with Jesus at the centre) as well as the effect of a metaphysical shock wave, Example of Ageing emanating out from Jesus and reflecting back from the 10 Montorfano’s Crucifixion was painted in true buon walls as he reveals there is a traitor in their midst. fresco , but the now barely visible kneeling figures to the sides were added later on dry plaster – the same method “Halo” of Jesus Leonardo used. -

Comune Di Perledo Comune Di Varenna
Comune di Perledo Comune di Varenna Foto: Alberto Locatelli, Lecco - Progetto grafico: PrePrint, Lecco - Stampa: La Grafica S.r.l., Molteno (LC) La Grafica S.r.l., Lecco - Stampa: PrePrint, Lecco - Progetto grafico: Alberto Locatelli, Foto: PERLEDO 9 ESINO LARIO SORGENTE FIUMELATTE BALUARDO 3 4 GITTANA 3 5 STAZIONE F. S. 6 CASTELLO DI VEZIO RAILWAY STATION VEZIO EREMO Sentiero - Footpat CIMITERO 4 7 GAUDIO PINO 2 9 7 h 6 Sentiero - Footpath OLIVEDO via Venini BELLANO 4KM AUTOSILO 2 11 10 3 PARKING FIUMELATTE ౸ 3 5 olvani ATTRACCO PUBBLICO VARENNA P VILLA MONASTERO PUBLIC DOCK 5 6 viale 4 6 8 6 7 PIAZZA S.GIORGIO 1 5 6 LECCO 20KM 1 Taxi 2 FERRY BOAT via Venini VILLA CIPRESSI via Venini 8 4 1 7 7 8 1 Passeggiata a Lago / Lake Walk 2 5 10 10 Sentieri pedonali / Footpaths 3 1 9 8 4 Distanze a piedi - Distances by foot Strada carrozzabile / Roads 3 Taxi Boat 3 2 1 Parcheggio / Parking Varenna Piazza S. Giorgio - Castello di Vezio ~ 35 min / 0.8 km ATTRACCO PUBBLICO 2 PUBLIC DOCK 5 Varenna Piazza S. Giorgio - Sorgente di Fiumelatte ~ 30 min / 2 km Spiaggia / Beach 4 1 Varenna Piazza S. Giorgio - Imbarcadero / Ferry Dock ~ 10 min / 0.5 km 3 2 Varenna Piazza S. Giorgio - Stazione F.S. / Train Station ~ 20 min / 0.9 km WC / Toilet 11 Varenna Piazza S. Giorgio - Fiumelatte Centro ~ 20 min / 2 km Castello di Vezio - Sorgente Fiumelatte ~ 45 min / 2 km Ufficio turistico / Tourist office BELLAGIO 7 www.varennaitaly.com - www.varennaturismo.com Tel. -

Tra Turismo E Cultura 6 Giorni Di Relax Tra La Natura
Montevecchia e dintorni Programma Primavera – Estate 2009 Tra turismo e cultura 6 giorni di relax tra la natura La Reception è a disposizione per qualsiasi tipo di informazione Proposta Itinerario per soggiorno di una settimana 1° giorno – mattina e pomeriggio dedicati al Parco di Montevecchia. 2° giorno – visita alla città di Lecco e paesi a lago da Abbadia Lariana a Colico. 3° giorno – visita alla città di Como e paesi a lago da Cernobbio a Domaso. 4° giorno – visita alla città di Bergamo. 5° giorno – visita alla città di Milano, quadrilatero della moda – Duomo – Castello Sforzesco. 6° giorno – gita sul lago in battello o motoscafo privato. 1° giorno – Montevecchia. Visita al Santuario della Beata Vergine del Carmelo Osservatorio astronomico: L'Osservatorio è un luogo unico nell'ambito delle visite culturali all'interno della Provincia di Lecco e non solo. Dalle straordinarie cupole che si trovano nella parte settentrionale di Merate su una splendida collinetta, è possibile osservare la volta celeste attraverso i portentosi telescopi messi a disposizione dei visitatori. L'osservatorio è comunque un'importante centro elaborazione dati e di ricerca. Aperto il primo venerdì non festivo di ogni mese; quattro visite guidate nell’arco della giornata 9:30, 10:30, 14:30, 15:30. Aperta anche due notti al mese su prenotazione. Museo del vino (Loc. Cascina Casarigo): dalle 14:00 alle 18:00 su prenotazione. Parco Cascina Cà Soldato (aperto sabato e domenica): il visitatore può osservare la fauna presente nel parco ed i diversi ambienti che lo caratterizzano. Latteria Maggioni Amabile: specialità locale di latticini. (via Alta Collina, 27 – Montevecchia – Tel: 039.9930982). -

The Italian Lakes
©Lonely Planet Publications Pty Ltd Lake Como & Around Why Go? Como. 104 In the shadow of the snow-covered Rhaetian Alps and Triangolo.Lariano. 109 hemmed in on both sides by steep, verdant hillsides, Lake Como (aka Lake Lario) is perhaps the most spectacular of Abbazia.di.San.. the three major lakes. Shaped like an upside-down Y, meas- Pietro.al.Monte. 112 uring around 160km in squiggly shoreline, it’s littered with Lake.Como.West.. villages, including exquisite Bellagio and Varenna. Where Bank . 113 the southern and western shores converge is the lake’s main Lake.Como.East.. town, Como, an elegant, prosperous Italian city. Bank . .119 Among the area’s siren calls are some extraordinarily Lake.Lugano. 122 sumptuous villas, often graced with paradisiacal gardens. Bellinzona. The mountainous terrain means that opportunities for tak- (Switzerland) . .129 . ing bird’s-eye views of the lake and its towns are numerous. And with a fraction of the visitors drawn here compared to Lake Maggiore or Lake Garda, Lake Como and its surround- ing area offer the traveller the chance to enjoy a real sense Best Places to of discovery. Eat ¨ Albergo Silvio (p111) ¨ Gatto Nero (p114) Road Distances (KM) ¨ Ristorante La Vista (p121) Bellinzona 91 ¨ Locanda dell’Isola (p115) ¨ Osteria del Gallo (p108) Como 31 60 ¨ Sale e Tabacchi (p122) Lecco 27 92 28 Lugano 63 29 32 60 Best Places to Stay ¨ Avenue Hotel (p199) ¨ Hotel Silvio (p200) Bellagio Bellinzona Como Lugano ¨ Hotel La Perla (p200) ¨ Hotel Gabbani (p201) ¨ Albergo Milano (p201) 101 Getting Around DON’T MISS The SS340 more or less shadows the western and eastern The view down to Var- shores of Lake Como, bypassing many of the smaller lake- enna and across the side villages which are served by smaller roads. -

VEZIO SHUTTLE Ultima Corsa Alle 19:00
Dal 09 Giugno al 12 Settembre. LAGO DI COMO Dalle 09:45 ogni 30 minuti LAKE COMO dall’ Imbarcadero di Varenna. Dove i tre rami si incontrano, il clima è mite e dove sorgono Ultima corsa alle 18:45. i paesi più belli, le ville più lussuose e il paesaggio diventa Solo sabato e domenica si aggiungono sorprendente e selvaggio. Suggestivo, romantico e affascinante, ecco il cuore del Lario o, più comunemente 19:15 e 19:45. chiamato, il Lago di Como. From 09 June to 12 September. Where the three branches meet, the climate is mild and where the most beautiful villages arise, the most luxurious From 9:45AM every 30 minutes villas and the landscape becomes surprising and wild. from the Varenna’s Pier. Suggestive, romantic and fascinating, this is the heart of Last run at 6:45PM. the Lario or, more commonly called, Lake Como. Only Saturday and Sunday also at 7:15PM and 7:45PM. Dal 09 Giugno al 12 Settembre. Dalle 10:00 ogni 30 minuti dal Castello di Vezio. CORSA SINGOLA VEZIO SHUTTLE Ultima corsa alle 19:00. VEZIO SHUTTLE da Varenna al Castello di Vezio in 15 minuti Solo sabato e domenica si aggiungono CORSA SEMPLICE from Varenna to Castle of Vezio in 15 minutes 1,50€ one way ticket - bus service 19:30 e 20:00. Convalidare al momento della salita a bordo From 09 June to 12 September. Must be validated when get on board From 10:00AM every 30 minutes from the Castle of Vezio. Last run at 7:00PM. -

Pieghevole Viandante 16-Corr Copia
E‘ con lo spirito del viandante che vi chiediamo di VIII EDIZIONE 2016 intraprendere il cammino. Certo rapiti e a"ascinati dai luoghi, ma cauti e senza correre, rispettosi della natura e soprattutto dei limiti che ci ha donato; perciò, nel percorrere questo tratto del “ Sentiero del Viandante ” ricordatevi sempre che si parla del tratto più impegnativo : con una salita di$coltosa e con ripidi e profondi valloni da costeggiare. Consigliamo pertanto, oltre ad abbigliamento e calzature adatti, attenzione e cautela . Stazione Ferroviaria Sentiero per ss 36 escursionisti esperti tempo di percorrenza 4,30 / 5,00 ore Vezio Varenna 370 Costa de Legla Esino Lario Pro Loco Lierna Faggeta Guillo Ortanella 2° Tappa Monte Fopp 952 1090 S.Pietro 992 Alpe di Mezzedo Domenica 11 Settembre 870 Croce del sp 72 Brentalone ss 36 650 Stazione Ferroviaria Zucco Lierna della pecora 730 Genico 320 338.2046991 [email protected] www.lierna.net * prolocolario.it Comune di Lierna Comune di Esino Lario Programma ore 8,15 Ritrovo presso la stazione ferroviaria (parcheggio gratuito) ore 8,45 Colazione o"erta dalla Pro Loco in località Castello ore 10,00 Partenza passeggiata ore 12,00 Pausa con assaggio gastronomico o"erto dalla Pro Loco in località Ortanella ore 17,00/17,30 Arrivo alla stazione ferroviaria di Varenna L'itinerario di questa tappa parte dalla stazione di Lierna: uscendo di qui si prende a sinistra la strada asfaltata che sale, poi al piazzale dell'u"cio postale si svolta a sinistra (Via della Libertà) e si imbocca sulla destra la via che si dirige Alpe di Mezzedo Croce del Brentalone a Genico. -

4. Lecco E Il Lago Dal Lago and the Lake from The
Vivi un’esperienza...in battello Live an experience…by boat green, healthy, 4. Lecco smart land. e il lago dal lago And the lake from the lake “Quel ramo del Lago di Como che volge a mezzogiorno...” “That branch of Lake Como that bends towards the south…” Iniziativa realizzata con il contributo di Vivere il lago dal lago, cogliere l’unicità di un paesaggio Experience the lake from the lake and appreciate the uniqueness così suggestivo, dove l’acqua è l’elemento assoluto e i colori of this landscape where water is the utmost element and the delle stagioni regalano scenari sempre diversi. L’itinerario è colours and landscape change with the seasons. This is an pensato in battello, con alcune soste per addentrarsi nei itinerary to follow by boat with stopoffs to explore the most borghi più caratteristici. La navigazione inizia nel golfo di interesting villages. Depart from the Gulf of Lecco and travel Lecco per risalire il ramo orientale fino al centro lago; il ritor- up the eastern branch of Lake Como as far as the central no nel capoluogo può avvenire ancora in battello o in treno. lake area. You can return to Lecco either by boat or by train. TEMPO DI PERCORRENZA DURATION Da mezza giornata a giornata intera Half day – 1 full day PARTENZA STARTING POINT Lecco Imbarcadero: lungolario Cesare Battisti (servizio Lecco landing stage: lake road Lungolario C. Battisti pubblico); lungolario Isonzo di fronte Ristorante Larius (public transport); lake road Lungolario Isonzo opposite (servizio privato). Dalla stazione ferroviaria il lungolago Larius restaurant (private boat service); from the train è a circa 550 m station it is about 550 m.