L'immigrazione Straniera in Lombardia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Curriculum Vitae
CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome Laezza Chiara Data di nascita 20 ottobre 1972 Luogo di nascita Napoli Datore di lavoro Comune di Mariano Comense (CO)-Piazzale Console T. Manlio n. 6/8- 22066 Mariano Comense E-mail [email protected] Nazionalità Italiana ISTRUZIONE E FORMAZIONE Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi “Federico II” di Napoli Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza –Indirizzo Statutario. Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Liceo classico “F. Durante”- Frattamaggiore (NA) Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Macerata, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’ANCI e l’ANUSCA Titolo della qualifica rilasciata Master di primo livello in Servizi Demografici ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) Settembre 2012-a tutt’oggi • Nome e indirizzo del datore di Città di Mariano Comense (CO) lavoro Piazzale Console T. Manlio n. 6/8 • Principali mansioni e responsabilità Istruttore diretivo- Cat. D- Posizione Economica D3-Titolare di posizione organizzativa- Responsabile “Settore Appalti, Contratti e Finanziamenti”. • Date (da – a) 16/09/2006-ad agosto 2012 • Nome e indirizzo del datore di Città di Mariano Comense (CO) lavoro Piazzale Console T. Manlio n. 6/8 • Tipo di impiego Assunzione a tempo indeterminato in seguito a trasferimento per passaggio diretto (fino al 31/01/2008 in posizione di comando) • Principali mansioni e responsabilità Istruttore diretivo- Cat. D- Posizione Economica D3-Titolare di posizione organizzativa (dal 16/10/2006 a tutt’oggi)-Responsabile “Settore Attività Produttive” e “Sportello Unico Attività Produttive-Gestione associata tra i Comuni di Mariano Comense, Inverigo, Figino Serenza, Cabiate”. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus C80 C80 Cantù - Meda - Monza Visualizza In Una Pagina Web La linea bus C80 (Cantù - Meda - Monza) ha 12 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Cabiate: 06:15 (2) Cantù: 05:55 - 22:10 (3) Cantù -> Como: 06:46 (4) Cantù -> Lomazzo: 14:10 (5) Cantù -> Magistri C.: 06:40 (6) Mariano: 07:10 - 13:05 (7) Meda: 13:58 (8) Meda: 06:15 - 13:14 (9) Monza: 04:50 - 20:40 (10) Seregno: 06:05 - 06:35 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus C80 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus C80 Direzione: Cabiate Orari della linea bus C80 22 fermate Orari di partenza verso Cabiate: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 06:15 martedì 06:15 Cantù - Piazzale Cai (Postaz. C80) Piazzale CAI, Cantù mercoledì 06:15 Cantù - Via Manzoni (408) giovedì 06:15 Via Alessandro Manzoni, Cantù venerdì 06:15 Cantù - Piazza Parini (308) sabato 06:15 Piazza Giuseppe Parini, Cantù domenica Non in servizio Cantù - Via Ariberto (321) Cantù - Via Fossano (Cem) Cantù - Via Fossano (Scuole - 320) Informazioni sulla linea bus C80 Via Tripoli, Cantù Direzione: Cabiate Fermate: 22 Cantù - Via Fossano, 58/59 (501) Durata del tragitto: 25 min La linea in sintesi: Cantù - Piazzale Cai (Postaz. Cantù - Via Fossano, 70 C80), Cantù - Via Manzoni (408), Cantù - Piazza Via Ginevrina Da Fossano, Cantù Parini (308), Cantù - Via Ariberto (321), Cantù - Via Fossano (Cem), Cantù - Via Fossano (Scuole - 320), Vighizzolo - Piazza Piave Cantù - Via Fossano, 58/59 (501), Cantù - Via Via Enrico Toti, Cantù Fossano, 70, Vighizzolo - Piazza Piave, Vighizzolo - Via Montello, 33, Cascina Amata - Via M. -

Cancellazioni
Ulisse — InfoCamere Page 1 of 45 Camera di Commercio di COMO-LECCO Elenco CO2246950981 del 31/05/2021 16:00:52 Registro Imprese ordinato per [tipo movimento, comune, denominazione] Utente: CCO0096 Posizioni: 144 Note: cessazione suap maggio Criteri: Impresa - Tipo Solo Imprese cessate Impresa - Albo Registro Imprese Impresa - Territorio COMO Impresa - Periodo Registrazione dal 01/05/2021 al 31/05/2021. 1) Prov: CO Sezioni RI: O Data iscrizione RI: 16/05/2016 N.REA: 325930 F.G.: SR Denominazione: LARIO GREEN SRL IN LIQUIDAZIONE C.fiscale: 03652520135 Partita IVA: 03652520135 Indirizzo: VIA MILANO, 10 Comune: 22031 ALBAVILLA - CO Data inizio attività: 30/05/2016 Attività: ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA PRESSO LE IMPRESE A LIVELLO DI SERVIZI ENERGETICI,NELLA REPERIBILITA' DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI E LA GESTIONE DI SISTEMI AZIENDALI GESTIONALI. C. Attività: 74.90.93 I / 74.90.93 P Capitale Sociale: deliberato 10.000,00 Valuta capitale sociale: EURO 1) pers.: FUSI PIER PAOLO, LIQUIDATORE Impresa cancellata in data 25/05/2021 con data domanda 24/05/2021 Causale: RI - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE Data denuncia (C) 24/05/2021 30/06/2020 - DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE 25/05/2021 - RICHIESTA DI CANCELLAZIONE 2) Prov: CO Sezioni RI: P Data iscrizione RI: 01/03/2007 N.REA: 292042 F.G.: DI http://ulisse.intra.infocamere.it/ulis/gestione/get -document -content.action 31/ 05/ 2021 Ulisse — InfoCamere Page 2 of 45 Ditta: ZOANI MAURIZIO C.fiscale: ZNOMRZ60R06A333R Partita IVA: 03027750136 Indirizzo: VIA ISIDORO PAGANI, 13 Comune: 22070 APPIANO GENTILE - CO Numero addetti dell'impresa dichiarati nel 2020 : indipendenti: 1 dipendenti: 0 Data inizio attività: 01/03/2007 Attività: AGENTE DI COMMERCIO NEL SETTORE TESSILE. -

Piano Annuale 2020 Corretto Tecum
CITTÁ DI MARIANO COMENSE PROVINCIA DI COMO …. SETTORE TERRITORIO Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente PIANO ANNUALE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI ANNO 2020 Il presente Piano Annuale dell’Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali è stato predisposto in conformità all’articolo 4 del Regolamento Regionale n. 4 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni e sulla base dei dati forniti dai Comuni dell’Ambito Territoriale di Mariano Comense e dall’ALER territorialmente competente, che è stata consultata prima di procedere alla presentazione della proposta all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Mariano Comense. L’ambito territoriale di Mariano Comense è composto dai Comuni di Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba per complessivamente 58.958 abitanti, suddivisi in 24.124 nuclei familiari. Territorialmente è competente l’ALER di Varese – Como – Monza e Brianza – Busto Arsizio. L’Assemblea dei Sindaci dell’ambito territoriale di Mariano Comense, nella seduta del 16/04/2018, ha nominato il Comune di Mariano Comense quale Comune Capofila per la predisposizione del Piano Annuale dell’offerta abitativa pubblica e sociale. Al fine di predisporre il Piano Annuale per l’anno 2020, il Comune di Mariano Comense ha coordinato gli enti proprietari nelle operazioni di ricognizione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP) che si prevede di assegnare nel corso dell’anno 2020, come previsto dalla normativa vigente (R.R. 4/2017 e R.R. 3/2019). _____________________________________________________ 22066 – Mariano Comense, P.le Console Teodoro Manlio 6/8 – c.f. 81001190131 – P. Iva 01358150132 Tel. 031/757211 – Fax 031/749287 – http://www.comune.mariano-comense.co.it – e-mail [email protected] Tel. -

Cancellazioni
Ulisse — InfoCamere Page 1 of 150 Camera di Commercio di COMO-LECCO Elenco CO1217863993 del 01/02/2021 12:33:19 Registro Imprese ordinato per [tipo movimento, comune, denominazione] Utente: CCO0096 Posizioni: 475 Note: CESSATE GENNAIO SUAP Criteri: Impresa - Tipo Solo Imprese cessate Impresa - Albo Registro Imprese Impresa - Territorio COMO Impresa - Periodo Registrazione dal 01/01/2021 al 31/01/2021. 1) Prov: CO Sezioni RI: P Data iscrizione RI: 04/12/2018 N.REA: 333881 F.G.: DI Ditta: CAVALLARIN SARA C.fiscale: CVLSRA91P48D416C Partita IVA: 03803210131 Indirizzo: VIA SARUGGIA 83/A Comune: 22031 ALBAVILLA - CO Numero addetti dell'impresa dichiarati nel 2020 : indipendenti: 1 dipendenti: 0 Data inizio attività: 05/12/2018 Attività: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI VARI, MEDIANTE L'INTERVENTO DI UN DIMOSTRATORE O DI UN INCARICATO ALLA VENDITA (PORTA A PORTA) C. Attività: 47.99.1 I / 47.99.1 P 1) pers.: CAVALLARIN SARA, TITOLARE FIRMATARIO Impresa cancellata in data 13/01/2021 con data domanda 08/01/2021 Causale: CZ - CESSAZIONE DI OGNI ATTIVITA' Data cessazione attività: 31/12/2020 Data denuncia (C) 08/01/2021 31/12/2020 - RICHIESTA DI CANCELLAZIONE 2) Prov: CO Sezioni RI: P Data iscrizione RI: 01/06/2020 N.REA: 405216 F.G.: DI Ditta: TNC DI CROCI LORENZO C.fiscale: CRCLNZ99T28D416U Partita IVA: 03900190137 http://ulisse.intra.infocamere.it/ulis/gestione/get -document -content.action 01/ 02/ 2021 Ulisse — InfoCamere Page 2 of 150 Indirizzo: VIA BASSO FORMIANO, 9 Comune: 22031 ALBAVILLA - CO Numero addetti dell'impresa dichiarati nel 2020 : indipendenti: 1 dipendenti: 0 Data inizio attività: 22/06/2020 Attività: COMMERCIO AL DETTAGLIO VIA INTERNET C. -
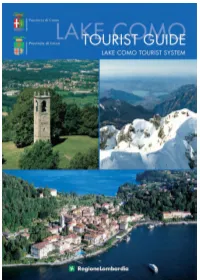
Tourist Guide.Pdf
COMACINA ISLAND PRESENTATION LAKE COMO TOURIST SYSTEM This tourist guide introduces one of the most beautiful areas in the region called Lombardy and enthusiastically welcomes all visitors who are planning to have an enjoyable stay here. Seen from above, the blue of the lakes and the green of the woods are the two colours which exist in harmony in this spectacular landscape full of panoramas. The lakes are the main characteristic of Como and Lecco provinces, surrounded by a range of important mountains which open up to the hilly countryside of Brianza to the South, the home to entrepreneurship. We had the idea of preparing a guide that was not only easy to use, but of high quality: therefore, you will find, alongside the usual cultural itineraries that inform you of our national heritage, practical information that can help you to easily discover our region and even the less known places. Subdivided into geographical areas of lake, mountain and plain, the Guide describes the entire territory of Como and Lecco provinces; its history, architecture, art and natural beauty, starting from the “capoluoghi” (main towns) of the province and the lake basin. It then goes on describing the mountain area and cultural features, uncovering the towns and ancient villages, alongside the mountain shelters and peaks. It gives detailed information on walking excursions for all nature lovers, from trekking to all types of sport. The section that describes the plains moves down towards the gentle Brianza hills, travelling through villas and castles and working valleys crossed by the River Adda, as well as parks full of treasures and wonderful views. -

Dgr 11 Luglio 2014
– 2 – Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 16 luglio 2014 • alla determinazione di un livello di classificazione sismica C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI maggiormente cautelativo rispetto a quello vigente; D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 • all’aggiornamento della classificazione del territorio lom- Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. bardo, anche in funzione del riordino delle disposizioni 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d) della normativa regionale in materia di vigilanza e con- trollo sulle costruzione in Zona sismica; LA GIUNTA REGIONALE Preso atto che il Gruppo di Lavoro interdirezionale «Coordina- Richiamati: mento azioni sul rischio sismico», costituito con decreto n. 8448 • il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento del 23 settembre 2013 del Direttore Generale della D.G. Sicu- di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni rezza, Protezione Civile e Immigrazione, ha elaborato, come da ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 verbale del 9 aprile 2014, una proposta di aggiornamento della marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 54 comma 1 lett. classificazione sismica regionale approvata dalla richiamata c), ai sensi del quale sono mantenute in capo allo Stato le d.g.r. 14964/2003; funzioni relative alla predisposizione della normativa tecni- Preso atto che le competenti Direzioni Generali: ca nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche nonché i criteri generali • hanno valutato la nuova classificazione coerente con le per l’individuazione delle zone sismiche, delegando altre- specificità del territorio lombardo, anche in considerazio- sì alle Regioni le funzioni relative all’individuazione delle ne della presenza di aree fortemente antropizzate e del zone sismiche, alla formazione e all’aggiornamento degli patrimonio storico esistente, nonché con la classificazione elenchi delle medesime; delle Regioni confinanti; • la legge regionale 5 gennaio 2000 n. -

Territorio: Lavori Pubblici E Pontili in Vista Cultura: Biblioteca Pronta a Crescere Il Personaggio: Tre Storie Che Fanno Sognar
di San Siro IlPeriodico delGrillo Comune di San Siro - Via Don Giacomo Galli, Loc.Parlante Acquaseria - Tel. 0344 50015 ANNO IV - NUMERO II - LUGLIO 2011 Supplemento Testata registrata Trib. Como 14/04 Dir. Responsabile: Alessandro Gini - Consulenza editoriale grafica e stampa: www.nuovaera.info Difendiamo San Siro. Difen- diamo le nostre tasche! Ne- gli ultimi mesi sono stati nu- merosi i segni di incivilità e maleducazione che hanno ferito il nostro territorio. Cas- sonetti dell’immondizia dan- neggiati, fioriere ribaltate, ri- fiuti abbandonati nei boschi, scritte ovunque sui muri. La maleducazione sembra aver trovato terreno fertile con l’arrivo della bella sta- gione. Un tremendo autogol per la nostra credibilità di paese in sensibile espansio- ne turistica ma, soprattutto, un fenomeno da arginare tutti insieme, perchè il costo della maleducazione, alla fine, lo pagano tutti i citta- dini. Chi pensa, con questi comportamenti, di danneg- giare un’Istituzione, è bene invece che sappia che lui stesso poi ne pagherà le conseguenze. Già, perché i costi che un’Amministrazio- ne comunale deve sobbar- carsi per ripristinare un’area danneggiata o un muro im- brattato, saranno inevitabil- e d i t o 4 Territorio: lavori pubblici e pontili in vista r i Cultura: biblioteca pronta a crescere 9 a l 13 Il personaggio: tre storie che fanno sognare e segue a pag. 2 Campi estivi e Grest: ecco le foto 16 DAL COMUNE continua da pag. 1 UN TERRITORIO FERITO, CHE VUOL DIRE BASTA! mente a carico dei residenti. Il denaro che utilizza il Comune, del resto, è il denaro dei suoi cittadini. -

TOURIST GUIDE ASSOCIATIONS PROVINCE of COMO Associazione Guide E Accompagnatori Turistici Di Como E Provincia Phone No
TOURIST GUIDE www.lakecomo.com ISOLA COMACINA 01_ING_presen_sistema.indd 1 25/07/11 11:40 PRESENTATION This Tourist Guide introduces one of the most beautiful areas in the region called Lombardy and enthusiastically welcomes all visitors who are planning to have an enjoyable stay here. Seen from above, the blue of the lakes and the green of the woods are the two colours which exist in harmony in this spectacular landscape full of panoramas. The lakes are the main characteristic of Como and Lecco provinces, surrounded by a range of important mountains which open up to the hilly countryside of Brianza to the South, the home to entrepreneurship. We had the idea of preparing a guide that was not only easy to use, but of high quality: therefore, you will fi nd, alongside the usual cultural itineraries that inform you of our national heritage, practical information that can help you to easily discover our region and even the less known Via Sirtori 5 - 22100 Como places. Phone No. + 39 031 2755551 Subdivided into geographical areas of lake, mountain Fax + 39 031 2755569 and plain, the Guide describes the entire territory of [email protected] www.provincia.como.it Como and Lecco provinces; its history, architecture, art www.lakecomo.com and natural beauty, starting from the “capoluoghi” (main towns) of the province and the lake basin. It then goes on describing the mountain area and cultural features, uncovering the towns and ancient villages, alongside the mountain shelters and peaks. It gives detailed information on walking excursions for all nature lovers, from trekking to all types of sport. -

Linea CADORNA
linea CADORNA - SEVESO - CAMNAGO - ASSO Genere di treno S4 AUTO R S4 AUTO AUTO RS2S4 RS2S2 S4 AUTO R S4 R S4 AUTO S4 AUTO R S2/ S4 S2/ S4 AUTO R S2/ S4 S2/ S4 AUTO Numero del treno 11909 1609A 6611 10911 6613A 2913A 1613 1713 10915 6615 1717 6717 10917 2917A 1617 10919 621 10923 6923A 925 10925A 625 1727 10927 1729 929 10929A 631 1731 10931 1733 933 10933A Giorno di circolazione F6(4) F6(4) P(14) G(1) PG(7) P(14) F6(4) F5(3) G P(15) F5(3) P(12) G(1) P(16) F6(4) G G(1) G(1) P(6) G G(1) G F5(3) G(1) F5(3) G G(1) G(1) F5(3) G(1) F5(3) G G(1) [31] [36] [31] [36] [36] [31] [31] [31] [31] [31] [36] [31] [31] [36] [36] [36] [36] Nota commerciale [31] [31] [31] [36] [36] [36] [36] [38] [35] [38] [38] [35] [36] [35] [36] [35] [38] [35] [35] [38] [38] [38] [38] Classe 2 1-2 2 1-2 2 2 1-2 2 2 2 1-2 2 1-2 22 1-2 2 2 2 2 1-2 2 2 2 2 MILANO NORD 5.53 6.09 6.23 6.39 6.53 7.09 7.23 7.39 7.53 8.09 8.23 8.53 9.09 9.23 9.53 10.09 10.23 10.53 Milano Domodossola 5:56 6:12 6:26 6:42 6:56 7:12 7:26 7:42 7:56 8:12 8:26 8:56 9:12 9:26 9:56 10:12 10:26 10:56 Milano Bovisa a. -

District 108IB1.Pdf
Club Health Assessment for District 108IB1 through April 2021 Status Membership Reports Finance LCIF Current YTD YTD YTD YTD Member Avg. length Months Yrs. Since Months Donations Member Members Members Net Net Count 12 of service Since Last President Vice Since Last for current Club Club Charter Count Added Dropped Growth Growth% Months for dropped Last Officer Rotation President Activity Account Fiscal Number Name Date Ago members MMR *** Report Reported Report *** Balance Year **** Number of times If below If net loss If no When Number Notes the If no report on status quo 15 is greater report in 3 more than of officers thatin 12 months within last members than 20% months one year repeat do not haveappears in two years appears appears appears in appears in terms an active red Clubs less than two years old 145743 Lombardia Cyber - CIVIS 20 03/22/2021 Newly 20 20 0 20 100.00% 0 1 M,VP,MC,SC N/R Chartered 145382 Lombardia Nord Alert Team 02/26/2021 Newly 20 20 0 20 100.00% 0 0 M,VP,MC,SC N/R Chartered 140356 Lombardy On The Road 12/04/2019 Active 22 0 0 0 0.00% 22 0 2 N MC 1 Clubs more than two years old 129675 Arcore Borromeo 12/29/2016 Active 14 0 1 -1 -6.67% 15 2 0 2 R 2 $103.40 MC 116107 BELLAGIO-BELLAXIO 02/17/2012 Active 28 4 2 2 7.69% 26 9 0 N 0 $1,184.40 VP,MC 20969 BORMIO 06/29/1971 Active 45 2 2 0 0.00% 47 14 2 12 $268.06 Exc Award (06/30/2016) 30445 BRIANZA COLLI 03/21/1975 Active 21 0 0 0 0.00% 21 15 2 R N/A $337.99 20971 BRIANZA HOST 06/25/1965 Active 23 0 1 -1 -4.17% 24 28 0 2 R 0 $606.00 VP,MC 30832 BUSTO ARSIZIO 05/28/1975 -

C 80 Cantù - Meda - Monza
C_80 Cantù - Meda - Monza 2 Si effettua nei giorni feriali non di scuola. 31 La corsa da Cantù, prosegue per Lomazzo con Linea C 84. 34 Effettua deviazione da Mirabello e Vighizzolo via S. Giuseppe. 79 Si effettua nei giorni scolastici da Lunedì a Venerdì. 87 La fermata di Meda via Indipendenza si effettua in via Cadorna. A4 A Meda non transita da Via Indipendenza ma da Via Cialdini(Liceo M.Curie) IL SERVIZIO E' SOSPESO IL 25 DICEMBRE, IL 1° GENNAIO E IL 1° MAGGIO. seguono quadri orario 08 10 C_80 Cantù - Meda - Monza ORARIO INVERNALE 800002 800006 800202 800012 800008 800014 800024 800016 800018 800022 800020 800026 800204 800030 800032 800040 800042 Fer6 Fer6 Fer6 Scol Fer6 Fer6 Scol Scol Scol Fer6 Fest Scol Scol Scol Fer6 Scol Scol 02 02 CANTU' - Viale Madonna 05.05 05.35 05.45 06.00 06.00 06.00 06.10 06.20 06.25 06.30 06.30 06.35 06.50 06.55 07.00 07.15 07.25 CANTU' - Via Ariberto 05.05 05.35 05.45 06.00 06.00 06.00 06.10 06.20 06.25 06.30 06.30 06.36 06.50 06.56 07.00 07.15 07.25 CANTU' - Via Fossano 59 05.07 05.37 05.47 06.02 06.02 06.02 06.12 06.22 06.27 06.32 06.32 06.38 06.52 06.58 07.02 07.17 07.27 VIGHIZZOLO - Piazza Piave 05.09 05.39 05.49 06.04 06.04 06.04 06.14 06.24 06.29 06.35 06.34 06.40 06.54 07.00 07.05 07.20 07.30 CASCINA AMATA - Via M.