Studio Del Terremoto Di Tuscania
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1911 1 Acquapendente Anno Ditta Localita' B. Fasc. 1967
1911 ELENCO FASCICOLI CONTENENTI PRATICHE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO “ESAURITI” ACQUAPENDENTE DITTA LOCALITA' ANNO 1 B. FASC. 1967 BISCONTI ARNOLDO VIA CASSIA KM. 137+57 13 434 1967 RONCA NOE' ACQUAPENDENTE 13 435 1968 19 627 D'ORAZIO ADOLFO E RUFFALDI MARIELLAVIALE DELL'ANNUNZIATA 1969 CANTERA GADDO E VENTURI ROSA VIALE DELL'ANNUNZIATA 23 772 1969 CERRINI EVARISTO ACQUAPENDENTE 23 770 1969 GIOACCHINI (IMPRESA) VIA ONANESE 23 767 1969 PERUZZI CORRADO (DITTA) ACQUAPENDENTE 23 766 1969 SMOVICA (IMPRESA) ACQUAPENDENTE 23 771 1969 SODA GIUSEPPE VIA DEL RIVO 23 769 1969 VITALI VITALIANO VIALE DELL'ANNUNZIATA 23 768 1970 BISOGNI ILIO VIA CASSIA – LOC. MADONNINA31 1025 1970 BRAMINI GIUSEPPE LOC. PODERE POPINZO 31 1031 1970 31 1027 CAMPANA VELIA IN FRANCO LOC. TORRE ANNUNZIATA 1970 31 1030 FANI RAFFAELLA E PIERI ALFIA LOC. PORTA DELLA MADONNA 1970 31 1021 FELICIOTTI EDELBERTO VIA DEL RIVO 1970 MONCELSI MARIA IN FORNACA PODERE LAZZANO – OPERE DI MIGLIORAMENTO31 1024 FONDIARIO 1970 NERI NERINO SS.CASSIA KM 132 + 0,48 31 1022 1970 31 1028 PERUZZI (SOCIETA') – TAURELLI E SALIMBENIACQUAPENDENTE (IMPRESA) – CAPANNONE ADIBITO A STALLA 1970 POLI M.CONCETTA IN FABI LOC. PODERE S.PIETRO 31 1026 1970 31 1023 SAVELLI CORNELIA IN CERRINI (IMPRESA)LOC. PORTA DELLA MADONNA 1970 SODA STEFANO LOC. VIGNOLO 31 1029 1971 BENOTTI GIUSEPPE E MUZZI EVELINOLOC. CASINO 40 1329 1971 PRUDENZI GIUSEPPE E ILIO LOC. VILLA FIORENTINA 40 1330 1971 SODA STEFANO VIA CASSIA – LOC. VIGNOLO 40 1328 1972 48 1652 COSTANTINI COSTANTINO E GIOVANNIVIA ONANESE 1972 SM. OVI. CA. (DITTA) – PERUZZI (SOCIETA')LOC. S. CATERINA 48 1651 1974 BERTANI M. -

Denominazione Tipologia Ore Posizione Cdc Codice Scuola Denominazione Scuola Nominativo Docente Graduatoria Cdc Cattedra Residue Gradutoria
DENOMINAZIONE TIPOLOGIA ORE POSIZIONE CDC CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE SCUOLA NOMINATIVO DOCENTE GRADUATORIA CDC CATTEDRA RESIDUE GRADUTORIA AD00 SOSTEGNO VTMM80101V SCUOLA SEC. I VALENTANO INTERNA MARIANI ELENA GPS II 344 AD00 SOSTEGNO VTMM80401A SCUOLA SEC. I CANINO INTERNA CATTANEO VALERIA GPS II 449 AD00 SOSTEGNO VTMM80401A SCUOLA SEC. I CANINO INTERNA DI VIRGINIO MASSIMILIANO GPS II 477 AD00 SOSTEGNO VTMM805016 SCUOLA SEC. I MONTALTO DI C. INTERNA BARELLA VALENTINA GPS II 544 AD00 SOSTEGNO VTMM805016 SCUOLA SEC. I MONTALTO DI C. INTERNA VETRALLINI ANDREINA GPS II 579 AD00 SOSTEGNO VTMM805016 SCUOLA SEC. I MONTALTO DI C. INTERNA SARTI BARBARA GPS II 634 AD00 SOSTEGNO VTMM805016 SCUOLA SEC. I MONTALTO DI C. INTERNA COLELLI AURA GPS II 635 AD00 SOSTEGNO VTMM80801N SCUOLA SEC. I GROTTE S. STEFANO INTERNA DELFINO MICHELA GPS II 321 AD00 SOSTEGNO VTMM80801N SCUOLA SEC. I GROTTE S. STEFANO INTERNA SARZANA IRENE GPS II 326 AD00 SOSTEGNO VTMM80901D SCUOLA SEC. I CAPRAROLA INTERNA LORETI MAURIZIO GPS II 510 AD00 SOSTEGNO VTMM80901D SCUOLA SEC. I CAPRAROLA INTERNA IANNI ADELE GPS II 558 AD00 SOSTEGNO VTMM81101D SCUOLA SEC. I SUTRI INTERNA CIPOLLARI MARTINA GPS II 484 AD00 SOSTEGNO VTMM81101D SCUOLA SEC. I SUTRI INTERNA CAREDDU MARGHERITA GPS II 430 AD00 SOSTEGNO VTMM81101D SCUOLA SEC. I SUTRI INTERNA PAIOLO CARLA GPS II 552 AD00 SOSTEGNO VTMM81101D SCUOLA SEC. I SUTRI INTERNA PONTREMOLESI MARTA GPS II 563 AD00 SOSTEGNO VTMM81101D SCUOLA SEC. I SUTRI INTERNA CIMETTA PAOLA GPS II 562 AD00 SOSTEGNO VTMM81101D SCUOLA SEC. I SUTRI INTERNA VACCAROTTI LOREDANA GPS II 575 AD00 SOSTEGNO VTMM81101D SCUOLA SEC. I SUTRI 12 PONTORIERO DANIELA GPS II 595 AD00 SOSTEGNO VTMM81101D SCUOLA SEC. -

Your Italy, Your Story Istituto Lorenzo De’ Medici
Ldm TUSCANIA Your Italy, Your Story Istituto Lorenzo de’ Medici OUR MISSION Istituto Lorenzo de’ Medici is committed to delivering a high-quality international learning experience through which students advance along their educational paths, develop their creativity, realize their own potential, and empower themselves to impact the world around them. Experiential learning is LdM’s main tool to foster students’ future professional development. THE ITALIAN INTERNATIONAL INSTITUTE Founded in 1973 in Florence, Istituto Lorenzo de’ The educational opportunities at each of LdM’s Medici (LdM) is among Italy’s most comprehensive three sites are deeply rooted in their surrounding and well-established international institutions in environments, allowing students to experience higher education. In addition to its main campus in first-hand the inspiring culture of both historical Florence, LdM has premises in Rome and Tuscania. and contemporary Italy. LdM integrates formal, Today, LdM hosts over 3000 students annually from university-level learning with an emphasis on all over the world. personal growth, individual engagement, and community responsibility. OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE IN INTERNATIONAL EDUCATION Istituto Lorenzo de’ Medici is affiliated with note on the quality of LdM facilities and academic institutions world-wide and is registered and environment. The LdM campuses in Florence, Rome authorized in Italy by the Ministry of Education, and Tuscania are approved by the U.S. Department (December 2, 1989); LdM is also accredited by the of Veterans Affairs. Tuscany Region as an educational institution (code LdM is also accredited by the CSN of the Swedish n. FI0735, decree n. 2935, July 4, 2012). government, by the Icelandic Student Loan Fund Istituto Lorenzo de’ Medici is approved by the US (LIN), and it has been awarded the European quality Middle States Commission on Higher Education as certification ISO 9001:2008 by EQA (European a branch campus of Marist College, with particular Quality Assurance). -

Florence // Rome // Tuscania
CIAO! ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE 2019 FLORENCE // ROME // TUSCANIA 1 Don’t just study Italian, live it... Istituto Lorenzo de’ Medici - The Italian International Institute Italian Language and Culture at LdM Founded in 1973 in Florence, Istituto Lorenzo de’ Medici (LdM) is among Italy’s most comprehensive and well-established international institutions, offering Italian Language courses as well as academic programs in higher education. LdM has premises in Florence, Rome and Tuscania, and thanks to over 45 years of experience and research in teaching Italian Language and Culture to foreigners, LdM is able to offer its students the highest quality education at an academic level. LdM Florence is located in the historic district of San Lorenzo, close to the famous Medici Chapel and the San Lorenzo Market. The campus encompasses 14 buildings in the historic city center. LdM Florence is perfect for students looking for an exciting blend of didactic offerings and cultural activities and bustling city-life, as well as an easy access to the tranquil Tuscan countryside. Courses at LdM Rome take place in a beautiful 19th century palace on Via XX Settembre, in the government and business district. The city’s unique metropolitan environment is comprised of small, lively neighbourhoods and picturesque districts. LdM Tuscania offers the opportunity to experience a true cultural immersion within the intimate setting of a medieval town located in central Italy, in the breathtaking countryside of the Maremma (about one hour drive from Rome). An untouched natural setting hosts a surprisingly large number of Etruscan necropolises and is home to the remains of ancient civilizations, which can be found all over the town and in the surrounding area. -

Geothermal State of Play Italy
Italy - State of the art of country and local situation Table of contents 1. Geothermal resources .......................................................................................................................................4 Geothermal potential ...................................................................................................................................4 Low-enthalpy geothermal potential ............................................................................................................5 Low-enthalpy geothermal reserves .............................................................................................................5 Location of geothermal reserves .................................................................................................................6 Hidrogeological considerations (lithology) .................................................................................................6 2. Geothermal exploitation installations ..............................................................................................................8 Locations of exploitation places ..................................................................................................................8 3. Hybrid geothermal installations .......................................................................................................................9 4. Case study ........................................................................................................................................................10 -

La Squadra Dell'istituto Agosti Di Bagnoregio Conquista Il Trofeo Città Di Montefiascone
This page was exported from - TusciaTimes.eu (.it) Export date: Sun Sep 26 21:07:18 2021 / +0000 GMT La squadra dell'istituto Agosti di Bagnoregio conquista il Trofeo Città di Montefiascone MONTEFIASCONE (Viterbo) ? La squadra dell'IO ?F. lli Agosti? di Bagnoregio guidata dalla professoressa Milva Ferlicca, coadiuvata dai colleghi Vittoria Angeli e Salvatore Paioletti, si aggiudica la prima edizione del ?Trofeo Città di Montefiascone? e si qualifica per disputare il ?Trofeo Città di Viterbo? in programma a Viterbo alla fine di maggio 2017. Si tratta della manifestazione conclusiva, a cui sono ammesse le quattro squadre vincitrici dei rispettivi gironi provinciali. L'evento, che si è tenuto a Montefiascone il 30 novembre scorso, rientra nella programmazione del Progetto ?Scuola-Movimento-Sport-Salute? per la realizzazione del quale si sono unite in un accordo di rete tutte le Scuole di I grado della Provincia di Viterbo e del quale è capofila l'IC ?L. Fantappiè? di Viterbo. Tale Progetto è patrocinato dal CONI Lazio, dall'Amministrazione Provinciale di Viterbo, dalla ASL di Viterbo, dall'Ordine dei Medici di Viterbo, dalla UIL Scuola di Viterbo ed è sostenuto dall'Ufficio Scolastico Provinciale. In particolare, il Trofeo ?Città di Montefiascone? è patrocinato e sostenuto dal Comune di Montefiascone. Oltre alla squadra vincitrice, hanno preso parte all'incontro la squadra dell'IC ?Via Ruspantini? di Grotte di C., guidata dai professori Carlo Palumbo, Adria Dionisi, Maria Paola Belli e Fabrizio Belli; la rappresentativa dell'IC ?P. Ruffini? di Valentano, guidata dai professori Sebastiano Sbocchia, Giancarlo Menichelli, Monica Balestra, Francesca Benincasa, Tamara Pasquini e la squadra dell'Istituto Omnicomprensivo di Acuapendente guidata dai professori Gabriella Dionisi, Silvia Galli, Federica Barbini e Dante Tramontana. -

Review of Blera: Topografia Na Tica Della Città E Del Territorio, by Stefania Quilici Gigli Russell Scott Bryn Mawr College, [email protected]
Bryn Mawr College Scholarship, Research, and Creative Work at Bryn Mawr College Greek, Latin, and Classical Studies Faculty Research Greek, Latin, and Classical Studies and Scholarship 1978 Review of Blera: Topografia na tica della città e del territorio, by Stefania Quilici Gigli Russell Scott Bryn Mawr College, [email protected] Let us know how access to this document benefits ouy . Follow this and additional works at: http://repository.brynmawr.edu/classics_pubs Part of the Classics Commons Custom Citation Scott, Russell T. Review of Blera: Topografia antica della città e del territorio, by Stefania Quilici Gigli. American Journal of Archaeology 82 (1978): 264-265. This paper is posted at Scholarship, Research, and Creative Work at Bryn Mawr College. http://repository.brynmawr.edu/classics_pubs/38 For more information, please contact [email protected]. 264 AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY [AJA 82 are identified with them relief) by comparison as BLERA. TOPOGRAFIA ANTICA DELLA CITTA E DEL Thasian work. The attributions to Thasos, often borne TERRITORIO, by Stefania Quilici Gigli. (DAI Rom, out by observation of the marble, are a particularly Sonderschriften 3-) PP- 318 (double convincing part of the book. They include the pedi- columns), mental sculptures of the Hieron at Samothrace and figs. 571, pls. 14 (12 line drawings, i aerial photo- also a series of draped statues found at Palestrina. The graph, I map). Philipp von Zabern, Mainz, 1976. fragment from Thasos usually assigned to the base DM 148. with the signature of Philiskos of Rhodes is shown not to belong to it and to be another piece in the early- This folio volume contains the results of five years' Hellenistic Thasian series. -

Viterbo) a Sinkhole in the Middle Valley of the River Tiber: Vadimone Lake
Mem. Descr. Carta Geol. d’It. XCIII (2013), pp. 381-392 figg. 6; tabb. 2 Un sinkhole nella media valle del Tevere: il lago di Vadimone (Viterbo) A sinkhole in the middle valley of the River Tiber: Vadimone lake PIRRO M. (*), PAGLIUCA M.N. (*), CAPRIOTTI D. (*), NISIO S. (**), GUARINO P.M. (**) RIASSUNTO - Nell’area di Orte (media valle del Tevere), in ABSTRACT - In proximity of the right bank of the middle prossimità della riva destra del Tevere, è ubicata una polla valley of Tiber [Lazio] in the Orte area, it is located a d’acqua, di forma sub-circolare, localmente conosciuta come pond, with a circular shape locally known as Lake laghetto Vadimone. Questo piccolo lago è famoso nella sto- Valdimone. This small lake is famous in the history be- ria perché la leggenda narra che in prossimità di esso, intorno cause the legend tells that near its sides, in the period al VII a.C. e il VI sec. a.C., fu combattuta una battaglia tra around the 7th-6th c. BC, was fought a bloody battle be- Romani ed Etruschi, in seguito alla quale questi ultimi furono tween Romans and Etruscans, following which the latter sconfitti definitivamente. definitively were defeated. La pianura alluvionale dove è ubicato il piccolo lago è The floodplain where is homonymous pool is also anche conosciuta con il toponimo di piana di Lucignano, ca- known with the toponym of Lucignano area which is ratterizzata dalla presenza di depositi di travertino di modesto characterized by a thin travertine deposits (Upper spessore di età Pleist. superiore-Olocene. -
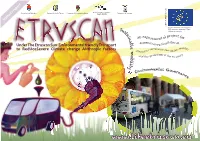
[[[ Pmjiixvywger Iy
Associazione Culturale Provincia di Viterbo Università della Tuscia Comune di Acquapendente Punti di Vista Provincia di Savona LIFE 08 ENV/IT/425 progetto realizzato con il supporto dell’Unione Europea 7YW XE rojec M n exp l p t fo R a erimenta r E F mons bility de trating feasi of Under The Etruscan Sun: Environmental friendly Transport P I obili ergie m t to RedUceSevere Climate change ANthropic factors en s for sus le y Q e t alternativ ainab S otion of y and prom the or F the territ M P M X ] SRQIRXEP+ RZMV SZIV ) RER GI [[[PMJIIXVYWGERIY Under the Etruscan Sun. Environmental friendly Transport to RedUce ETRUSCAN Severe Climate change ANthropic factors a local governance experience for alternative mobility with renewable energy ETRUSCAN is a sustainable mobility project with a strong local development component: this The PartNERSHIP . www.provincia.viterbo.gov.it - www.unitus.it www.comuneacquapendente.it www.conventobolsena.org/associazione_en.html www.provincia.sv.it three problems because it allows: [[[PMJIIXVYWGERIY * Istat 2012 heritage of the area, the two buses oer a e project has also promoted the installation service for students from the Tuscia Univer- of an exhausted vegetable oil reforming plant. sity, helping to reduce the trac of private COLLECTION OF At the same time the Province of Viterbo has vehicles; for the students of the schools of the initiated a project to collect exhausted vegetable Province they represent a chance to travel in WASTE OILS oil from households with the future goal of the local area through alternative and intrigu- Following the start of ETRUSCAN, the conveying the collected oil in the system and ing routes. -

Cancellazioni Maschi Assise 2012
TRIBUNALE DI VITERBO Elenco Giudici Popolari Corte d'Assise - biennio 2012/2014 - cancellandi maschi N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA RESIDENZA TITOLO STUDIO MOTIVI 1 ABBONDANZIERI GIANFRANCO ARCEVIA 01/09/1950 A040 ACQUAPENDENTE LICENZA MEDIA I Deceduto 2 AGOSTINI FILIPPO ACQUAPENDENTE 21/04/1952 A040 ACQUAPENDENTE MAT SCIENTIFICA Deceduto 3 AGOSTINI IPPOLITO ACQUAPENDENTE 30/04/1946 A040 ACQUAPENDENTE DIPL RAGIONERIA Raggiunti limiti eta 4 AGOSTINI SANTE GRADOLI 29/10/1945 E126 GRADOLI LICENZA MEDIA I Raggiunti limiti eta 5 ALESSANDRINI ENZO CIVITA CASTELLANA 18/05/1946 C765 CIVITA CASTELLA LIC. MEDIA Raggiunti limiti eta 6 ALESSI LANDO FABRICA DI ROMA 02/04/1946 C988 CORCHIANO PERITO INDUSTRI Raggiunti limiti eta 7 ALFONSI SIMONE ROMA 27/01/1978 A949 BOLSENA DIPLOMA EMIGRAZIONE 8 ALLEGRI GIANCARLO CIVITELLA D'AGLIANO 24/09/1945 C780 CIVITELLA D'AGL LICENZA MEDIA I Raggiunti limiti eta 9 AMADIO FRANCO VEJANO 18/05/1968 G111 ORIOLO ROMANO DIPLOMA EMIGRAZIONE 10 AMENDOLA PAOLO ROMA 24/10/1968 E978 MARTA DIPLOMA EMIGRAZIONE 11 ANDREOCCI BERNARDINO VIGNANELLO 20/04/1953 L612 VALLERANO LAUREA LINGUE EMIGRAZIONE 12 ANGELETTI ALDO CIVITA CASTELLANA 15/06/1947 C765 CIVITA CASTELLA LIC. MEDIA INFE Raggiunti limiti eta 13 ANGELETTI LANFRANCO CIVITA CASTELLANA 02/04/1947 C765 CIVITA CASTELLA LIC. MEDIA INFE Raggiunti limiti eta 14 ANGELETTI PIETRO CIVITA CASTELLANA 25/06/1946 C765 CIVITA CASTELLA LAUREA INGEGN Raggiunti limiti eta 15 ANGELINI ALBERTO NEPI 17/05/1946 C765 CIVITA CASTELLA MAT ARTISTICA Raggiunti limiti eta 16 ANGELONI PIETRO CELLERE 23/03/1946 B663 CAPODIMONTE LAUREA Raggiunti limiti eta 17 ANGELONI RICCARDO VELLETRI 11/11/1956 C780 CIVITELLA D'AGL LAUREA EMIGRAZIONE 18 ANGELUCCI MARIO CIVITELLA D'AGLIANO 14/08/1946 C780 CIVITELLA D'AGL PERITO AGRAGRIO Raggiunti limiti eta 19 ANTONAGLIA FRANCO BRACCIANO 12/08/1947 G111 ORIOLO ROMANO LIC. -

MARIANI Maggio 2011.Pdf
Ing. Antonio Mariani CURRICULUM VITAE San Lorenzo Nuovo Novembre 2012 Ing. Antonio Mariani Laureato in INGEGNERIA il 19 Luglio 1972 presso l’Università degli Studi di Roma con voti 104/110. Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo al n. 123 dal 1973 DATI ANAGRAFICI: Data e luogo di nascita : 16 Settembre 1946 San Lorenzo Nuovo (VT) Luogo di residenza : San Lorenzo Nuovo (VT) - Via Cassia Vecchia,4 Nazionalità : Italiana SEDE: Studio Tecnico in San Lorenzo Nuovo (VT) – Piazza Europa 12 TITOLO: CASA DI RIPOSO PER ANZIANI COMMITTENTE: EDILBS S.R.L. – SAN LORENZO NUOVO (VT) LOCALITA’: SAN LORENZO NUOVO (VT) ATTIVITA’ SVOLTA: CALCOLI STRUTTURALI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ANNO: 2011 IMPORTO OPERE: € 700.000,00 TITOLO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE DI TUSCANIA COMMITTENTE: PROVINCIA DI VITERBO LOCALITA’: TUSCANIA (VT) ATTIVITA’ SVOLTA: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CALCOLI STRUTTURALI ANNO: 2011 IMPORTO OPERE: € 1.000.000,00 TITOLO: AMPLIAMENTO FUNZIONALE HOTEL LIDO COMMITTENTE: HOTEL LIDO S.R.L. – BOLSENA (VT) LOCALITA’: BOLSENA (VT) ATTIVITA’ SVOLTA: CALCOLI STRUTTURALI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ANNO: 2010 – 2011 IMPORTO OPERE: € 870.000,00 TITOLO: COSTRUZIONE PLURIFAMILIARE IN C.A. COMMITTENTE: ZUCCA EDILIZIA LOCALITA’: SAN LORENZO NUOVO (VT) ATTIVITA’ SVOLTA: PROGETTAZIONE- CALCOLI STRUTTURALI- DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ANNO: 2010 IMPORTO OPERE: € 600.000,00 TITOLO: COSTRUZIONE PLURIFAMILIARE IN C.A. COMMITTENTE: EDILBS S.R.L. – SAN LORENZO NUOVO (VT) LOCALITA’: SAN LORENZO NUOVO (VT) ATTIVITA’ SVOLTA: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CALCOLI STRUTTURALI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ANNO: 2009 – 2011 IMPORTO OPERE: € 750.000,00 TITOLO: RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO S. -

Studio Di Fattibilità – Progetto Speciale Della Via Clodia
Comune di Tuscania Studio di fattibilità del Progetto speciale della via Clodia Paolo Gasparri Assotuscania Giugno 2010 Studio di fattibilità del Progetto speciale della via Clodia, Paolo Gasparri, Assotuscania, pag. 1/16 Ai nuovi Rasna Paolo Gasparri Uno speciale ringraziamento a: Pietro Massimiliano Bianco, Rita Fiasco, James Flege, Donato Limone, Luisa Marini, Anna Maria Salaparuta, Cinzia Salvi, Marco Tronconi Sommario Sommario .................................................................................................................................................. 2 Premessa.................................................................................................................................................... 3 Introduzione ............................................................................................................................................. 3 Progetto speciale della via Clodia ............................................................................................................. 3 Risultato atteso, obiettivi e azioni ............................................................................................................. 5 Obiettivo 1: Itinerari.................................................................................................................................. 5 Obiettivo 2: Territorio ............................................................................................................................... 6 Obiettivo 3: Storia ....................................................................................................................................