I Conti Di Valenza
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Anno Mese Giorno Specie Maschi Femmine Totale
COMUNE ANNO MESE GIORNO SPECIE MASCHI FEMMINE TOTALE Località esatta rilascio di rilascio 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Altavilla Monferrato Franchini 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Alfiano Natta Borghi 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Balzola Santa Clotilde 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Borgo San Martino Fornace 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Camagna Monferrato San Giorgio 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Camino Rocca delle Donne 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Camino Castel San pietro 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Castelletto Merli Cosso 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Cella Monte Varocara 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Popolo 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Rolasco 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione S. Germano 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Terranova 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Roncaglia 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione S. Maaria del Tempio 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Casale Monferrato Frazione Oltreponte 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Cerrina Monferrato Blengi 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Cerrina Monferrato Montalero 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Coniolo Ornea 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Conzano Pracino 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Frassinello MonferratoColombara 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Frassineto Po Valmacchina 2020 1 10 lepre comune 1 1 2 Frassineto Po str. -

Sub Ambito 01 – Alessandrino Istat Comune 6003
SUB AMBITO 01 – ALESSANDRINO ISTAT COMUNE 6003 ALESSANDRIA 6007 ALTAVILLA MONFERRATO 6013 BASSIGNANA 6015 BERGAMASCO 6019 BORGORATTO ALESSANDRINO 6021 BOSCO MARENGO 6031 CARENTINO 6037 CASAL CERMELLI 6051 CASTELLETTO MONFERRATO 6052 CASTELNUOVO BORMIDA 6054 CASTELSPINA 6061 CONZANO 6068 FELIZZANO 6071 FRASCARO 6075 FRUGAROLO 6076 FUBINE 6078 GAMALERO 6193 LU E CUCCARO MONFERRATO 6091 MASIO 6105 MONTECASTELLO 6122 OVIGLIO 6128 PECETTO DI VALENZA 6129 PIETRA MARAZZI 6141 QUARGNENTO 6142 QUATTORDIO 6145 RIVARONE 6154 SAN SALVATORE MONFERRATO 6161 SEZZADIO 6163 SOLERO 6177 VALENZA SUB AMBITO 02 – CASALESE ISTAT COMUNE 6004 ALFIANO NATTA 6011 BALZOLA 6020 BORGO SAN MARTINO 6023 BOZZOLE 6026 CAMAGNA 6027 CAMINO 6039 CASALE MONFERRATO 6050 CASTELLETTO MERLI 6056 CELLA MONTE 6057 CERESETO 6059 CERRINA MONFERRATO ISTAT COMUNE 6060 CONIOLO 6072 FRASSINELLO MONFERRATO 6073 FRASSINETO PO 6077 GABIANO 6082 GIAROLE 6094 MIRABELLO MONFERRATO 6097 MOMBELLO MONFERRATO 5069 MONCALVO 6099 MONCESTINO 6109 MORANO SUL PO 6113 MURISENGO 6115 OCCIMIANO 6116 ODALENGO GRANDE 6117 ODALENGO PICCOLO 6118 OLIVOLA 6120 OTTIGLIO 6123 OZZANO MONFERRATO 6131 POMARO MONFERRATO 6133 PONTESTURA 6135 PONZANO MONFERRATO 6149 ROSIGNANO MONFERRATO 6150 SALA MONFERRATO 6153 SAN GIORGIO MONFERRATO 6159 SERRALUNGA DI CREA 6164 SOLONGHELLO 6171 TERRUGGIA 6173 TICINETO 6175 TREVILLE 6178 VALMACCA 6179 VIGNALE MONFERRATO 6182 VILLADEATI 6184 VILLAMIROGLIO 6185 VILLANOVA MONFERRATO SUB AMBITO 03 – NOVESE TORTONESE ACQUESE E OVADESE ISTAT COMUNE 6001 ACQUI TERME 6002 ALBERA LIGURE 6005 -

Anno Scolastico 2018-19 PIEMONTE AMBITO 0011
Anno Scolastico 2018-19 PIEMONTE AMBITO 0011 - AL1 Elenco Scuole II Grado Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto ALPS01000P GALILEO GALILEI ALPS01000P GALILEO GALILEI NORMALE SPALTO BORGOGLIO ALESSANDRIA 49 ALIS01800X FERMI - NERVI ALIS01800X FERMI - NERVI NORMALE VIA A.MORBELLI 33 ALESSANDRIA ALRI01801G E.FERMI VIA A.MORBELLI 33 ALESSANDRIA ALTL01802N PIER LUIGI NERVI VIA MORBELLI 33 ALESSANDRIA ALTL01801L PIER LUIGI NERVI CARCERARIA CASA DI RECLUSIONE ALESSANDRIA ALTL018501 P.L. NERVI - C.A.T. SERALE VIA MORBELLI 33 ALESSANDRIA ALIS00600N LEONARDO DA VINCI ALIS00600N LEONARDO DA VINCI NORMALE VIA TROTTI 19 ALESSANDRIA ALRC00601L G.MIGLIARA VIA TROTTI 19 ALESSANDRIA ALTD00601X LEONARDO DA VINCI VIA TROTTI 19 ALESSANDRIA ALTD00652A I.T.COMMERCIALE L.DA SERALE VIA TROTTI 19 ALESSANDRIA VINCI ALTF01000R ALESSANDRO VOLTA ALTF01000R ALESSANDRO VOLTA NORMALE SPALTO MARENGO 42 ALESSANDRIA ALIS016008 SALUZZO - PLANA ALIS016008 SALUZZO - PLANA NORMALE VIA FAA' DI BRUNO ALESSANDRIA ALPC01601G GIOVANNI PLANA PIAZZA MATTEOTTI 29 ALESSANDRIA 85 ALPM01601Q DIODATA ROERO VIA FAA' DI BRUNO ALESSANDRIA SALUZZO 85 ALIS004002 BENVENUTO CELLINI ALIS004002 BENVENUTO CELLINI NORMALE -
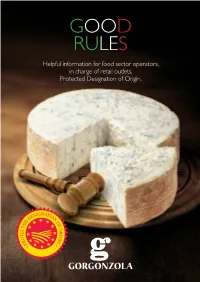
Good Rules Helpful Information for Food Sector Operators, in Charge of Retail Outlets
GOOD RULES Helpful information for food sector operators, in charge of retail outlets. Protected Designation of Origin. GNAT ESI IO D N D O E F T O C R E I G T I O N R • P • P. D.O. GORGONZOLA CHEESE With these brief notes we just wish to remind you of a few “important details” concerning the use of the Protected Designation of Origin for “Gorgonzola” cheese (upon slice sale, pre-packed sale, preparation of speciality food products, etc.), which, during our inspections of Retail Outlets, we have found to be inadequate, unconformable or even prosecutable. In line with the mutually beneficial relationship that exists among those involved in the “fieldwork”, we would like to thank you in advance for the time you may wish to devote to us. The Ispectors of the Consortium for the Protection of Gorgonzola Cheese THE PRODUCT SOFT TABLE CHEESE MADE FROM UNHEATED CURD, BELONGING TO THE CATEGORY OF MOULD-RIPENED CHEESES, (CHEESES FEATURING A RANGE OF VERTICAL BLUE AND GREEN VEINS, ALSO REFERRED TO IN ITALIAN AS “ERBORINATURA”). THERE ARE TWO VARIETIES ON SALE: SWEET SPICY GORGONZOLA GORGONZOLA CHEESE CHEESE Origin branding performed on both faces of thecheese wheel, bearing the initials CG, as well as the identification number of the of the applica- ble cheese factory. Branding upon placing on the market, by means of the second identification mark re- lated to P.D.O. Gorgonzola cheese: this consists in individual embossed aluminium sheets used to wrap the vari- ANDING ous portions of product. Upon placing the product on the market, it will al- R ways be necessary to trace back to the origin and to the specific batch of the product on display, marketed and/or used by the Retail Outlet. -

Il Turismo Nell'area Del Parco Di Crea
Il turismo nell’area del Parco di Crea. Ires Piemonte (Maurizio Maggi, Carlo Beltrame, Elena Ciarli, Emanuela Giorgini) marzo 2002 PARTE PRIMA: Il quadro territoriale di Crea e l’analisi dell’intorno 1. Il quadro territoriale allargato - Crea, il Santuario, il Parco - Il quadro europeo - Il quadro regionale 2. I Piani territoriali provinciali - Il PTP di Alessandria - Il PTP di Asti - Il PTP di Vercelli 3. Il quadro locale - Fra Basso Monferrato e risaie - La città di Casale - Il quadro occupazionale - Il quadro turistico PARTE SECONDA: Domanda e offerta turistica 1. Il contesto locale 2. La domanda turistica - Costi e benefici del turismo - Trend recenti e prospettive - L’indagine sul pubblico 3. L’offerta del territorio - Le strutture di accoglienza - Il turismo itinerante - Gli itinerari 4. Aspetti qualitativi 5. Proposte di intervento a livello locale 6. Conclusioni 7. Nota metodologica Il presente rapporto è opera di un gruppo di lavoro composto da Carlo Beltrame (autore del- la Parte prima), Elena Ciarli (autrice del capitolo 4 parte seconda), Emanuele Giorgini (autri- ce dei capitoli 2 e 7, parte seconda) e Maurizio Maggi (coordinatore). La responsabilità di quanto scritto è interamente da attribuirsi all’Ires Piemonte. Il turismo nell’area del Parco di Crea 1 PARTE PRIMA Il QUADRO TERRITORIALE DI CREA E L’ANALISI DELL’INTORNO Il turismo nell’area del Parco di Crea 2 1. IL QUADRO TERRITORIALE ALLARGATO Il turismo nell’area del Parco di Crea 3 CREA, IL SANTUARIO, IL PARCO Crea, il Santuario e l’area a parco naturale, sono certamente la località più “visitata” della provincia di Alessandria e tra le più “visitate” del Piemonte. -

Comune San Giorgio Monferrato
Comune San Giorgio Monferrato Categoria: Comuni Indirizzo: via Cavalli d'Olivola 1 - 15020 - San Giorgio Monferrato Telefono: +39 (0142) 806.121 Fax: +39 (0142) 806.184 E-mail: [email protected] Descrizione Borgo su cui svetta il Castello, il quale si presenta con l’immagine dell’importante restauro ottocentesco ma che nasconde anche spazi barocchi e neoclassici; dal giardino all’italiana si gode di una splendida vista sul territorio circostante. Per maggiori informazioni si rimanda al PODCAST sul sito www.ilsognodialeramo.it (indicato di seguito). * * * LA STORIA Il territorio di San Giorgio fece parte fin dai tempi più remoti del così detto “distretto” di Sant’Evasio. L’omonimo Castello, sotto il profilo documentale, è pure da ritenersi, secondo valenti storici, il più antico fra i castelli del Monferrato. La prima attestazione riferibile alla presenza di San Giorgio è del 999, in un diploma di Ottone III a favore del Vescovo di Vercelli. Federico Barbarossa nel 1152 confermava al Vescovo vercellese la proprietà del castello e del nascente borgo. Nel 1306 San Giorgio compare come libero Comune. Tra i successivi feudatari: Gian Giorgio Paleologo, ultimo della stirpe, i Gozzani e i Cavalli d'Olivola. Links https://www.ilsognodialeramo.it/it/buffer-zone/ http://www.comune.sangiorgiomonferrato.al.it I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. -

ORARI AUTOLINEE PARTENZE Da CASALE MONFERRATO - Piazza VITTORIO VENETO (FS) Per Le Seguenti Località - DAL 10.09.2013
ORARI AUTOLINEE PARTENZE da CASALE MONFERRATO - Piazza VITTORIO VENETO (FS) per le seguenti località - DAL 10.09.2013 DESTINAZIONE PARTENZA STALLO FREQUENZA ARRIVO FERMATE INTERMEDIE (orario di arrivo alle fermate intermedie) VETTORE ORA NR ORA MORTARA 5:40 11 feriale dal lunedì al sabato 6:27 Terranova (5.54) Candia L. (6.02) Cozzo (6.05) AUTOTICINO S.T.A.C. VERCELLI 5:45 11 feriale dal lunedì al sabato 6:15 Diretto AUTOTICINO S.T.A.C. TRINO 5:55 55 feriale dal lunedì al sabato 6:17 Morano (6.07) AUTOTICINO S.T.A.C. MORTARA 6:05 33 feriale dal lunedì al sabato 6:52 Terranova (6.19) Candia L. (6.27) Cozzo (6.30) AUTOTICINO S.T.A.C. ALESSANDRIA 6:20 88 feriale dal lunedì al sabato 7:08 Occimiano (6.37) Mirabello (6.41) San Salvatore (6.48) Castelletto M. (6.51) Gerlotti (6.54) ARFEA ASTI 6:20 22 feriale dal lunedì al sabato 7:28 S. Giorgio C. (6.30) Ozzano (6.34) Serralunga (6.39) Moncalvo (6.48) Tonco (7.04) - Castel’Alfero (7.11) - Portacomaro (7.17) AUTOTICINO S.T.A.C. TORINO 6:35 55 feriale dal lunedì al venerdì 8:20 Morano (6.47) Trino (6.55) Palazzolo (7.01) Fontanetto (7.05) Crescentino (7.10) AUTOTICINO S.T.A.C. MILANO - FAMAGOSTA 6:42 44 feriale dal lunedì al venerdì 8:13 Valenza FS (7.04) Valenza (7.08) Grava (7.21) Sale (7.24) Castelnuovo Scrivia (7.31) AUTOTICINO S.T.A.C. VERCELLI 6:47 44 feriale dal lunedì al feriale venerdì dal nel lunedì periodo al venerdì scolastico nel periodo 7:25 scolastico Villanova (7.00) Stroppiana (7.05) AUTOTICINO S.T.A.C. -

Prefettura Ufficio Territoriale Del Governo Di Alessandria
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria RIPARTIZIONE TERRITORIALE Al fine di una più equa e capillare distribuzione sul territorio e in modo da assicurare quanto più possibile la proporzionalità del numero dei migranti da accogliere rispetto alla popolazione residente nella Provincia, si individuano le seguenti fasce di distribuzione, con l’indicazione del numero di richiedenti asilo complessivamente assegnabili in ogni comune. 1- Comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti 20 posti Albera Ligure Cuccaro Monferrato Paderna Alfiano Natta Denice Pareto Alice Bel Colle Dernice Parodi Ligure Alluvioni Cambiò Fabbrica Curone Pasturana Altavilla Monferrato Felizzano Pecetto di Valenza Alzano Scrivia Fraconalto Pietra Marazzi Avolasca Francavilla Bisio Piovera Balzola Frascaro Pomaro Monferrato Basaluzzo Frassinello Monferrato Pontestura Bassignana Frassineto Po Ponti Belforte Monferrato Fresonara Ponzano Monferrato Bergamasco Frugarolo Ponzone Berzano di Tortona Fubine Pozzol Groppo Bistagno Gabiano Prasco Borghetto di Borbera Gamalero Predosa Borgo San Martino Garbagna Quargnento Borgoratto Alessandrino Gavazzana Quattordio Bosco Marengo Giarole Ricaldone Bosio Gremiasco Rivalta Bormida Bozzole Grognardo Rivarone Brignano-Frascata Grondona Rocca Grimalda Cabella Ligure Guazzora Roccaforte Ligure Camagna Monferrato Isola Sant'Antonio Rocchetta Ligure Camino Lerma Rosignano Monferrato Cantalupo Ligure Lu Sala Monferrato Capriata d'Orba Malvicino San Cristoforo Carbonara Scrivia Masio San Giorgio Monferrato Carentino -

Uffici Stato Civile/Servizi Demografici
COMUNI DELLA PROVINCIA DI COMUNE DI ALLUVIONI PIOVERA ALESSANDRIA Via Roma, 67 - Loc. Alluvioni (Montariolo) 15040 Alluvioni Piovera (AL) (Uffici Stato Civile/Servizi Ufficio Stato Civile demografici) telefono: 0131.848121 fax: 0131.848237 I seguenti dati sono stati raccolti consultando i siti e-mail: [email protected] internet istituzionali dei singoli Comuni nelle date 03/11/2015-04/12/2015; è opportuno verificarne l’attualità al momento dell’utilizzo. L’unico COMUNE DI ALTAVILLA MONFERRATO aggiornamento successivo qui apportato è relativo Viale Unità d’Italia 17 ai dati del Comune di Alluvioni Piovera. 15041 Altavilla Monferrato (AL) Non sono indicate le e-mail certificate in quanto il Ufficio servizi demografici presente indirizzario è stato creato prevalen- telefono: 0142 2936956 temente per supportare le ricerche genealogiche e-mail: individuali non istituzionali. [email protected] COMUNE DI ACQUI TERME Piazza Levi, 12 COMUNE DI ALZANO SCRIVIA 15011 Acqui Terme (AL) Piazza Pietro Bassi, 23 Ufficio Stato Civile 15050 Alzano Scrivia (AL) telefono: 0144770255 Ufficio servizi demografici fax: 014457627 telefono e fax: 0131 854382 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] COMUNE DI ALBERA LIGURE COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA via Roma, 1 Piazza Bertelli, 21 15060 Albera Ligure (AL) 15061 Arquata Scrivia (AL) telefono: 0143 90051 Ufficio Stato Civile fax : 0143 90159 telefono: 0143 600405; 0143 600424 e-mail: [email protected] fax 0143 600432 e-mail: [email protected] COMUNE DI ALESSANDRIA Piazza della Libertà, 1 COMUNE DI AVOLASCA 15121 Alessandria Via Municipio, 4 Ufficio Stato Civile 15050 Avolasca (AL) telefono: 0131 515218 - 0131 515206 Ufficio servizi demografici fax: 0131 515362 - 0131 515412 telefono: 0131 876502 e-mail: [email protected] fax 0131 876503 e-mail: [email protected] COMUNE DI ALFIANO NATTA Via Stazione, 1 COMUNE DI BALZOLA 15021 Alfiano Natta (AL) Via Roma n. -

CONFIDENTIAL Mondo
Mon.D.O. Monferrato (Demand and Supply) www.monferrato.org HOSPITALITY Casale Monferrato, August 2016 Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) – Consortium of Promotion Turistic; Via XX Settembre 7, Casale Monferrato (AL) www.monferrato.org, [email protected] 1 Mon.D.O. Monferrato (Demand and Supply) www.monferrato.org "Notes of hospitality" for every need Monferrato and the nearby plain of the Po are growing. There are many new facilities open, the accommodation facilities for example, (B&B, farm ..) The rates vary, too. The advice is always to set the price at time of booking. The words "Member of Mon.D.O." highlight the structures working with the Consortium. "Monferrato, a great food and wine tradition" Monferrato, a land with great wine vocation, offers a wide and important choice of wines, Barbera, Grignolino, Freisa, Malvasia, the white Chardonnay, etc., while the cuisine offers Monferrato typical dishes, agnolotti, mixed fry and boiled meat with a trio of Bagnet (sauces) and, as far as the plain is concerned, salami, marinated fish, rice and beans, frogs, snails. In season, mushrooms and truffles. Among the desserts, krumiri, bunet, panna cotta, tarts. “Monferrato, tradition and innovation” The vitality of an area is also measured by the opportunities for meetings, leisure activities and aggregation that are offered and in this sense our Monferrato offers extraordinary vivacity. There is a very rich schedule of events, which can be viewed on the site www.monferrato.org. By car, on foot or by bicycle, on horseback or with the river easy rafting, the Casale Monferrato area and the plain of the Po await you with their warmest welcome. -

Monferrato Casalese - Dossier
Monferrato Casalese - Dossier The Monferrato area is part of the provinces of Asti and Alessandria, in Piedmont, in the north west of Italy; the area has a favourable position, located at the center of the triangle between the main industrial cities of Turin, Milan and Genoa. The area called Monferrato Casalese, in particular, is located between the plain of the river Po and the Monferrato hills; in this region can be found the town of Casale Monferrato (the historical capital) and about sixty municipalities, with a population of 110.000 people. Two different Unesco World Heritage Sites can also be found in the Monferrato Casalese: the Sacred Mount of Crea (that is part of the Sacred Mounts of Piedmont and Lombardy) and Monferrato of the Infernot (one of the six areas in The Vineyard Landscape of Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato). The local economy embraces all sectors. As regards the primary sector, vine-growing dominates the Monferrato area, where different DOC wines are produced (for example Barbera, Grignolino, etc.); the cultivation of rice and other cereals also has an important role in the local agricultural economy, as do market gardens and plain and tree crops (above all poplar trees). Not to be forgotten is the production of truffles and cognac as well as other food products. Industrial and service sectors play a vital role in the local economy. Multinational companies operating in the cement and logistic fields have their headquarters in the town of Casale Monferrato. There are also successful companies operating in engineering (such as refrigeration, typographical machineries and machine tools, etc.), textile and clothing (cashmere, etc.), woodwork and paper manufacture and food conservation. -

Official Journal C 435 of the European Union
Official Journal C 435 of the European Union Volume 61 English edition Information and Notices 3 December 2018 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2018/C 435/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9125 — Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe) (1) 1 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES Council 2018/C 435/02 Notice for the attention of a person subject to the restrictive measures provided for in Council Decision 2014/119/CFSP and in Council Regulation (EU) No 208/2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine ........................ 2 2018/C 435/03 Notice for the attention of the data subjects to whom the restrictive measures provided for in Council Regulation (EU) No 208/2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine apply ..................................................................... 3 European Commission 2018/C 435/04 Euro exchange rates .............................................................................................................. 4 EN (1) Text with EEA relevance. 2018/C 435/05 Commission Implementing Decision of 21 November 2018 on the publication in the Official Journal of the European Union of the application for registration of a geographical indication in the spirit drinks sector referred to in Article 17 of Regulation