Tesi Rosaci Fabiana.Docx
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Politics of Roman Memory in the Age of Justinian DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the D
The Politics of Roman Memory in the Age of Justinian DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Marion Woodrow Kruse, III Graduate Program in Greek and Latin The Ohio State University 2015 Dissertation Committee: Anthony Kaldellis, Advisor; Benjamin Acosta-Hughes; Nathan Rosenstein Copyright by Marion Woodrow Kruse, III 2015 ABSTRACT This dissertation explores the use of Roman historical memory from the late fifth century through the middle of the sixth century AD. The collapse of Roman government in the western Roman empire in the late fifth century inspired a crisis of identity and political messaging in the eastern Roman empire of the same period. I argue that the Romans of the eastern empire, in particular those who lived in Constantinople and worked in or around the imperial administration, responded to the challenge posed by the loss of Rome by rewriting the history of the Roman empire. The new historical narratives that arose during this period were initially concerned with Roman identity and fixated on urban space (in particular the cities of Rome and Constantinople) and Roman mythistory. By the sixth century, however, the debate over Roman history had begun to infuse all levels of Roman political discourse and became a major component of the emperor Justinian’s imperial messaging and propaganda, especially in his Novels. The imperial history proposed by the Novels was aggressivley challenged by other writers of the period, creating a clear historical and political conflict over the role and import of Roman history as a model or justification for Roman politics in the sixth century. -

The Formulaic Dynamics of Character Behavior in Lucan Howard Chen
Breakthrough and Concealment: The Formulaic Dynamics of Character Behavior in Lucan Howard Chen Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2012 © 2012 Howard Chen All rights reserved ABSTRACT Breakthrough and Concealment: The Formulaic Dynamics of Character Behavior in Lucan Howard Chen This dissertation analyzes the three main protagonists of Lucan’s Bellum Civile through their attempts to utilize, resist, or match a pattern of action which I call the “formula.” Most evident in Caesar, the formula is a cycle of alternating states of energy that allows him to gain a decisive edge over his opponents by granting him the ability of perpetual regeneration. However, a similar dynamic is also found in rivers, which thus prove to be formidable adversaries of Caesar in their own right. Although neither Pompey nor Cato is able to draw on the Caesarian formula successfully, Lucan eventually associates them with the river-derived variant, thus granting them a measure of resistance (if only in the non-physical realm). By tracing the development of the formula throughout the epic, the dissertation provides a deeper understanding of the importance of natural forces in Lucan’s poem as well as the presence of an underlying drive that unites its fractured world. Table of Contents Acknowledgments ............................................................................................................ vi Introduction ...................................................................................................................... -

ROMANIZATION and SOME CILICIAN CULTS by HUGH ELTON (BIAA)
ROMANIZATION AND SOME CILICIAN CULTS By HUGH ELTON (BIAA) This paper focuses on two sites from central Cilicia in Anatolia, the Cory cian Cave and Kanhdivane, to make some comments about religion and Romanization. From the Corycian Cave, a pair of early third-century AD altars are dedicated to Zeus Korykios, described as Victorious (Epinikios), Triumphant (Tropaiuchos), and the Harvester (Epikarpios), and to Hermes Korykios, also Victorious, Triumphant, and the Harvester. The altars were erected for 'the fruitfulness and brotherly love of the Augusti', suggesting they come from the period before Geta's murder, i.e. between AD 209 and 212. 1 These altars are unremarkable and similar examples are common else where, so these altars can be interpreted as showing the homogenising effect of the Roman Empire. But behind these dedications, however, may lie a re ligious tradition stretching back to the second millennium BC. At the second site, Kanhdivane, a tomb in the west necropolis was accompanied by a fu nerary inscription erected by Marcus Ulpius Knos for himself and his family, probably in the second century AD. Marcus then added, 'but if anyone damages or opens [the tomb] let him pay to the treasury of Zeus 1000 [de narii] and to the Moon (Selene) and to the Sun (Helios) above 1000 [denarii] and let him be subject to the curses also of the Underground Gods (Kata chthoniai Theoi). ' 2 When he wanted to threaten retribution, Knos turned to a local group of gods. As at the Corycian Cave, Knos' actions may preserve traces of pre-Roman practices, though within a Roman framework. -

Wonder, Space, and Place in Pausanias' Periegesis
Axion Theas: Wonder, Space, and Place in Pausanias’ Periegesis Hellados by Jody Ellyn Cundy A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Classics University of Toronto © Copyright by Jody Ellyn Cundy 2016 Axion Theas: Wonder, Space, and Place in Pausanias’ Periegesis Hellados Jody Ellyn Cundy Doctor of Philosophy Department of Classics University of Toronto 2016 Abstract The Periegesis Hellados presents a description of the sites and sights of Roman Greece in ten carefully constructed books. These books present the fruits of author’s extensive travels and careful textual research over the course of several decades (between the 130’s and ca. AD 175-80) and compiled into a unified composite itinerary. There is no doubt that Pausanias travels through an “already written landscape,” and his travel experience is necessarily informed by and sometimes clearly motivated by his literary encounters. This project investigates Pausanias’ engagement with literary antecedents, with a particular focus on the antiquarian impulse to excerpt and compile anecdotes in thematic catalogues, which broadly resemble wonder-texts (paradoxographies). The organizing principle of these thematic catalogues contrasts with the topographical (spatial) structure of the frame narrative of the Periegesis. In part, this study aims to resolve the perceived tension between the travel account and the antiquarian mode in Pausanias’ project in order to show that they serve complementary rather than competing ends. Resolution of these competing paradigms allows in turn for a more coherent understanding of the Periegesis as unified subject. This study argues that wonder (thauma) is a unifying theme ii of Periegesis Hellados. -

Chronicle of Michael the Syrian and the Armenian Version (1248): a Textual Comparison
The Chronicle of Michael the Great, Patriarch of the Syrians Translated from Classical Armenian by Robert Bedrosian For Reverend Father Krikor Vardapet Maksoudian, who taught me the language Sources of the Armenian Tradition (Long Branch, N.J., 2013) This work is in the public domain. It may be copied and distributed freely. Maps: From Atlas Antiquus (Berlin, 1869) by Heinrich Kiepert: Asia Minor and Neighbors Syria Mesopotamia Greater Cappadocia Armenia and Neighbors Additional maps are available on the Maps page. Chronological tables are available on the Chronological Tables page. Translator's Preface Composite 1871 Edition 1870 Edition 1871 Edition (below) The Chronicle of Michael the Great, Patriarch of the Syrians The following Table of Contents for the Composite 1871 edition was created for the convenience of readers and is not part of the Armenian text. Author's Preface Sources Problems of Chronology Adam Seth Jared; Mt. Hermon Chaldean Kings Methusaleh Noah Sons of Noah and Their Lands Tower of Babel The Amazons Rulers of Babylon Abraham Shamiram (Semiramis) Jacob Moses Exodus Judges Saul Solomon The Queen of Sheba and Her Riddles Rulers after Solomon Tiglathpilesar Shalmaneser Darius, Daniel, Cyrus Xerxes, B.C. 486-465 Persian Kings Alexander, B.C. 356-323 Ptolemy, B.C. 323-285 Translators of the Bible Haykazean Kings Maccabees, B.C. 167-160 138 B.C. 90 B.C. Genealogy of Herod Barzaphran Julius Caesar, B.C. 100-44 Herod's Rule over the Jews Cleopatra, reigned B.C. 51-30 Birth of Jesus Coming of the Magi Selection of the Apostles Selection of the Disciples Philo, Jewish Sects Abgar, King of Edessa Claudius, A.D. -

Ms 4. Yüzyilda Isauria Eyaleti'nin Siyasal Ve Idari
MS 4. YÜZYILDA ISAURIA EYALETİ’NİN SİYASAL VE İDARİ YAPISI MEHMET KURT* Giriş Antik Isauria, Anadolu’nun güneyinde doğudan Kilikia Trakheia/Kilikia Aspera (Dağlık Kilikia), batıdan Pamphylia ve kuzeyden de Lykaonia ile sınır- lanmış oldukça dağlık bir bölgedir (Harita)1. Bölgenin özellikle Toros dağlarının batı kesimlerinde yer alan bölümü son derece engebeli olup, akarsular tarafından parçalanmış çok sayıda vadi ve kanyondan oluşmaktadır. Bu durumunun istisna- larını ise kıyı kesimi ve Kalykadnos (Göksu) Vadisi oluşturmaktadır. Hierokles2’in Isauria Eyaleti’nin metropolis Seleukeia olmak üzere 23 kentini sıraladığı listeden ve Constantinus Porphyrogenitus3’un saymış olduğu Isauria dekapolisinden de açıkça * Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Karaman/ TÜRKİYE, [email protected] 1 W. Ruge, “Isauria”, RE IX/2, 1916, s. 2056. Isauria ve Isaurialılar hakkında detaylı bilgi ve literatür için bkz. J. Matthews, The Romans Empire of Ammianus with a new introduction, Michigan Classical Press, London 1989, ss. 355-367; B. D. Shaw, “Bandit Highlands and Lowland: The Mountains of Isauria-Cilicia”, Journal of the Economic and Social History of the Orient XXXIII/3, 1990, ss. 237-270; N. Lenski, “Assimilation and Revolt in the Territory of Isauria, from the 1st Century BC to the 6th Century AD”, Journal of the Economic and Social History of the Orient XLII/4, 1999, ss. 413-465; S. Dmitriev, “Observations on the Historical Geography of Roman Lycaonia”, Greek, Roman, and Byzantine Studies 41, 2000, ss. 350-357. Haritanın hazırlanmasında J. Matthews, The Roman Empire of Ammianus with a new Introduction, s. 356, Map 8’den faydalanılmıştır. 2 Hierok. 708.1-710.9’da kıyı ve iç Isauria’da yer alan 23 kent şu şekilde sıralanmaktadır: Seleucia metropolis, Celesdere, Anemurium, Titiopolis, Lamus, Antiochia, Juliosebaste, Cestri, Selinus, Iotape, Diocaesarea, Olbe, Claudiopolis, Hieropolis, Dalisandus, Germanicopolis, Irenopolis, Philadelphia, Moloe, Darasus, Zeede, Neapolis, Lauzados. -

THE REACH of the ROMAN EMPIRE in ROUGH CILICIA by HUGHW.ELTON
THE ECONOMIC FRINGE: THE REACH OF THE ROMAN EMPIRE IN ROUGH CILICIA By HUGHW.ELTON Many discussions of the Roman economy are rather vague about what they mean by 'Roman'. Phrases such as 'Roman Europe' or 'the Roman Empire' often blur two different concepts, that of the cultures of Iron Age Europe and the political institution of the Roman Empire. Cultures in Iron Age Europe varied widely. The Welsh uplands or the Atlas mountains, for example, had an aceramic culture with few public buildings, though were mIed directly by Rome for several centuries. Other regions, not under Roman control, like the regions across the middle Danube, showed higher concentrations of Mediterranean consumer goods and coins than some of these aceramic areas. 1 In Mesopotamia, many societies were urban and literate, not differing in this respect from those in Italy or Greece. Thus, determining what was imperial Roman territory by archaeological criteria alone is very difficult? But these archaeological criteria are important for two reasons. First, they allow us to analyse the cultural and economic changes that occurred in Iron Age Europe between 100 B.C. and A.D. 250. Second, they allow for the possibility of change within Europe that was not caused by the Roman state? Unlike cultures within Iron Age Europe, the Roman Empire was a political structure, imposed by force and dedicated to extracting benefits for the mling elite of the city of Rome.4 As the empire developed and matured, its form changed, but it was never about the mIed, only the rulers. If we accept that the Empire was a political, not an archaeological, structure, it follows that an examination of 'Impact of Empire: Transformation of Economic Life', has to mean an examination of the impact of the Roman imperial state. -
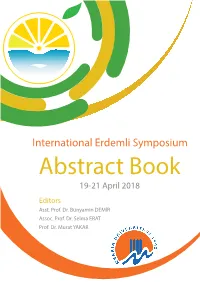
International Erdemli Symposium Abstract Book 19-21 April 2018 Editors Asst
International Erdemli Symposium Abstract Book 19-21 April 2018 Editors Asst. Prof. Dr. Bünyamin DEMİR Assoc. Prof. Dr. Selma ERAT Prof. Dr. Murat YAKAR International Erdemli Symposium was held on April 19-21, 2018 in Mersin Province Erdemli District. Erdemli is the 6th largest district of the Mersin Province and is at the forefront with its large and deep history, rich cultural accumulation, unique natural beauties, springs, historical sites and important agricultural facilities. It is thought that there are many issues that need to be produced and evaluated about Erdemli, which continues to develop and grow, at present and in future. For this purpose, it was aimed to create an awareness of ideas and project proposals about Erdemli to be discussed in a scientific atmosphere and to share it with public. In addition to that, this symposium could be a platform in which business or research relations for future collaborations will be established. International Erdemli symposium has received quite high interests from academician sides. We had in total 350 presentations from different universities. The symposium was organized in Erdemli by Mersin University with collaboration of municipality of Erdemli for the first time and internationally and free of charge. We believe that the symposium will be beneficial to our city Mersin and our country Turkey. As organizing committee, we believe that we had a successful symposium. We gratefully thank to the scientific committee of the symposium, all of the speakers, all of the participants, all of the students, all of the guests and also the press members for their contributions. On behalf of the organizing committee. -

Board of Missions
PROCEEDING-S OF THE BOARD OF MISSIONS OF TH E PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA, A T T H E IH iFttst gftfronfal Sttnttna, Held in the City o f Philadelphia, on the 6th day of September, A. D. 1838, and continued by adjournments to the 11th of the same month. TOGETHEB WITH THE REPORTS OF TH E DOMESTIC AND FOREIGN COMMITTEES, THE REPORT OF THE BOARD TO THE GENERAL CONVENTION, AND TH E REPORT OF A SPECIAL COMMITTEE, MADE BY THE REV. DR. JARVIS. NEW-YORK: t PRINTED BY WILLIAM OSBORN, 88 William-street. M DCCC XXXVIII. PROCEEDINGS OF T H E BOARD OF MISSIONS. TRIENNIAL MEETING. Philadelphia, September 6, 1838. T h e Triennial Meeting of the Board of Missions of the Protestant Episcopal Church in the United States of America, was held this day at St. Andrew’s church, at 5 o’clock, P. M. Present: The Rt.Rev. Bishops Moore, Bowen, Chase, Brow nell, H. U. Onderdonk, Meade, B. T. Onderdonk, M‘Ilvaine, Doane, and McCoskry;—The Rev. Messrs. Allen, Anthon, Boyd, Burroughs, Carder, Croswell, De Lancey, Dorr, Dunn, Ducachet, Edson, Forbes, Hawks, Jackson, Jarvis, Johns, Jones, Mason, Mead, Milnor, Morehouse, Prestman, Rodney, Tyng, Vaughan, Watson, and the Secretary,—Messrs. Ec- cleston. Huntington, Lovell, Morris, Newton, Nicklin, Stuy- vesant and Wharton. The Rt. Rev. Bishop Moore opened the meeting with prayer. The roll having been called, it was on motion of the Se cretary, Resolved, That the reading of the minutes of the last meeting be dispensed with. The Rev. Mr. Vaughan, the Secretary and General Agent of the Foreign Committee, reported that Henry I. -

Cilicia at the Crossroad of Eastern Mediterranean Trade Network, Panel 5.16, Archaeology and Economy in the Ancient World 35 (Heidelberg, Propylaeum 2020) 53–62
Elaiussa Sebaste: Monetization Annalisa Polosa The term “economy” normally means production, circulation and consumption of goods and services.1 Coins generally play a marginal role in the studies on ancient economies, and this can easily be explained by the fact that coins were not the only medium of exchange in archaic economies, and by the limited range of transactions that were operated through struck coins, whose function has long been intended only for state and military expenses, taxes, and long distance trade, and that is hardly used, at its beginnings, in exchanges of a lesser value.2 Figs. 1–2: Mallos stater (ANS 1969.66.2). However, the more archaeological research becomes refined, the more numismatic data from excavations become an important testimony of economic activities. And intensive studies on coin production in antiquity have shown, long since, that ancient monetary systems had complex structures, often comprising plentiful series of small fractions in precious metals, joined, at the end of the 5th century BCE, by bronze coins that widened the range of operations that could be achieved through coins.3 The examples of developed monetary systems in classical times’ Cilicia are numerous, and one good example can be the output of the mint of Mallos (fig. 1–4), displaying fractions up to the tetartemorion (i.e. 1/4 obol).4 The importance of small change has been a matter of great importance in the last decades:5 thus state expenses, military pay, long distance trade above mentioned must be considered together with the presence of civic institutions, spectacle buildings, local and regional festivals and games: all these elements can involve circulation, especially of low value coins, whose role raises when small silver denominations are joined by bronze of lesser value, as stated above, allowing coined money to be useful for a wider range of transactions. -

Adalya 23 2020
ISSN 1301-2746 ADALYA 23 2020 ADALYA ADALYA 23 2020 23 2020 ISSN 1301-2746 ADALYA The Annual of the Koç University Suna & İnan Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations (OFFPRINT) AThe AnnualD of theA Koç UniversityLY Suna A& İnan Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations (AKMED) Adalya, a peer reviewed publication, is indexed in the A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) and CC/A&H (Current Contents / Arts & Humanities) Adalya is also indexed in the Social Sciences and Humanities Database of TÜBİTAK/ULAKBİM TR index and EBSCO. Mode of publication Worldwide periodical Publisher certificate number 18318 ISSN 1301-2746 Publisher management Koç University Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer / İstanbul Publisher Umran Savaş İnan, President, on behalf of Koç University Editor-in-chief Oğuz Tekin Editors Tarkan Kahya and Arif Yacı English copyediting Mark Wilson Editorial Advisory Board (Members serve for a period of five years) Prof. Dr. Mustafa Adak, Akdeniz University (2018-2022) Prof. Dr. Engin Akyürek, Koç University (2018-2022) Prof. Dr. Nicholas D. Cahill, University of Wisconsin-Madison (2018-2022) Prof. Dr. Edhem Eldem, Boğaziçi University / Collège de France (2018-2022) Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Emeritus, Istanbul University (2016-2020) Prof. Dr. C. Brian Rose, University of Pennsylvania (2018-2022) Prof. Dr. Charlotte Roueché, Emerita, King’s College London (2019-2023) Prof. Dr. Christof Schuler, DAI München (2017-2021) Prof. Dr. R. R. R. Smith, University of Oxford (2016-2020) © Koç University AKMED, 2020 Production Zero Production Ltd. Abdullah Sok. No. 17 Taksim 34433 İstanbul Tel: +90 (212) 244 75 21 • Fax: +90 (212) 244 32 09 [email protected]; www.zerobooksonline.com Printing Fotokitap Fotoğraf Ürünleri Paz. -

ECCLESIAE OCCIDENTALIS MONUMENTA IURIS ANTIQUISSIMA Ed
ECCLESIAE OCCIDENTALIS MONUMENTA IURIS ANTIQUISSIMA ed. C.H. Turner (Oxford, 1899-1939) Index of Names and Selected Words Corrected, revised, and extended 2008 by Philip R. Amidon, S.J. Creighton University [email protected] It has seemed opportune to republish this index in a corrected and extended version; there has been added to the list of names a list of selected words, and the method of referring to the text has been somewhat altered. The exact scope of C.H. Turner’s masterpiece is not immediately apparent from its title or subtitles (Canonum et conciliorum graecorum interpretationes latinae; Canones et concilia graeca ab antiquis interpretibus latine reddita). What one in fact finds here is an edition of the earliest surviving collections of church canons in Latin which are undoubtedly from the fourth century or have been assigned to it by at least some consensus of scholarship; some of them are translations from Greek, while others were originally drafted in Latin itself. Most of them, with the exception of the Apostolic Constitutions and Canons, are attributed to church councils. Turner, however, also offers a selection of doctrinal and historical material of enormous value, some of it indeed connected to the councils whose canons he edits; a comparison, for instance, of the creed contained in the synodical letter of the Council of Sardica with the Tomus Damasi, will suggest how far the doctrinal education of the western church advanced during the course of the fourth century. The connection of other historical matter to the canons is less obvious, however; one wonders what the Athanasian Historia acephala is doing here (granted that it is part of the collection of Theodosius the Deacon), however grateful one is to have the edition.