Antica Fiera Di Sommacampagna”
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Classifica Gelaterie
BLACK AND WHITE Chievo 403.714 ARTIGIANALE DODO Peschiera 4.402 SAVOIA Verona 394.604 I MIGLIORI TRE DANIEL Zevio 4.366 IL GELATONE Verona 339.138 IL GELATONE Nogara 4.026 TEMPTATIONS Soave 290.162 VITTORIA GELATO E CAFFÈ Verona 3.972 IL MUSTACCHIO Verona 234.108 ELENA GELATEO DI BERARDINELLI TEO Verona 3.929 CRISTALLO EL COSSETT EUROPA San bonifacio 224.447 ISOLA GELATERIA DANIELA Veronella 3.827 BARDOLINO CASTELLETTO L'ARTE DEL GELATO Legnago 219.829 DELLA SCALA CREMA E CIOCCOLATO San Martino B.A. 3.435 WHITE ES Zevio 169.101 PONTE PIETRA Verona 3.410 LA PARONA DEL GELATO Parona 162.294 LIMONAIA Torri Del Benaco 3.031 AKROPOLIS San Giovanni Lupatoto 137.309 CREMERIE Affi 2.840 PAMPANIN Verona 118.245 IMPERO Verona 2.561 GELATERIA MATTIELLI Soave 117.394 TRICOCCO Verona 2.521 GELATERIA STEFY Caldiero 88.543 TORTA DELLA NONNA Peschiera 2.498 CORTE VITTORIA Sommacampagna 84.765 CAFFÈ OTTOLINI Verona 2.227 L'ARTIGIANO DEI SAPORI Malcesine 82.614 ARTE DEL GELATO Verona 2.218 NANÀ Verona 68.730 DOLORES Cerea 1.579 LA PECORA NERA Verona 68.685 MAZZINI Verona 1.300 LA GELATERIA DELLO STADIO Verona 68.422 BLUE ICE Lugagnano 1.259 ARTIK Verona 66.058 SLURP Bussolengo 1.251 GANDINI IL GELATO San bonifacio 65.586 IL LATTE DEL PARCO Bosco Chiesanuova 1.168 LA GELATTERIA Villafranca 62.374 CENTO PER CENTO Malcesine 1.146 OASI Verona 59.236 AGRIGELATERIA MANZATI Palazzolo Di Sona 1.123 FRATELLI FAINELLO Costermano sul Garda 56.735 CIOCCOLATO ISALBERTI Cerea 1.019 LA DOLCE VITA San zeno di Montagna 53.456 ANGELINA Lazise 835 LA GOLOSA Dossobuono 48.847 SOTTOZERO San Giovanni Lupatoto 714 MOZART Verona 48.788 GROMM Verona 687 MASTER'S CREAM Legnago 43.735 ASKI Verona 631 TOP UNO Villafranca 43.029 TEMPI DELIZIOSI Sant'Ambrogio 617 GELATOTECA Negrar 41.782 BELLINI 1929 San Giovanni Lupatoto 14.264 DALLA VALLE Tregnago 610 TUGÒ Verona 38.751 ARTIGIANALE FRIZZOLAN Bosco Chiesanuova 13.428 LA LIMONATA Torri del Benaco 505 BONGELATO Bovolone 37.852 IGLOO Verona 12.720 CREMAMORE Verona 499 GELATERIA DEL BORGO San Martino B.A. -

CURRICULUM VITAE Francesca Parato
CURRICULUM VITAE Francesca Parato PERSONAL INFORMATION Address: 23, Via Gen. C. A. Dalla Chiesa 37069 – Villafranca (Verona) - Italy Telephone: +39 0456304372 Mobile: +39 3402806277 e-mail: [email protected] Nationality: Italian Date of birth: November, 24th 1987 EDUCATION AND TRAINING • June, 2006: High School Diploma at “Enrico Medi”, Verona. • From 2011 to 2014: multiple Primary School and Kindergarten internships in Verona, Mantua and Brescia. • September, 2014: Degree with honors at “Università Cattolica del Sacro Cuore” (Brescia) in Primary Education Science, including specialization for special needs students. • March, 2015: Kindergarten internship at “Colegio Cardenal Spinola”, Madrid (Spain). • July, 2015: thesis research in Madrid (Spain), “Thesis Scholarship” program. • December 2015: Degree with honors at “Università Cattolica del Sacro Cuore” (Brescia) in Kirdengarten Education Science, including specialization for special needs students. • from May 2016: attending “O.N.M. Differenziazione Didattica Montessori” diploma (6-12), recognized by A.M.I., at “Associazione Montessori Brescia”, ending in July 2017. AWARDS • September 2016 Page 1 of 3 National awards in Primary School teacher for children with special needs position (it is compulsory winning the award to teach in public schools). • November 2016 Nationa awards in Primary School teacher position (it is compulsory winning the award to teach in public schools). WORK EXPERIENCE • September 2016 - present Teacher for children with special needs at “Don Lorenzo Milani” Primary School, Sommacampagna (Verona). Role: supporting the education of children with learning difficulties through the development of an individual learning plan. • From October 2015 to June 2016 Teacher for children with special needs at “Anna Frank” primary school, Povegliano Veronese (Verona). -

Publication of a Communication of Approval of a Standard Amendment to a Product Specification for a Name in the Wine Sector Refe
5.3.2020 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 72/33 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2020/C 72/14) This communication is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATING THE APPROVAL OF A STANDARD AMENDMENT ‘SOAVE’ Reference number: PDO-IT-A0472-AM05 Date of communication: 2 December 2019 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Formal amendment For the ‘Classico’ type, the term ‘subarea’ has been replaced by the term ‘specification’. This is a formal amendment to take account of the exact wording provided in Italian law. This formal amendment concerns Article 1 of the Product Specification but it does not affect the Single Document. 2. Vine training systems The vine training systems have been extended to include GDC and all forms of trellises. The reason for this amendment is to adapt the Product Specification to the development of more modern and innovative vine training systems (particularly the various new kinds of trellises) and the need for agronomic methods to take account of climate change. This formal amendment concerns Article 4 of the Product Specification but it does not affect the Single Document. 3. Vine density per hectare As regards vine density per hectare (at least 3 300), the reference to the Decree of 7 May 1998 has been deleted. This is a formal amendment given that newly planted vines must have a minimum density of 3 300 plants per hectare. -

Comune Di Somm Comune Di Sommacampagna Acampagna
! m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0026989.08-11-2016 !"#$%&'()'*"##+!+#,+-%+ ' E,ACF=:B=>'<='D;AC:>G' !"#"$ !""#$%&'"#(# '' !"%"&"$ ')*++,-,+.,/0,1234-53617. @25056*1056 '' ="="="$. -*+9051)*++,-,+.,/0,123176 ' ' ! ! !"# $%& '&()**%& +,-,., & "##"!$%&% ! '()**%#) ! !"#"$%&'()*&++S-./"&#%&)&)*&++0)12%&+0)*&+)1&''"%('"()&)*&+) !0'&) +,-).,/0)!1)0)-"#)!()-!#)!2"#3*".,/0,!"45,)0*"#, ! +,2,6,/0)!77!M! ',6*)4,!9,!:"#3*".,/0)!&45,)0*"#) ! 2,"!$-,6*/;/-/!$/#/45/!<<! ==><?!@/4"! 916"#2"13"-9,"%"45,)0*"#)A() B%4,0"45,)0*)%,* ! ! '()**%#)! !"#"$%&'() *&")3&#")&)*&++&)-%%"4"%)62+%2'0+")&)*&+)12'"$.( ) +,-).,/0)!1)0)-"#)! 9)#!(")6"11,/ V!#)!5)##"!"-*,V!#R"-BH,*)**3-"! )!#R"-*)!B/0*)4(/-"0)"! ')-2,.,/!D3*)#"!)!E3"#,*!9)#!(")6"11,/ ! 2,"!'"0!G,BH)#)!II! ==>JK!@/4"! 45"BL91L (5""BA4",#B)-*%5)0,B3#*3-"#,%,* ! ! '()**%#)! 7&8"(#&)9&#&%() M%$%!:"#3*".,/0)!9,!74("**/!&4 5,)0*"#) ! N"#"../!O,0)**,!M!$"##)!N-,3#,! $"00"-)1,/!PP ! K=>I>!:)0).,"!:Q! (-/*/B/##/%1)0)-"#)A()B%-)1,/0)%2)0)*/%,* ! ! '()**%#)! :'(4"#;"0)*")9&'(#0) ')**/-)!&45,)0*)!M!')-2,.,/! :"#3*".,/0)!74("**/!&45,)0*"#) ! 2,"!9)##)!R-"0B)6BH,0)!>=! K?>I>!:)-/0"!:@! "45,)0*)%(-/2,0B,"%2 -A()B2)0)*/%,* ! ! '()**%#)! !"#"$% &'()*&++&)<#='0$%'2%%2'&)&)*&") 1'0$>('%") N-/22)9,*/-"*/!70*)--)1,/0"#)!()-!#)!S()-)!N355#,BH)!:)0)*/! M!D-)0*,0/!M!R-,3#,!:)0).,"!T,3#," ! '%!N/#/!>P! K=>IJ!:)0).,"!:Q! //((%*-,2)0)*/A()B%4,*%1/2%,* ! ! '()**%#)! -7:-9 !M!+ ,("-*,4)0*/!N-/2,0B,"#)!9, !:)-/0"! 2,"!+/4,03**,!U! K=>KJ!:)-/0"!:@! 9"(2-A()B%"-("2%,* ! ! '()**%#)! 896*35!81:1!!<=>?)53)> ,A37))*07>B5)C6*.>#"'D1''!63,)+7))7*05!E*-9+506,F7*051E*-G! -

“L'alpone” Di Settembre 2019 in Formato
l’Alpone - Settembre 2019 Autorizz. del Tribunale di Verona del 3 Luglio 1986 - R:S: 705 - Sped. in abbonamento Post. - 45 % art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Verona da Verona C.M.P. - 50 % - Trimestrale di informazione e cultura - Anno 34 - N. 3 - SETTEMBRE 2019 - Recapito a cura dell’ Ente Poste Italiane l’alpone Anno 34 Nr. 3 www.ilarione.it Pro Loco | San Giovanni Ilarione Settembre 2019 Saluto del Presidente CIAO JOHN, AMICO DI TUTTI Giovanni Todesco, una vita di impegno e testimonianza Cari lettori de L’Alpone, nell’invitare tutti voi all’ormai imminente Sagra delle Ca- Figura molto conosciuta in paese per il ito a mettere a disposizione della scienza stagne, voglio ringraziare fin d’ora tutti suo impegno nei vari campi del sociale, è universale una scoperta di questa portata. coloro che in questi giorni stanno contri- stato uno spirito libero, poliedrico, in tutte Grazie alle sue conoscenze nel campo buendo con il loro lavoro a rendere que- le sue attività, le sue passioni, i suoi hobby paleontologico, è stato spesso chiamato a sta festa sempre migliore: associazioni, ci ha messo sempre l’anima, la massima condividere con i bambini delle scuole le gruppi di volontari, autorità e semplici partecipazione, curando nei minimi par- sue scoperte, la sua passione per i fossili, cittadini. ticolari ogni suo progetto e ogni suo pro- a svelare l’arcano mondo antico e quando Sappiamo che unendo le forze possiamo posito. parlava con loro gli occhi suoi luccicava- fare molto per il nostro paese e la sagra Balzato agli onori della cronaca per la no, come il piccolo esploratore che affron- serve proprio per ritrovare quello spirito scoperta di Ciro, il primo fossile di dino- ta l’immensità del passato, per scoprire i di amicizia e di unità che sarà prezioso sauro italiano e passata sui libri di paleon- segreti della vita e della storia. -

INTERVENTI CONCLUSI 2006-2014 in Lavorazione
INTERVENTI DI PIANO D'AMBITO DELL'ATO VERONESE COMPLETATI NEL PERIODO 2006-2014 CODICE IMPORTO PROGETTO IMPORTO COMUNE REALIZZATORE AREA TITOLO INTERVENTO SERVIZIO AATO (€) CONTRIBUTI (€) AFFI COMUNE DI AFFI G Adeguamento acquedotto zona Centro Commerciale B.1-A-51 A€ 155.000 AFFI AGS G Fognatura Mezzacasa Incaffi B.1-A-52 F€ 275.000 AFFI AGS G Adeguamento funzionale Impianto di depurazione di Affi D€ 137.000 Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste del capoluogo - 1° ALBAREDO D'ADIGE ACQUE VERONESI V AF€ 125.000 stralcio B.1-B-08a ALBAREDO e ARCOLE CISIAG V Fognatura Via Venezia (albaredo) e Via Padovana e Nogarole (Arcole) F€ 325.000 B.1-B-09a ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHIS.A., COLOGNA VENETA, Estensione rete idrica nei comuni di Albaredo, Arcole, Bonavigo, Boschi LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ACQUE VERONESI V Sant'Anna, Cologna v., legnago, Minerbe, pressana, Roveredo, terrazzo, vari A€ 1.200.000 ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, Veronella, Zimella - 1° stralcio ZIMELLA ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHIS.A., COLOGNA VENETA, Rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ACQUE VERONESI V S.A., Cologna Veneta, legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, vari A€ 1.558.000 € 1.145.000 ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° stralcio ZIMELLA ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHIS.A., COLOGNA VENETA, Rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ACQUE VERONESI V S.A., Cologna Veneta, legnago, -

C.V. Giacopuzzi
Regione Veneto Azienda U.L.S.S. n. 22 Bussolengo Servizi Sociali - E-Mail: [email protected] DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) Il sottoscritto Giacopuzzi Chiara Verona, 07/07/1977 COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA Residente in Via Nuova 75 – 37060 Caselle di Sommacampagna (Vr) COMUNE – INDIRIZZO – NUMERO CIVICO (1) consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 in caso di false dichiarazioni, D I C H I A R A la veridicità dei dati riportati nell’allegato curriculum personale (2) Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs.196/2003 , è a conoscenza che quanto sopra indicato verrà utilizzato per PRESENTAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DELL’ENTE. (indicare l’uso della dichiarazione) BUSSOLENGO, 10/10/16 _______________________________ ___________________________________ luogo e data firma Sede: 37012 BUSSOLENGO (Verona) – Via C.A. Dalla Chiesa - Tel. (+39) 0456 712 357 / 376 - Fax: 0456 712 344 Codice Fiscale e Partita IVA 02576210237 La sottoscritta Giacopuzzi Chiara, nata a Verona il 07/07/1977 e residente a Caselle di Sommacampagna (VR) in Via Nuova n.75, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA DATI PERSONALI COGNOME E NOME : GIACOPUZZI CHIARA DATA E LUOGO DI NASCITA : 7 LUGLIO 1977, VERONA RESIDENZA : Via Nuova 75, 37060 Caselle di Sommacampagna, Vr CITTADINANZA : ITALIANA CODICE FISCALE GCPCHR77L47L781L TELEFONO : 349 0893241 STATO CIVILE : nubile ISTRUZIONE: Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1996 presso il Liceo Scientifico Statale “A.Messedaglia” di Verona con la votazione di 42/60 Diploma Universitario in Servizio Sociale conseguito in data 16 marzo 2001 presso l’Università degli Studi di Verona, con la votazione di 102/110. -

Linee E Orari Bus Extraurbani - Provincia Di Verona
Linee e orari bus extraurbani - Provincia di Verona Servizio Estivo 2016 [email protected] 141 Legnago - Roverchiara - Oppeano - Verona .....................................47 Linee da/per Verona 141 Verona - Oppeano - Roverchiara - Legnago .....................................47 102 Ceraino - Domegliara - S.Lucia - Pescantina - Bussolengo - Verona 143 Legnago - S.Pietro di Morubio - Bovolone - Verona ..........................48 ............................................................................................................. 12 144 Legnago - Cerea - Bovolone - Verona ..............................................49 102 Verona - Bussolengo - Pescantina - S.Lucia - Domegliara - Ceraino 144 Verona - Bovolone - Cerea - Legnago ..............................................50 ............................................................................................................. 12 146 Nogara - Isola d. Scala - Verona ......................................................51 Domegliara/Negrar - Verona ................................................................13 146 Verona - Isola d. Scala - Nogara ......................................................51 Verona - Negrar/Domegliara ................................................................15 148 Mantova - Castelbelforte - Trevenzuolo - Vigasio - Verona ................52 104 Fosse - S.Anna di Alfaedo - Negrar - Verona ....................................17 148 Verona - Vigasio - Trevenzuolo - Castelbelforte - Mantova ................52 104 Verona - Negrar - S.Anna -

Area Partenze Linee Extraurbane
VIALE PALLADIO Sosta VIALE GIROLAMO CARDINALE TEMPIO 9 VOTIVO 5 8 4 7 31 32 33 11 12 10 6 3 AREA PARTENZE Linee EXTRAURBANE 23 24 25 26 27 28 29 30 2 16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 1 AREA PARTENZE Linee URBANE Marciapiede A Marciapiede C-D Marciapiede E-F BUS NAVETTA AEROPORTO “CATULLO” SHUTTLE BUS STAZIONE FS Biglietteria ATV I NOSTRI CONTATTI informazioni [email protected] 045 8057 922 i dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 14.00 relazioni con [email protected] 045 8057 852 i il Pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 www.atv.verona.it AREA PARTENZE LINEE EXTRAURBANE DESTINAZIONE CORSIA DESTINAZIONE CORSIA ALBAREDO 2 MONTAGNANA 18 BADIA CALAVENA 14 MONTECCHIO 27 BADIA POLESINE 5 NEGRAR 25 BAGNOLO 31 Marciapiede NEGRAR C-D (urbano) BELVEDERE 31 NOGARA 6 BOLCA 15 PALÙ 2 BOSCOCHIESANUOVA 28 PESCANTINA 23 BOVOLONE 5 PESCHIERA -RIVA 10 BRESCIA 21 PESCHIERA -BRESCIA 21 BREONIO 26 POVEGLIANO 12 BUSSOLENGO 10; 11 RIVA DEL GARDA 10 CALDIERO-STRÀ 14; 15 Marciapiede CAMPOFONTANA 15 RIZZA (VERONA) E-F (urbano) CAPRINO 24 ROVERÈ VERONESE 29; 30 Marciapiede CASTEL D'AZZANO ROVEREDO DI GUÀ 18 E-F (urbano) SALIONZE 33 CASTELBALDO 4 SANT'ANNA ALFAEDO 25 CASTELMASSA 6 SAN BONIFACIO 15 CASTELNUOVO DEL GARDA 21 SAN BORTOLO 15 CEREA 5 SAN BRICCIO 20 CERRO VERONESE 28; 29 SAN GIOVANNI ILARIONE 15 COLOGNA VENETA 18; 16 SAN GIOVANNI LUPATOTO 1 DOMEGLIARA 13 Marciapiede FERRARA MONTE BALDO 24 SAN GIOVANNI LUPATOTO E-F (urbano) Marciapiede FORETTE SIRMIONE 21 E-F (urbano) SOAVE 15 FOSSE 25 SOMMACAMPAGNA 32 FUMANE 26; 13 SONA 33 GARDA 10; 11 SPIAZZI 24 GARDALAND 10 SAN MARTINO BUON ALBERGO 14; 15 GIAZZA 17 SAN MAURO SALINE 19 Marciapede GREZZANA A (urbano) SANTA MARIA STELLE 29 ISOLA DELLA SCALA 6 SUSTINENZA 7 LEGNAGO (VIA BONAVICINA) 7 SAN ZENO MONTAGNA 24 LEGNAGO (VIA CEREA) 5 TREGNAGO 14 LEGNAGO (VIA ROVERCHIARA) 4 VALEGGIO 32 LEGNAGO (VIA ALBAREDO) 2 VELO 29; 30 MALCESINE 10 VESTENANUOVA 15 MANTOVA 8 Marciapiede VIGASIO E-F (urbano) MARANO VALPOLICELLA 27 VILLAFRANCA 12; 31 Marciapede MARZANA A (urbano) VILLIMPENTA 6 MENÀ 5 VOLARGNE 13 MERLARA 7 ZEVIO 2 MEZZANE 19. -

Caduti Veronesi Il 19-01-1943 Postojali
Tipo Cognome Nome Paternità Data di nascita Luogo di nascita Provincia di nascita Grado Corpo Data di decesso Luogo di decesso Noto non Id. ALBRIGO GUIDO GIUSEPPE 04/01/1921 GAZZO VERONESE Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Noto non Id. APOLLONIO FRANCESCO FRANCESCO 17/04/1914 VERONA Verona Aiut. di Batt. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Noto ARMOTTI PIETRO ANTONIO 17/10/1922 RONCA' Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BALLINI FERRUCCIO ANTONIO LUIGI 18/11/1922 GREZZANA Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BANTERLE UMBERTO BONFIGLIO 05/08/1917 BUSSOLENGO Verona C.le 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BATTISTONI LUIGI ANGELO 05/02/1912 CAPRINO VERONESE Verona C.le 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BELLAMOLI GUGLIELMO ANGELO 30/08/1916 GREZZANA Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BELTRAME GIOVANNI GIOBATTA 15/07/1921 SAN GIOVANNI ILARIONE Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Noto non Id. BENVENUTI UMBERTO ANGELO 22/08/1922 PESCANTINA Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BERGAMINI NEMORINO ATTILIO 30/03/1915 POVEGLIANO VERONESE Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BERTAGNA ANTONIO LUIGI 18/10/1919 LAZISE Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Disperso BERTAGNOLI LUIGI ARCANGELO 26/04/1922 GREZZANA Verona Alp. 6 RGT. ALPINI 19/01/1943 POSTOJALI - Fossa comune Noto non Id. -
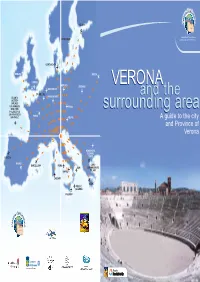
VERONA Surrounding Area VERONA Surrounding Area
Consorzio di Promozione e Commercializzazione Turistica VERONAVERONAand the surroundingsurroundingand the areaarea A guide to the city and Province of Verona TRAVEL DISTANCE BY Legend: MOTORWAY FROM VERONA TO: Trento km. 103 Fair Bolzano km. 157 Airport Vicenza km. 51 Venice km. 114 Lake Garda Brescia km. 68 Lessinia Milan km. 161 Bologna km. 142 Veronese Plain Florence km. 230 Soave Rome km. 460 Valpolicella Verona AFFI VERONA and the surrounding area A guide to the city and Province of Verona Verona Tuttintorno is proud to present the new edition of "Verona and the Surrounding Area - A Guide to the City and Province of Verona". The publication provides a general overview of the area's riches, and describes 30 fascinating itineraries to explore. The guide represents a collaborative effort between the Consortium and its members: travel agencies, hoteliers, restaurant owners, wineries, the Wine Road association, local government, transportation agencies, and tourist-sector service providers of every kind. The included itineraries offer a myriad of possibilities for enjoying the area's cultural riches, its nearby mountains, lake, and plain, getting and its world-famous enogastronomic traditions. Verona Tuttintorno, a consortium of businesses dedicated to promoting local tourism and the cultural, environmental, and enogastronomic to Verona patrimony of the City and Province of Verona, also offers up-to-date information and itinerary planning assistance for those wishing to make Verona and the surrounding area their next vacation destination. BY CAR BY TRAIN BY PLANE Enjoy Verona and the surrounding area!!! The A4 Motorway crosses the province Verona is served by the main train line The Valerio Catullo Airport, situated in of Verona from east to west. -

Disciplinare Di Produzione Della Denominazione Di Origine Controllata Dei Vini “Soave” Consolidato Con La Modifica Di Cui Al Provvedimento Ministeriale N
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Soave” consolidato con la modifica di cui al provvedimento ministeriale n. 0006383 del 30.01.2019, con le modifiche ordinarie approvate con DM 24 ottobre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4.11.2019, nonché con gli aggiornamenti conseguenti alle osservazioni formulate dalla Commissione UE con nota n. Ares(2020)1487373. Articolo 1 Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata “Soave” è riservata ai vini “Soave” (anche in versione spumante) e “Soave” designati con la specificazione aggiuntiva Classico e “Soave” designati con la sottozona Colli Scaligeri, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 Base ampelografica 1. I vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Garganega: almeno il 70%; Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%. In tale ambito del 30% possono altresì concorrere, fino ad un massimo del 5%, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Verona. Articolo 3 Zona di produzione delle uve 1. A - Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona. Tale zona è così delimitata: A sud, ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di San Martino Buon Albergo e segue la statale n.