CARLO III ROSSO, Barone Di Cerami E I SUOI ANNI
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
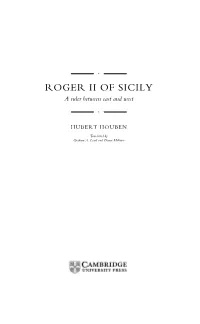
ROGER II of SICILY a Ruler Between East and West
. ROGER II OF SICILY A ruler between east and west . HUBERT HOUBEN Translated by Graham A. Loud and Diane Milburn published by the press syndicate of the university of cambridge The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge cb2 1rp, United Kingdom cambridge university press The Edinburgh Building, Cambridge, cb2 2ru,UK 40 West 20th Street, New York, ny 10011-4211, USA 477 Williamstown Road, Port Melbourne, vic 3207, Australia Ruiz de Alarcon´ 13, 28014 Madrid, Spain Dock House, The Waterfront, Cape Town 8001, South Africa http://www.cambridge.org Originally published in German as Roger II. von Sizilien by Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1997 and C Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1997 First published in English by Cambridge University Press 2002 as Roger II of Sicily English translation C Cambridge University Press 2002 This book is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. Printed in the United Kingdom at the University Press, Cambridge Typeface Bembo 10/11.5 pt. System LATEX 2ε [TB] A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloguing in Publication data Houben, Hubert. [Roger II. von Sizilien. English] Roger II of Sicily: a ruler between east and west / Hubert Houben; translated by Graham A. Loud and Diane Milburn. p. cm. Translation of: Roger II. von Sizilien. Includes bibliographical references and index. isbn 0 521 65208 1 (hardback) isbn 0 521 65573 0 (paperback) 1. Roger II, King of Sicily, d. -

Defining and Perceiving Peoples in the Chronicles of Norman Italy" (2011)
Western Michigan University ScholarWorks at WMU Master's Theses Graduate College 6-2011 "Videbantur Gens Effera": Defining and erP ceiving Peoples in the Chronicles of Norman Italy Jesse Hysell Follow this and additional works at: https://scholarworks.wmich.edu/masters_theses Part of the European History Commons Recommended Citation Hysell, Jesse, ""Videbantur Gens Effera": Defining and Perceiving Peoples in the Chronicles of Norman Italy" (2011). Master's Theses. 394. https://scholarworks.wmich.edu/masters_theses/394 This Masters Thesis-Open Access is brought to you for free and open access by the Graduate College at ScholarWorks at WMU. It has been accepted for inclusion in Master's Theses by an authorized administrator of ScholarWorks at WMU. For more information, please contact [email protected]. "VIDEBANTUR GENS EFFERA": DEFINING AND PERCEIVING PEOPLES IN THE CHRONICLES OF NORMAN ITALY by Jesse Hysell A Thesis Submitted to the Faculty ofThe Graduate College in partial fulfillment ofthe requirements for the Degree of Master ofArts Department of History Advisor: Luigi Andrea Berto, Ph.D. Western Michigan University Kalamazoo, Michigan June 2011 "VIDEBANTUR GENS EFFERA": DEFINING AND PERCEIVING PEOPLES IN THE CHRONICLES OF NORMAN ITALY Jesse Hysell, M. A. Western Michigan University, 2011 The goal ofthis project is to analyze the ways different cultural groups in Sicily and southern Italy were depicted in a set ofhistorical texts associated with the Norman takeover ofthose regions in the eleventh and twelfth centuries. To achieve that aim, I consider social vocabulary applied to three distinct peoples (native Italians, Greeks, and Muslims) in five sources written by Amatus ofMontecassino, Geoffrey Malaterra, William ofApulia, Alexander ofTelese, and Hugo Falcandus. -

Libero Consorzio Comunale Di Enna Già Provincia Regionale Di Enna SETTORE III Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici Dirigente: Dott
15/06/2020 Libero Consorzio Comunale di Enna già Provincia Regionale di Enna SETTORE III Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici Dirigente: Dott. Ing. Paolo PULEO SERVIZIO 1 Gestione e Manutenzione Stradale Accertamenti e Violazioni al Codice della Strada – Autoparco Responsabile: Geom. Salvatore RAGONESE Enna, 3 febbraio 2020 LA PROVINCIA DI ENNA NEL CUORE DELLA SICILIA UNICA SENZA SBOCCHI SUL MARE CON RILIEVI COLLINARI E MONTUOSI ESTESA 2.562,50 km2 COMPOSTA DA 20 COMUNI 1 VIABILITÀ NEL TERRITORIO PROVINCIALE AUTOSTRADA A19 PALERMO - CATANIA PROVINCIALE TERRITORIO TERRITORIO VIABILITÀ NEL NEL 15/06/2020 2 15/06/2020 VIABILITÀ NEL TERRITORIO PROVINCIALE AUTOSTRADA A19 IL PIÙ IMPORTANTE COLLEGAMENTO VIARIO PALERMO - CATANIA TRA LA SICILIA ORIENTALE E OCCIDENTALE DIVIDE A METÀ SVILUPPO SU TERRITORIO PROVINCIALE IL TERRITORIO PROVINCIALE km 63,100 SVINCOLI AUTOSTRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE FERRARELLE ENNA MULINELLO DITTAINO AGIRA CATENANUOVA VIABILITÀ NEL TERRITORIO PROVINCIALE TERRITORIO NEL 3 15/06/2020 VIABILITÀ NEL TERRITORIO PROVINCIALE TRATTI RICADENTI N. N. DENOMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSATO SUL TERRITORIO Ordine PROVINCIALE 1 SS 117 Centrale Sicula Nicosia - Cerami - Leonforte - Assoro 40,556 2 SS 117 bis di Nicosia Enna - Piazza Armerina 63,400 3 SS 120 dell'Etna e delle Madonie Sperlinga - Nicosia - Cerami - Troina 68,400 4 SS 121 Catanese Villarosa - Enna - Leonforte - Nissoria - Agira - Regalbuto 79,300 5 SS 122 Agrigentina Enna 8,891 6 SS 191 Barrafranca Barrafranca - Pietraperzia 17,900 7 SS 192 della Valle del Dittaino Enna - Zona Industriale Dittaino - Catenanuova 51,000 8 SS 288 di Aidone Aidone (Morgantina) - Piazza Armerina 21,400 9 SS 290 di Alimena Calascibetta - Enna 20,520 10 SS 560 Mercato Bianco Enna - Pietraperzia 9,800 11 SS 561 Pergusina Enna - Valguarnera 10,500 12 SS 575 di Troina Troina - Centuripe 32,805 13 SS 626 della Valle del Salso Enna - Pietraperzia 16,050 14 SS 640 Strada degli Scrittori (già di Porto Empedocle) Villarosa 1,400 sommano …………….…..…. -

Elenco Cave Di Prestito
N. COMUNE MATERIALE DENOMINAZIONE 1 AGIRA CALCARE BASTIONE 2 AGIRA CALCARENITE BACIANTE 3 AGIRA QUARZARENITE MANDRE BIANCHE 5 4 AGIRA QUARZARENITE MANDRE BIANCHE SUD 5 AGIRA CALCARENITE TERRE ROSSE II 6 AGIRA SABBIA MANDRE BIANCHE -GISAM 7 AGIRA CALCARENITE BACIANTE 2 8 AIDONE CALCARE FARGIONE 9 AIDONE CALCARE FARGIONE IIº 10 AIDONE CALCARE TOSCANO 11 AIDONE SABBIA DRAGOFOSSO 12 AIDONE CALCARE TOSCANO - CARFI' 13 AIDONE QUARZARENITE MENDOLA 14 AIDONE QUARZARENITE PARCO 15 ASSORO CALCARENITE PIETRA DI SERRE 16 ASSORO QUARZARENITE MILOCCA 17 ASSORO ROSTICCI ZOLFO ZIMBALIO 18 BARRAFRANCA CALCARE ROCCHE 19 CATENANUOVA SABBIA SAN PIERO 20 CENTURIPE MATER. ALLUV.LE CUBA 2 21 CENTURIPE SABBIA INTORRELLA 2 22 CENTURIPE SABBIA SPINA SANTA 23 CENTURIPE ARGILLA PAPORTELLO-MANDARANO 24 CERAMI QUARZAREN.ORN. GANNO 25 CERAMI CALCARE SPEZZAGALLO 26 CERAMI SABBIA PANGALLO 27 CERAMI SABBIA RAFFO 28 ENNA ARGILLA MENDOLA 29 ENNA CALCARENITE SCIOLTABINO 30 ENNA CALCARENITE ALVANELLO 31 ENNA CALCARE GALLIZZI 32 NICOSIA CALCARE S.BASILE II 33 NICOSIA QUARZAREN. MARROCCO 34 NICOSIA SABBIA MANCIPA 35 NICOSIA SABBIA SAN LUCA 36 NICOSIA SABBIA SANTA AGRIPPINA 37 NICOSIA CALCARENITE BASILE FORNAROTTO 38 NICOSIA CALCARE S.BASILE II 39 NICOSIA CALCARE FICILINO 40 NISSORIA QUARZARENITE BOSCO 41 NISSORIA CALCARENITE PERCIATA 42 PIAZZA ARMERINA SABBIA AMPL.CAMITRICI 43 PIAZZA ARMERINA SABBIA AMPL. IMBACCARI SOPRANO CARFI' 44 PIAZZA ARMERINA SABBIA AMPLIAMENTO IMBACCARI SOPRANO 45 PIAZZA ARMERINA CALCARENITE CAMITRICI II 46 PIAZZA ARMERINA CALCARENITE GALLINICA 47 PIAZZA ARMERINA CALCARENITE SORTEVILLE 48 PIAZZA ARMERINA CALCARE BARINOTTO 49 PIAZZA ARMERINA CALCARENITE MONTAGNA GEBBIA 50 PIETRAPERZIA CALCARE MARCATO BIANCO 51 PIETRAPERZIA CALCARE MUSALA' 52 TROINA QUARZARENITE ORNAMENTALE MONTE S.SILVESTRO 53 TROINA QUARZARENITE COLLE GELSO CAUCIRI' 1 54 VILLAROSA ROSTICCI ZOLFO GIULFO 55 VILLAROSA SABBIA E CONGL. -

Consigliere-Cacciato Salvatore
Curriculum Vitae Europass Informazioni personali Nome(i) / Cognome(i) SALVATORE CACCIATO Indirizzo(i) Contrada Pini — 94010 CALASCIBETTA Telefono(i) -F39 093534468 Cellulare: 3204337442 Fax 093520821 E-mail cacciatosalvatore©yahoo.it Cittadinanza Italiana Data di nascita 08.08.1958 Sesso maschile Occupazione Direzione Aziendale desiderata/Settore professionale Esperienza professionale Date Dal 01/10/1989 — Lavoro o posizione ricoperti Perito tecnico forestale Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione lavoratori per realizzazione opere idraulico - forestali. Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana —Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Territoriale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 14° — Ufficio Servizio per il Territorio di Enna- Tipo di attività o settore Settore tecnico Date 03/2002 — 03/2014 Lavoro o posizione ricoperti Revisore — Ispettore- Principali attività e responsabilità Ispezioni ordinarie alle società cooperative Nome e indirizzo del datore di lavoro Legacoop Sicilia — Via A. Borrelli, 3 - Palermo Tipo di attività o settore Contabile Date 06/2013 — 04/2014 Lavoro o posizione ricoperti i Consigliere Comune di Calascibetta Principali attività e responsabilità Nome e indirizzo del datare di lavoro Comune di Calascibetta Tipo di attività o settore i Date 05/2012 — 06/2013 Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Provincia Regionale di Enna Principali attività e responsabilità Nome e indirizzo del datore di lavoro -

Comune Di ASSORO
Codifica Elenco dei beni soggetti all’apposizione del vincolo EEGR10002BGL00083 preordinato all’asservimento coattivo Direzione Rev. 00 Sviluppo Rete Ingegneria - PRI NA del 15/12/2011 Pag. 1 di 7 ELETTRODOTTO A 380kV IN DOPPIA TERNA “CHIARAMONTE GULFI - CIMINNA” ED OPERE CONNESSE PIANO TECNICO DELLE OPERE PARTE GENERALE - APPENDICE A "Elenco dei beni soggetti all’apposizione del vincolo preordinato all’asservimento coattivo" Provincia di ENNA Comune di ASSORO Storia delle revisioni Rev. 00 del15/12/2011 PRIMA EMISSIONE Elaborato Verificato Approvato M. Longobardi P. Paternò ING. S. CELI A. Stabile SRI - PRI NA N. Speranza V. Russo SRI-PRI-NA Questo documento contiene informazioni di proprietà di Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alla finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA Pag. 2 di 7 Provincia : ENNA Comune : ASSORO Codice: A478 DATI ANAGRAFICI INTESTAZIONE CATASTALE DIRITTI E ONERI REALI IMMOBILE DATA CODICE FISCALE/ COGNOME NOME LUOGO NASCITA TITOLO QUOTA FOGLIO PARTICELLA NASCITA PARTITA IVA RIZZO Salvatore TROINA 22/08/1947 RZZSVT47M22L448F Proprieta` 69 63 MIRITELLO Filippa CATENANUOVA 15/01/1949 MRTFPP49A55C353A Proprieta` 1/9 RIZZO Benedetto Antonio CATANIA 11/05/1975 RZZBDT75E11C351Z Proprieta` 1/9 RIZZO Giovanni TROINA 09/05/1940 RZZGNN40E09L448V Proprieta` 1/3 69 4 RIZZO Maria Rosa CATANIA 21/11/1970 RZZMRS70S61C351N Proprieta` 1/9 RIZZO Salvatore TROINA 22/08/1947 RZZSVT47M22L448F -

The Italian Emigration of Modern Times
The University of Southern Mississippi The Aquila Digital Community Dissertations Spring 5-2010 The Italian Emigration of Modern Times: Relations Between Italy and the United States Concerning Emigration Policy, Diplomacy, and Anti-Immigrant Sentiment, 1870-1927 Patrizia Fama Stahle University of Southern Mississippi Follow this and additional works at: https://aquila.usm.edu/dissertations Part of the Cultural History Commons, European History Commons, Political History Commons, Social History Commons, and the United States History Commons Recommended Citation Stahle, Patrizia Fama, "The Italian Emigration of Modern Times: Relations Between Italy and the United States Concerning Emigration Policy, Diplomacy, and Anti-Immigrant Sentiment, 1870-1927" (2010). Dissertations. 934. https://aquila.usm.edu/dissertations/934 This Dissertation is brought to you for free and open access by The Aquila Digital Community. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of The Aquila Digital Community. For more information, please contact [email protected]. The University of Southern Mississippi THE ITALIAN EMIGRATION OF MODERN TIMES: RELATIONS BETWEENITALY AND THE UNITED STATES CONCERNING EMIGRATION POLICY,DIPLOMACY, AND ANTI-IMMIGRANT SENTIMENT, 1870-1927 by Patrizia Famá Stahle Abstract of a Dissertation Submitted to the Graduate School of The University of Southern Mississippi in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of Doctor of Philosophy May 2010 ABSTRACT THE ITALIAN EMIGRATION OF MODERN TIMES: RELATIONS BETWEEN ITALY AND THE UNITED STATES CONCERNING EMIGRATION POLICY, DIPLOMACY, AND ANTI-IMMIGRANT SENTIMENT, 1870-1927 by Patrizia Famà Stahle May 2010 In the late 1800s, the United States was the great destination of Italian emigrants. In North America, employers considered Italians industrious individuals, but held them in low esteem. -

REPERTORIO N.19994 RACCOLTA N.7956 CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI REPUBBLICA ITALIANA L'anno
REPERTORIO N.19994 RACCOLTA N.7956 CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilauno, il giorno ventotto del mese di dicembre. (28 dicembre 2001) In Enna, nella sala della Giunta della Provincia Regionale di Enna, sita in questa Piazza Garibaldi n.2 ove richiesto mi sono recata. Avanti a me dottor Grazia Fiorenza, notaio in Enna, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Enna e Nicosia, SONO PRESENTI 1) PROVINCIA REGIONALE DI ENNA, codice fiscale 80000810863, con sede in Enna alla Piazza Garibaldi n.2, a quest'atto rappresentata dal Presidente signor Michele Galvagno, impiegato, nato a Centuripe il 18 maggio 1954, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Provinciale del 16 ottobre 2001 n.72 del registro, n.72/C di protocollo, esecutiva; 2) COMUNE DI AGIRA, codice fiscale 00106510860 con sede in Agira, Via Vittorio Emanuele n.284, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Giunta Gaetano, ingegnere, nato ad Agira il 23 settembre 1947, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2001, verbale n.33, esecutiva; 3) COMUNE DI AIDONE, codice fiscale 80001220864, con sede in Aidone alla Piazza Umberto n.1, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Curia Filippo, impiegato, nato ad Aidone il 26 settembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta delibera del Commissario Straordinario del 26 ottobre 2001, n.36, esecutiva; -

D4-2 Uti 1.Pdf
Insediamenti della catena settentrionale degli Erei nel contatto con i Nebrodi 1 Cerami – Gagliano Castelferrato – Nicosia – Sperlinga - Troina scheda n. D4/2 1 UTI tema progettuale riferimento alla pianificazione operativa del PTP soggetti attuatori piani e modello territori dell'UTI programmi di settore produttivo tipologia del gestionale ed interessati tema progettuale note descrittive del tema progettuale sistema strutturante modalita' e strumenti d'attuazione settore interessato attuatori partneriato progetto istituzionale interessati dall'intervento Il progetto è parte della REP come AREE DI COMPLETAMENTO PROVINCIA - COMUNI - PARCO DEI BOSCHI DEI NODI DELLA RETE ECOLOGICA. Interessa nel dettaglio i EREI Boschi di Monte Scopino, di Busciana la Serra di Vito o di Cagnina AMBIENTE - CULTURA Nicosia, Gagliano, Cerami, INTERVENTO DIRETTO da attuare con il piano T 1 Intervento integrato di e la realizzazione del parco naturalistico Zuccaleo-Calumeli. REP - TURISMO - PROVINCIA Troina d'area tutela e valorizzazione valorizzazione AGRICOLTURA naturalistica- ambientale Il progetto si attua secondo i principi di sostenibilità proposti nello PROVINCIA - ENTI Schema Direttore della Rete Ecologica Provinciale e del PIR - Rete GESTORI DELLE AMBIENTE - CULTURA PROVINCIA CIRCUITO Ecologica Siciliana. RISERVE ED ENTI INTERVENTO DIRETTO da attuare con il piano - TURISMO - ENTI GESTORI Accordo di Parchi e riserve dell'UTI T 2 NATURALISTICO PIANO REP PARCO - d'area AGRICOLTURA - DELLE RISERVE programma tra tutela e valorizzazione DEGLI ALTI EREI D'AREA DEI ARTIGIANATO ED ENTI PARCO - Provincia e Pa/1 "PARCHI Comuni - Rete EREI" ecologica Il progetto interessa l'intero territorio provinciale nel recupero dei PROVINCIA - COMUNI - percorsi storici della rete trazzerale. Si declina, sul piano operativo, ENTI GESTORI DELLE anche con la costituizione di un Distretto Equestre funzionale alla RR.NN. -
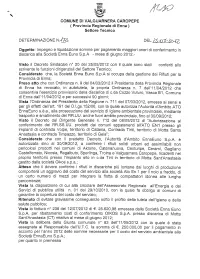
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE Settore Tecnico
vi V COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE ( Provincia Regionale di Enna ) Settore Tecnico DETERMINAZIONE N.Vg5> DEL Oggetto: Impegno e liquidazione somme per pagamento maggiori oneri di conferimento in discarica alla Società Enna Euno S.p.A - mese di giugno 201 2.- Visto il Decreto Sindacale n° 20 del 25/05/2012 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico; Considerato che, la Società Enna Euno S.p.A si occupa della gestione dei Rifiuti per la Provincia di Enna; Preso atto che con Ordinanza n. 9 del 04/03/2012 il Presidente della Provincia Regionale di Enna ha revocato, in autotutela, la propria Ordinanza n. 7 dell' 11/04/201 2 che consentiva l'esercizio provvisorio della discarica di c.da Cozzo Vuturo, Vasca B1, Comune di Enna dall1 11/04/20 12 e per successivi 90 giorni; Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 711 del 07/03/2012, emessa ai sensi e per gli effetti dell'ari. 191 del D.Lgs.152/06, con la quale autorizza l'Autorità d'Ambito ATO EnnaEuno s.è.a., alla prosecuzione del servizio di Igiene ambientale provinciale, mediante trasporto e smatimento dei RR.UU. anche fuori ambito provinciale, fino al 30/09/2012; Visto il Decreto del Dirigente Generale n. 712 del 08/05/2012 di "Autorizzazione al conferimento dei RR.SS.UU. prodotti dai comuni appatenenti all'ATO EN1 presso gli impianti di contrada Volpe, territorio di Catania, Contrada Tiriti, territorio di Motta Santa Anastasia e contrada Timpazzo, territorio di Gela"; Considerato che con il predetto Decreto, l'Autorità d'Ambito EnnaEuno S.p.A. -

Ordine Dei Farmacisti Della Provincia Di Enna
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ENNA Via Calabria, 50 - 94100 Enna - Telefono 0935533629 - Fax 0935531317 http://www.fofi.it/ordineen/ - E-Mail : [email protected] - [email protected] Albo Ordinario 1 ADAMO LUCIA nata a PIAZZA ARMERINA (EN) il 27/07/1984 è iscritta all'albo dal 22/01/2016 al numero 573 abilitazione all'esercizio della professione : Esame di Stato - Università degli studi di Catania - 2015 1^ SESS. - CATANIA residente in VIA NINO MARTOGLIO,25 a PIAZZA ARMERINA 94015 - EN 2 AGOZZINO ROSA nata a CATTOLICA ERACLEA (AG) il 23/02/1955 è iscritta all'albo dal 28/02/1980 al numero 283 abilitazione all'esercizio della professione : Esame di Stato - Università degli studi di Palermo - 1979 2^ SESS. - PALERMO residente in VIA GEN. DALLA CHIESA, 14 a BARRAFRANCA 94012 - EN 3 ALERCI ELENA nata a ENNA (EN) il 19/11/1959 è iscritta all'albo dal 03/06/1989 al numero 350 abilitazione all'esercizio della professione : Esame di Stato - Università degli studi di Catania - 1989 1^ SESS. - CATANIA residente in VIA ROMA, 289 a ENNA 94100 - EN 4 ALGOZINO LIDIA ANNA nata a LEONFORTE (EN) il 18/07/1956 è iscritta all'albo dal 31/12/1982 al numero 274 abilitazione all'esercizio della professione : Esame di Stato - Università degli studi di Catania - 1982 2^ SESS. - CATANIA residente in VIA OLIMPIADE, 12 a LEONFORTE 94013 - EN 5 ALIZADEH ARABANI NAVID nato a SOMEHSARA - IRAN il 21/01/1958 è iscritto all'albo dal 18/03/2000 al numero 413 abilitazione all'esercizio della professione : Esame di Stato - Università degli studi di Catania - 1996 1^ SESS. -

Chapter 1. Sicily to Australia. a Retrospective Overview 2
Chapter 1. Sicily to Australia. A Retrospective Overview 2 1.1 Elements of geography Sicilia, the island of Sicily, is a Region1 of modern Italy and includes, along with the mainland island, three minor archipelagos, the Aeolian Islands (7 islands), the Egadi Islands (3), the Pelagie Islands (3), and the islands of Pantelleria and Ustica. The largest island of the Mediterranean (27,500 square metres), it is Italy’s fourth most densely populated Region (preceded by the Regions of (in decreasing order): Lombardy, Campania and Lazio). Situated at the centre of the Mediterranean, it is the southernmost Region of Italy and lies about 100 miles northeast of Tunisia (North Africa) and is separated from mainland Italy (Calabrian Region) by the Messina Straits, 10 miles wide. Mostly mountainous in its interior, it hosts three major ranges: the Madonie (northwest), the Peloritani (northeast) and the high plateau of the Monti Iblei, in the southeast. Mount Etna, the highest active volcano in Europe (3340 metres high), stands alone, dominating a vast portion of the northeast territory. Relatively poor in waterways, reservoirs have been created to provide the necessary water supplies. Its vegetation was originally Mediterranean scrub, but through the centuries of different peoples have imported plants and crops from all over the world (including the now widespread Australian eucalyptus) and these have dramatically changed the island’s aspect over time. In the interior of Sicily, since Ancient Roman times, both the lives of its people and the landscape have been heavily characterized by the extensive cultivation of wheat. The Region of Sicily has its capital in Palermo and is administratively divided into nine Provinces, each with its own capital city: Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani.