Atri-Cerrano Un Sito Per L'unesco. Esame Delle Potenzialità Per La
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Listino Dei Valori Immobiliari Dei Terreni Agricoli
ISSN: 2280-191X LISTINO DEI VALORI IMMOBILIARI DEI TERRENI AGRICOLI PROVINCIA DI TERAMO LISTINO 2017 RILEVAZIONE ANNO 2016 quotazioni dei valori di mercato dei terreni agricoli entro un minimo e un massimo per le prin cipali colture in ciascun comune privati professionisti edizioni pubblica amministrazione O SSERVATORIO DEI VALORI AGRICOLI – PROVINCIA DI TERAMO – RILEVAZIONE 201 6 Hanno collaborato alla formazione del listino MASSIMO CURATOLO, ingegnere, membro di numerose commissioni di congruità presso enti pubblici. È stato capo area presso la struttura centrale della Agenzia del Territorio che si occupava di Osservatorio del mercato immobiliare. Ha diretto l’ufficio tecnico erariale di Isernia e di Viterbo. È stato capo del Servizio Tecnico 1° della Direzione Centrale dei SS.TT.EE. Autore/coautore di numerose pubblicazioni sia in campo estimale che catastale. Ha svolto numerosi incarichi di docenza. ANTONIO IOVINE, ingegnere consulente in materia di catasto ed estimo, attualmente direttore scientifico rivista informatica www.catastonline.it. È stato dirigente dell’Agenzia del territorio, responsabile dell’Area per i servizi catastali della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, membro della Commissione Censuaria Centrale. Autore/coautore di vari testi in materia di catasto, topografia ed estimo, ha svolto numerosi incarichi di docenza per conto della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e di altre strutture pubbliche o private tra cui, Scuola delle Autonomie locali, Consiel, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Verona, Synergia formazione. La redazione gradisce indicazioni costruttive o suggerimenti migliorativi ([email protected]). Disclaimer L’elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per errori o inesattezze. -

Elenco Definitivo Delle Domande Di Sostegno Ammissibili Per La
Allegato 1) alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/396 del 9/11/2017 Regione Abruzzo Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Politiche per l'inclusione, lo sviluppo e l'attrattività delle aree rurali Ufficio Politiche di sostegno all'avviamento di giovani agricoltori Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo - Bando "Pacchetto Giovani 2016" Elenco definitivo domande di sostegno AMMISSIBILI per la Sottomisura 6.1 - Tipo intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori" Premio Premio Punteggio Punteggio Num Domanda Beneficiario CUAA Comune Motivazioni di modifica del premio e/o del punteggio Richiesto Ammissibile Autoattribuito Ammissibile 54250044739 GRASSI FRANCESCA GRSFNC91S42E435N Vasto(CH) 50.000 50.000 87,50 87,50 - Sono stati attribuiti sia i 5 punti relativi all'incremento delle ULA, superiore ad 1, che i 1,5 punti relativi all'età dell'istante, superiore ai 35 anni. 54250001671 SAMUELE SERENA SMLSRN76H51G482K Pianella(PE) 50.000 50.000 80,00 86,50 Pertanto il punteggio finale passa dagli 80 punti richiesti agli 86,50 riconosciuti. AZIENDA AGRICOLA FARAONE SOCIETA' 54250049209 01963040678 Giulianova(TE) 100.000 100.000 85,75 85,75 - AGRICOLA 54250042931 ARETUSI ILENIA RTSLNI89L53G482U Alanno(PE) 60.000 60.000 85,00 85,00 RINUNCIA IN DATA 23/10/2017 54250043939 DI MICHELE CARLA DMCCRL97T52G482V Pescara(PE) 50.000 50.000 85,00 85,00 - 54250001929 DI TIZIO DANTE DTZDNT86T29C632W Tollo(CH) 50.000 50.000 85,00 85,00 - 54250051858 AZIENDA CARDAMONE -

Inventario Archivio Comune Di Pineto (TE)
COMUNE DI PINETO (PROVINCIA DI TERAMO) ARCHIVIO STORICO COMUNALE INVENTARIO 1799 – 1966 A cura di Anna Maria Censorii Sabatina Marini Maria Teresa Piccioni ACTAINFO S.R.L. Ottobre 2006 COMUNE DI PINETO Profilo storico istituzionale Sul toponimo di Mutignano, comune fino al 1927 e frazione di Pineto dal 1929, sono state fatte diverse teorie. Secondo una fantasiosa interpretazione deriverebbe da Mutini Fanum, culto in onore del dio Priapo silvestre, dio degli orti e dell’agricoltura. Altre congetture derivano il nome da Mutini-Janus, legandolo ad un doppio culto, quello di Priapo e di Giano, oppure da Mons-tignarius, ossia ricco di travi. Più correttamente, il suo nome deriverebbe dal personale romano Mutius, trasformatosi poi in Mut(t)inius. Dalle fonti storiche risulta che la denominazione relativa a Mutignano abbia subito nel corso dei secoli diverse trasformazioni. Dal Catalogus Barorum (1150-1168) Berardo, abate del monastero di S. Giovanni in Venere, tenne in feudo “Mutiguianum”. Nel 1275 Giordano, abate del monastero di S. Giovanni in Venere, chiede che gli venga prestato giuramento di fedeltà per le sue quote di possesso di “Mitignano”. Nel 1324 i cappellani di S. Pietro di “Miteneano” o “Mateniano” versano la decima annuale. Nel 1462 Ferrante I d’Aragona restituisce a Giulio Antonio d’Acquaviva i possedimenti del padre, includendovi l’abitato “Mitignani”. Nel 1502 Luigi XII di Valois-Orléans conferma ad Andrea Matteo III d’Acquaviva il casale “Mutignani”. Nel 1659 “Villa Mutignani” consisteva in un castello di 1039 anime. Nel 1729 ottiene la separazione dal tenimento di Atri e nel 1809 viene eretto a Comune di Mutignano. -
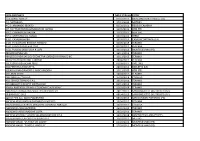
03/02/2015 Mosciano Sant'angelo (Te) A.C
ENTE OSPITANTE DATA STIPULA CITTA' "SOCCORSO AMICO" 03/02/2015 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) A.C. MATHEOLA 17/11/2010 MATERA A.C.D. ARMANDO SEGATO 03/01/2011 REGGIO CALABRIA A.P. DILETTANTISTICA GYMNASYUM-HATRIA 11/05/2011 ATRI (TE) A.P.D. GYMNASIUM HATRIA 11/05/2011 ATRI (TE) A.P.D. ORATORIO S.G. BOSCO 06/03/2012 TERNI A.S.D. CASALINGAMBA 16/09/2014 CASALINCONTRADA (CH) A.S.D. FC GAETANO BONOLIS TERAMO 31/05/2019 TERAMO A.S.D. GLADIUS PESCARA 2010 05/09/2011 PESCARA A.S.D. POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI 16/02/2016 MONTESILVANO (PE) ABRUZZI SONDA SAS 16/11/2013 TERAMO ABRUZZI SONDA SAS DEL GEOMETRA LORENZO DI FRANCO &C 16/11/2013 TERAMO ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO 20/06/2011 PESCARA ACCADEMIA DEI GIORNI FELICI 02/08/2011 AVELLINO ACD FEMMINILE BARLETTA 28/02/2011 BARLETTA (LE) ACEAFIN FINANZIAMENTI E ASSICURAZIONI 12/11/2020 ATRI (TE) ACLI ANNI VERDI 14/04/2011 TERAMO ACLI PROV.LE L'AQUILA 25/02/2014 L'AQUILA ACLI SERVICE TERAMO S.R.L. 16/03/2010 TERAMO ACS ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO 03/11/2015 TERAMO ADM & PARTNERS STP ARL- ECONOMICO AZIENDALE 15/03/2019 TERAMO ADRIATICA CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA 28/12/2011 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) AF BIANCUCCI SRLS 08/04/2015 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Agente FIFA Avv. ALDO PLACENTINO 08/01/2013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) AGENZIA ASSICURATIVA GASBARRO VINCENZO 13/04/2015 PESCARA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE ABRUZZO 14/02/2011 L'AQUILA AGENZIA DI ASSICURAZIONE 26/02/2010 TERAMO AGENZIA DI ASSICURAZIONE LUITA 26/02/2010 TERAMO AGENZIA GENERALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. -

Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Teramo
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO Teramo, 16 novembre 2015 Ns. Prot. n. 1532 Al Dirigente del settore lavori pubblici Comune di Roseto degli Abruzzi Dirigente tecnico Urbanistica e Edilizia Privata Arch. PATACCHINI Lorenzo [email protected] [email protected] Al Dirigente del settore lavori pubblici Comune di Giulianova Area IV° - Servizi alla Città ed al Territorio Responsabile: Mastropietro Maria Angela SERVIZI ALLA CITTA’ ED AL TERRITORIO [email protected] [email protected] Al Dirigente del settore lavori pubblici Comune di Silvi Funzionario Responsabile: Arch. DI PALMA Cesare [email protected] [email protected] Al Dirigente del settore lavori pubblici Comune di Martinsicuro AREA VI – LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE MAJELI Simonetta [email protected] [email protected] Al Dirigente del settore lavori pubblici Comune di Pineto Area Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente Responsabile: D'Evangelista Donato [email protected] [email protected] [email protected] Al Dirigente del settore lavori pubblici Comune di Alba Adriatica Ufficio lavori pubblici e politiche della casa Responsabile dell'ufficio: Arch. Luigi Irelli [email protected] [email protected] Al Dirigente del settore lavori pubblici Comune di Atri [email protected] -

Archivio Storico Comunale Inventario 1799 – 1966
COMUNE DI PINETO (PROVINCIA DI TERAMO) ARCHIVIO STORICO COMUNALE INVENTARIO 1799 – 1966 A cura di Anna Maria Censorii Sabatina Marini Maria Teresa Piccioni ACTAINFO S.R.L. Ottobre 2006 Progetto per la costruzione di un acquedotto in Mutignano (A.S.C.P. b. 16 f. 68, class. X-4) Manifesto (A.S.C.P. b. 2 f. 8, class. I-III) Piano della linea di demarcazione del territorio di Mutignano e Atri (A.S.C.P. b. 7 f. 102, class. II-II) Progetto di Edificio scolastico in località Filiani (A.S.C.P. b. 4 f. 21, class. IX-2) Progetto di Lavatoio (A.S.C.P. b. 19 f. 80, class. X-4) COMUNE DI PINETO Profilo storico istituzionale Sul toponimo di Mutignano, comune fino al 1927 e frazione di Pineto dal 1929, sono state fatte diverse teorie. Secondo una fantasiosa interpretazione deriverebbe da Mutini Fanum, culto in onore del dio Priapo silvestre, dio degli orti e dell’agricoltura. Altre congetture derivano il nome da Mutini-Janus, legandolo ad un doppio culto, quello di Priapo e di Giano, oppure da Mons-tignarius, ossia ricco di travi. Più correttamente, il suo nome deriverebbe dal personale romano Mutius, trasformatosi poi in Mut(t)inius. Dalle fonti storiche risulta che la denominazione relativa a Mutignano abbia subito nel corso dei secoli diverse trasformazioni. Dal Catalogus Barorum (1150-1168) Berardo, abate del monastero di S. Giovanni in Venere, tenne in feudo “Mutiguianum”. Nel 1275 Giordano, abate del monastero di S. Giovanni in Venere, chiede che gli venga prestato giuramento di fedeltà per le sue quote di possesso di “Mitignano”. -

Vacanze a Tutto Tondo: Mare, Montagne, Parchi, Campagne
acanze a tutto tondo: mare, montagne, parchi, campagne. Se il mare, i borghi di campagna, i grandi parchi, le riserve naturali e le cime dei paesaggi appenninici sono V il motivo centrale della tua vacanza, scopri le sorprese che la Provincia di Teramo ti riserva. Lungo l'asse costiero, che si estende per circa sessanta chilometri, sorgono, da nord a sud, sette città: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi. Le “sette sorelle”della “Costa dei Parchi”sono pronte ad accogliervi con la bellezza del loro mare e con l’eccellenza dei loro servizi turistici. In tutta la Provincia, il Consorzio Turistico “Costa dei Parchi”ti offre l’opportunità di soggiornare godendosi le proprie vacanze sulle spiagge della costa o nei piccoli borghi di montagna, nel cuore del Parco Naturale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, nel verde di una valle ma sempre con il mare a portata di mano. Soggiorni tutti caratterizzati dagli inconfondibili profumi e sapori che affiancano l’immagine di questi luoghi ad una favola. rlaub mit Allem Drum und Dran: Meer, Berge, Naturparks, Aufenthalte auf dem Land. Wenn in Ihrem Urlaub Meer, ländliche Altstädte, große Parks, Naturreservate und die Gipfel der U Apennin-Landschaft im Mittelpunkt stehen, dann entdecken Sie die Überraschungen der Provinz Teramos. Entlang der sich zirka sechzig Kilometer erstreckenden Küste befinden sich, von Norden nach Süden, sieben Städte: Martinsicuro, Alba Adriatica,Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto und Silvi. Die “sieben Schwestern“ der “Küste der Naturparks“ heißen Sie mit der Schönheit ihres Meeres und der ausgezeichneten Qualität ihres Touristenservices willkommen. -

DISPONIBILITA PRIMARIA A.S. 2021-22
a.s. 2021-22 Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo Disponibilità SCUOLA PRIMARIA Posti di tipo COMUNE 1 I.C. ALBA ADRIATICA RUOLO GM/18 DI SILVESTRE Giuseppina 2 I.C. ALBA ADRIATICA RUOLO GM/18 MACRILLANTI Giorgia 3 I.C. ALBA ADRIATICA RUOLO GM/18 DE MARE Maria 4 I.C. ALBA ADRIATICA RUOLO GM/18 DI GIUSEPPE Adele Annullamento trasferim. Interpr. Spurio Ass. prov. 5 I.C. ALBA ADRIATICA Elisabetta Interpr. DI NICOLA Mariateresa Ass. provv. 6 I.C. ATRI Insegnam. estero (Pacchione M.) Provinciale MARRONE Simona Ass. provv. Provinciale 7 I.C. CAMPLI DI MATTIA Alessio 8 I.C. CASTELLALTO-CELLINO RUOLO GM/18 CHIUSAROLI Monica 9 I.C. CASTELLALTO-CELLINO RUOLO GM/18 BRIZZI Eugenia 10 I.C. CASTELLALTO-CELLINO RUOLO GM/18 SACRIPANTE Pia 11 I.C. CASTELLALTO-CELLINO RUOLO GM/18 SANSONETTI Simona 12 I.C. CASTELLALTO-CELLINO Utilizzazione BATTISTINI Giovanni 13 I.C. CIVITELLA-TORRICELLA O.D. x IMMISSIONE IN RUOLO 14 I.C. CIVITELLA-TORRICELLA O.D. x IMMISSIONE IN RUOLO 15 I.C. CIVITELLA-TORRICELLA O.D. x IMMISSIONE IN RUOLO 16 I.C. CIVITELLA-TORRICELLA O.D. x IMMISSIONE IN RUOLO 17 I.C. CIVITELLA-TORRICELLA O.D. x IMMISSIONE IN RUOLO 18 I.C. CIVITELLA-TORRICELLA Applicaz. SENTENZA O.D. 19 I.C. CORROPOLI/COL/CONTR Applicaz. SENTENZA OD 20 I.C. GIULIANOVA 2 Utilizzazione DI MONTE Maria Gioietta Ass. provv. 21 I.C. ISOLA/COLLEDARA Applicaz. SENTENZA Interprov. MATTIOLI Francesca 22 I.C. MARTINSICURO RUOLO da GAE GRIECO Wanda 23 I.C. -
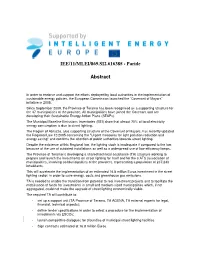
Paride Abstract
IEE/11/MLEI/869.SI2.616385 - Paride Abstract In order to endorse and support the efforts deployed by local authorities in the implementation of sustainable energy policies, the European Commission launched the “Covenant of Mayors” initiative in 2008. Since September 2009, the Province of Teramo has been recognised as a supporting structure for the 47 municipalities of the province. All municipalities have joined the Covenant and are developing their Sustainable Energy Action Plans (SEAPs). The Municipal Baseline Emissions Inventories (BEI) show that almost 70% of local electricity energy consumption is due to street lighting. The Region of Abruzzo, also supporting structure of the Covenant of Mayors, has recently updated the Regional Law 12/2005 concerning the "Urgent measures for light pollution reduction and energy saving" and confirms the attention of public authorities towards street lighting. Despite the existence of this Regional law, the lighting stock is inadequate if compared to the law, because of the use of outdated installations as well as a widespread use of low-efficiency lamps. The Province of Teramo is developing a shared technical assistance (TA) structure working to prepare and launch the investments on street lighting for itself and for the 3 ATS (association of municipalities, involving 33 Municipalities of the province), representing a population of 237.243 inhabitants. This will accelerate the implementation of an estimated 16.8 million Euros investment in the street lighting sector, in order to save energy, costs and greenhouse gas emissions. TA is needed to enable the transition from potential to real investment projects and to facilitate the mobilisation of funds for investments in small and medium-sized municipalities which, if not aggregated, could not make the upgrade of street lighting economically viable. -

Sezione Revisori Dei Conti Accreditati
SEZIONE REVISORI DEI CONTI ACCREDITATI All.1 SEDE N° NOMINATIVO INDIRIZZO CITTA' ORDINE 1 RAPACCHIALE DOTT.SSA FILOMENA VIA V. BINDI 2 SILVI 2 FAVA MARCO VIA F. CRISPI 62 TERAMO 3 GRAZIANI CHRISTIAN VIALE BOVIO, 52 TERAMO 4 DE BLASIO CLAUDIO VIA RONCHI, 21 PESCARA 5 LUCCHESE ANDREA VILLA FALCHINI, SNC TERAMO 6 SCARDAPANE DANIELA VIA CIRCONVALLAZIONE,9 SAN SALVO VASTO 7 MONACELLI PATRIZIA VIA VILLA, 5 TOCCO DA CASAURIA PESCARA 8 DI GIULIO MARIA GRAZIA VIA LAGO ISOLETTA, 45 PESCARA PESCARA 9 MICONI VITTORIO PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 17 L'AQUILA L'AQUILA 10 SACCHINI MICHELE VIA MONTE FAITO, 19 PESCARA PESCARA 11 DI MARCO ALESSANDRO VIA LA FIGLIA DI IORIO 14 PESCARA 12 VALCHERA AUGUSTO VIA MARIA PALMA MEZZOPRETI TERAMO TERAMO 13 IPPOLITI STEFANO VIA ITALICA, 49 PESCARA 14 GIUSTI MARCO VIA MONTE CARMELO, 38 PESCARA 15 IVONE ANTONIO VIA PRIMO VERE, 150/6 PESCARA 16 IVONE MASSIMO VIA CAMPOFELICE 47 PESCARA PESCARA 17 ROMANO LUCIA LOC.TA' PIANA S.ANGELO CASTEL DI SANGRO 18 DE DONATO SILVANA VIA SAN PIETRO,8 TOLLO 19 POMPONI LARA VIA C. COLOMBO, 132 SAN NICOLO' A TORDINO 20 PICHELLI MARCO VIA FONTE MURATA - FRAZ. MONTONE MOSCIANO SANT'ANGELO 21 URSITTI ANSELMO VIA AMERICA, 45 AVEZZANO AVEZZANO 22 MANCINI MARIO VIA GAMBINI, 7 TERAMO 23 BALIVA TONINO VIA DELLE GOLE, 2 AIELLI 24 GIZZI FRANCESCO VIA TIBULLO, 60 PESCARA PESCARA 25 CARUNCHIO LUIGI ALFREDO VIA C. BATTISTI, 12 LANCIANO LANCIANO 26 PAOLUCCI PERANGELO VIA CAPANNE, 30 TOLLO 27 DI CRISTOFORO EZIO VIA SANGRO, 3 ROSETO DEGLI ABRUZZI 28 RANALLI GIUSEPPE VIA CARSO, 41 SULMONA 29 SIMONE NICOLA VIA PIANA VACANTE, 66 ATESSA 30 PICHINI MASSIMO VIA TORRE BRUCIATA, 5 TERAMO TERAMO 31 RAPINO ETTORE VIA G. -

Sistema Informativo Ministero Della Pubblica Istruzione
SMOW5A 11-06-10PAG. 1 SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : TERAMO ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2010/11 ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 1. CAMPLESE DANIELA . 26/ 9/72 (TE) DA : TEAA82600V - I.C. NERETO (NERETO) A : TEAA82600V - I.C. NERETO (NERETO) DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 77 2. CIPRIANI GABRIELLA . 2/ 5/60 (TE) DA : TEAA05100L - D.D. ROSETO 2 CIRCOLO (ROSETO DEGLI ABRUZZI) A : TEAA04900L - D.D. ROSETO 1 CIRCOLO (ROSETO DEGLI ABRUZZI) PUNTI 21 (SOPRANNUMERARIO TRASFERITO CON DOMANDA CONDIZIONATA) 3. DE ASCANIIS GIOVANNA . 8/ 7/70 (TE) DA : TEAA05800B - D.D. S.EGIDIO ALLA VIBRATA (SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA) A : TEAA05800B - D.D. S.EGIDIO ALLA VIBRATA (SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA) DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 99 4. DE FULGENTIIS ADRIANA . 3/ 9/72 (AP) DA : TEAA82200G - I.C. ALBA ADRIATICA (ALBA ADRIATICA) A : TEAA82200G - I.C. ALBA ADRIATICA (ALBA ADRIATICA) DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 52 5. DI LUDOVICO ROBERTA . 10/ 4/67 (TE) DA : TEAA00100G - D.D. TERAMO NOE LUCIDI (TERAMO) A : TEAA00100G - D.D. TERAMO NOE LUCIDI (TERAMO) DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 122 SMOW5A 11-06-10PAG. 2 TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 6. -

I Vulcanelli Di Fando Nella Regione Abruzzo
Di Francesco Romolo*, Scalella Gianni**, LE SORGENTI CONNESSE AI VULCANELLI DI FANGO NEL TERRITORIO TERAMANO DELLA REGIONE ABRUZZO: VALORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TUTELA. * GEO&GEO Instruments – Borgata Vezzola, 2 – 64100 Teramo; www.geoandgeo.com ** Regione Marche, Autorità di Bacino Regionale – 60100 Ancona RIASSUNTO Le prime descrizioni delle sorgenti connesse ai “vulcani di fango” presenti nel territorio abruzzese risalgono alla metà del 1800 (Amary,1850, Stoppani, 1866; Cacciamali, 1892; Bonasera, 1954). Nell’area abruzzese tali sorgenti sono ubicate nel bacino periadriatico caratterizzato dai terreni plio-pleistocenici costituiti da alternanze conglomeratiche, arenacee e marnose poggianti sui sedimenti messiniani della Formazione della Laga. Nel settore teramano le sorgenti connesse ai “vulcani di fango”, che rappresentano la concausa di generazione della forma stessa, non sono particolarmente diffuse; tra le località ad oggi individuate sono da citare una zona nel Comune di Pineto (TE), due nel Comune di Cellino Attanasio (TE), una nel Comune di Atri (TE) e due nel Comune di Torano Nuovo (TE). Con il presente lavoro, che rappresenta uno dei pochissimi tentativi di indagine su tale tipologia di sorgenti, sono state studiate in dettaglio le sorgenti di Pineto e Cellino Attanasio; in quanto osservazioni di lungo periodo hanno permesso di evidenziare una caratteristica intermittente del fenomeno, apparentemente connessa con il regime pluviometrico (Biasutti, 1907, Bonasera, 1954; Barnaba, 1994; Scalella, 1996, 2000) responsabile delle variazioni del gradiente idraulico nel sottosuolo. Altresì le acque sorgenti mostrano caratteristiche chimico- fisiche che consentono di escluderne il loro utilizzo per fini termali. La particolarità della morfologia dei luoghi nei quali tali sorgenti si sviluppano, nonché il numero esiguo di tali forme può rappresentare l’input per promuovere tali beni ambientali da comprendere nei beni protetti fruibili nell’ambito della Regione Abruzzo.