I Vulcanelli Di Fando Nella Regione Abruzzo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Listino Dei Valori Immobiliari Dei Terreni Agricoli
ISSN: 2280-191X LISTINO DEI VALORI IMMOBILIARI DEI TERRENI AGRICOLI PROVINCIA DI TERAMO LISTINO 2017 RILEVAZIONE ANNO 2016 quotazioni dei valori di mercato dei terreni agricoli entro un minimo e un massimo per le prin cipali colture in ciascun comune privati professionisti edizioni pubblica amministrazione O SSERVATORIO DEI VALORI AGRICOLI – PROVINCIA DI TERAMO – RILEVAZIONE 201 6 Hanno collaborato alla formazione del listino MASSIMO CURATOLO, ingegnere, membro di numerose commissioni di congruità presso enti pubblici. È stato capo area presso la struttura centrale della Agenzia del Territorio che si occupava di Osservatorio del mercato immobiliare. Ha diretto l’ufficio tecnico erariale di Isernia e di Viterbo. È stato capo del Servizio Tecnico 1° della Direzione Centrale dei SS.TT.EE. Autore/coautore di numerose pubblicazioni sia in campo estimale che catastale. Ha svolto numerosi incarichi di docenza. ANTONIO IOVINE, ingegnere consulente in materia di catasto ed estimo, attualmente direttore scientifico rivista informatica www.catastonline.it. È stato dirigente dell’Agenzia del territorio, responsabile dell’Area per i servizi catastali della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, membro della Commissione Censuaria Centrale. Autore/coautore di vari testi in materia di catasto, topografia ed estimo, ha svolto numerosi incarichi di docenza per conto della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e di altre strutture pubbliche o private tra cui, Scuola delle Autonomie locali, Consiel, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Verona, Synergia formazione. La redazione gradisce indicazioni costruttive o suggerimenti migliorativi ([email protected]). Disclaimer L’elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per errori o inesattezze. -

Conferenza Provinciale Di Organizzazione Della Rete Scolastica Della Provincia Di Teramo
CONFERENZA PROVINCIALE DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI TERAMO Deliberazione n. 01 del 28 novembre 2019 OGGETTO: Definizione del Piano di dimensionamento della rete scolastica della Provincia di Teramo a.s. 2019/2020. L’anno duemiladiannove, il giorno ventotto del mese di novembre ore 16,10, nel Palazzo della Provincia, previa convocazione prot. n. 0027520 del 20/11/2019 del Presidente della Provincia di Teramo, si è riunita, in seconda convocazione, ed in seduta pubblica e deliberativa, la Conferenza Provinciale per l’organizzazione della rete scolastica della Provincia di Teramo, istituita con deliberazione n. 19 del 18/01/2016 del Presidente della Provincia di Teramo. A seguito di appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti componenti: PRE. ASS. DELEGATI PROVINCIA DI TERAMO Presidente della Provincia DIEGO DI BONAVENTURA 1 ALBA ADRIATICA Sindaco ANTONIETTA CASCIOTTI x 2 ANCARANO Sindaco PIETRANGELO PANICHI x 3 ARSITA Sindaco CATIUSCIA CACCIATORE x 4 ATRI Sindaco PIERGIORGIO FERRETTI x 5 BASCIANO Sindaco ALESSANDRO FRATTAROLI x 6 BELLANTE Sindaco GIOVANNI MELCHIORRE x 7 BISENTI Sindaco ENZINO DE FEBIS x 8 CAMPLI Assessore VALENTINA DI FRANCESCO x Delegata del Sindaco FEDERICO AGOSTINELLI 9 CANZANO Sindaco MARIA MARSILII x 10 CASTEL CASTAGNA Sindaco ROSANNA DE ANTONIS x 11 CASTELLALTO Sindaco VINCENZO DI MARCO x 12 CASTELLI Sindaco RINALDO SECA x 13 CASTIGLIONE M. R. Sindaco VINCENZO D’ERCOLE x 14 CASTILENTI Sindaco ALBERTO GIULIANI x 15 CELLINO ATTANASIO Sindaco GIUSEPPE DEL PAPA -

Elenco Definitivo Delle Domande Di Sostegno Ammissibili Per La
Allegato 1) alla Determinazione dirigenziale nr DPD020/396 del 9/11/2017 Regione Abruzzo Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Politiche per l'inclusione, lo sviluppo e l'attrattività delle aree rurali Ufficio Politiche di sostegno all'avviamento di giovani agricoltori Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo - Bando "Pacchetto Giovani 2016" Elenco definitivo domande di sostegno AMMISSIBILI per la Sottomisura 6.1 - Tipo intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori" Premio Premio Punteggio Punteggio Num Domanda Beneficiario CUAA Comune Motivazioni di modifica del premio e/o del punteggio Richiesto Ammissibile Autoattribuito Ammissibile 54250044739 GRASSI FRANCESCA GRSFNC91S42E435N Vasto(CH) 50.000 50.000 87,50 87,50 - Sono stati attribuiti sia i 5 punti relativi all'incremento delle ULA, superiore ad 1, che i 1,5 punti relativi all'età dell'istante, superiore ai 35 anni. 54250001671 SAMUELE SERENA SMLSRN76H51G482K Pianella(PE) 50.000 50.000 80,00 86,50 Pertanto il punteggio finale passa dagli 80 punti richiesti agli 86,50 riconosciuti. AZIENDA AGRICOLA FARAONE SOCIETA' 54250049209 01963040678 Giulianova(TE) 100.000 100.000 85,75 85,75 - AGRICOLA 54250042931 ARETUSI ILENIA RTSLNI89L53G482U Alanno(PE) 60.000 60.000 85,00 85,00 RINUNCIA IN DATA 23/10/2017 54250043939 DI MICHELE CARLA DMCCRL97T52G482V Pescara(PE) 50.000 50.000 85,00 85,00 - 54250001929 DI TIZIO DANTE DTZDNT86T29C632W Tollo(CH) 50.000 50.000 85,00 85,00 - 54250051858 AZIENDA CARDAMONE -

Supplement of User-Oriented Hydrological Indices For
Supplement of Hydrol. Earth Syst. Sci., 25, 1969–1992, 2021 https://doi.org/10.5194/hess-25-1969-2021-supplement © Author(s) 2021. CC BY 4.0 License. Supplement of User-oriented hydrological indices for early warning systems with validation using post-event surveys: flood case studies in the Central Apennine District Annalina Lombardi et al. Correspondence to: Annalina Lombardi ([email protected]) The copyright of individual parts of the supplement might differ from the article licence. SUPPLEMENTARY MATERIALS Web links to information sources listed in Table 2: CS01 Umbria Region http://www.cfumbria.it/supporto/download/Rapporti_evento/03_Novembre_2013/CFDUmbria_RapportoE Reports: vento_Nov2013.pdf https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/?act=filterdate&pg=24&f_day=11&f_month=11&f_year=20 13&f_zona=centro Press https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/?act=filterdate&pg=24&f_day=12&f_month=11&f_year=20 Reviews: 13&f_zona=centro https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/?act=filterdate&pg=24&f_day=13&f_month=11&f_year=20 13&f_zona=centro https://www.youtube.com/watch?v=gCfy7GOxmkk https://www.youtube.com/watch?v=E8Tv_jZjrNI https://www.youtube.com/watch?v=13N6caKVV0E https://www.youtube.com/watch?v=2hG0Vp5Rsew Videos: https://www.youtube.com/watch?v=i6q4D99t-2U https://www.youtube.com/watch?v=E8Tv_jZjrNI http://www.umbria24.it/video/alluvione-in-umbria-gli-allagamenti-a-perugia-e-dintorni https://www.youtube.com/watch?v=7Bg0w8o07Ng https://www.youtube.com/watch?v=7-Lf8ZMxzBM https://www.youtube.com/watch?v=13N6caKVV0E -

Circolare Ricostruzione Pubblica N. 2/2018
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 Sede di Teramo ________________________________________________________________________________________________ Prot n. Teramo, lì ATER Teramo [email protected] ATER L’Aquila [email protected] ATER Pescara [email protected] Comune di Cagnano Amiterno (AQ) [email protected] Comune di Campli (TE) [email protected] Comune di Capitignano (AQ) [email protected] Comune di Civitella del Tronto (TE) [email protected] Comune di Cortino (TE) [email protected] Comune di Isola del Gran sasso (TE) [email protected] Comune di Montorio al Vomano (TE) [email protected] Comune di Tossicia (TE) [email protected] Comune di Valle Castellana (TE) [email protected] Comune di Basciano (TE) [email protected] Comune di Martinsicuro (TE) [email protected] Comune di Penna Sant’Andrea (TE) [email protected] Ufficio Speciale per la Ricostruzione - Abruzzo Via Cerulli Irelli 15/17 Piano II 64100 TE [email protected] - [email protected] - Tel. 0861/021367 UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 Sede di Teramo ________________________________________________________________________________________________ Comune di Pescosansonesco (PE) [email protected] Comune di San Valentino in A.C. (PE) [email protected] Oggetto: Circolare Ricostruzione Pubblica n. 2/2018. Chiarimenti sulle procedure finalizzate alla realizzazione di interventi di ricostruzione pubblica inerenti la riparazione del patrimonio pubblico suscettibile di destinazione abitativa. Rif. Ordinanza Commissariale n.27 del 09.06.2017 e ss.mm.ii. Con riferimento alle procedure necessarie alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica finanziati con la Ordinanza Commissariale n. -

Inventario Archivio Comune Di Pineto (TE)
COMUNE DI PINETO (PROVINCIA DI TERAMO) ARCHIVIO STORICO COMUNALE INVENTARIO 1799 – 1966 A cura di Anna Maria Censorii Sabatina Marini Maria Teresa Piccioni ACTAINFO S.R.L. Ottobre 2006 COMUNE DI PINETO Profilo storico istituzionale Sul toponimo di Mutignano, comune fino al 1927 e frazione di Pineto dal 1929, sono state fatte diverse teorie. Secondo una fantasiosa interpretazione deriverebbe da Mutini Fanum, culto in onore del dio Priapo silvestre, dio degli orti e dell’agricoltura. Altre congetture derivano il nome da Mutini-Janus, legandolo ad un doppio culto, quello di Priapo e di Giano, oppure da Mons-tignarius, ossia ricco di travi. Più correttamente, il suo nome deriverebbe dal personale romano Mutius, trasformatosi poi in Mut(t)inius. Dalle fonti storiche risulta che la denominazione relativa a Mutignano abbia subito nel corso dei secoli diverse trasformazioni. Dal Catalogus Barorum (1150-1168) Berardo, abate del monastero di S. Giovanni in Venere, tenne in feudo “Mutiguianum”. Nel 1275 Giordano, abate del monastero di S. Giovanni in Venere, chiede che gli venga prestato giuramento di fedeltà per le sue quote di possesso di “Mitignano”. Nel 1324 i cappellani di S. Pietro di “Miteneano” o “Mateniano” versano la decima annuale. Nel 1462 Ferrante I d’Aragona restituisce a Giulio Antonio d’Acquaviva i possedimenti del padre, includendovi l’abitato “Mitignani”. Nel 1502 Luigi XII di Valois-Orléans conferma ad Andrea Matteo III d’Acquaviva il casale “Mutignani”. Nel 1659 “Villa Mutignani” consisteva in un castello di 1039 anime. Nel 1729 ottiene la separazione dal tenimento di Atri e nel 1809 viene eretto a Comune di Mutignano. -

Basciano, Canzano, Castellalto, Cellino
A Guardie farmaceutiche in applicazione delle LL.RR. 28.03.1989 N n. 24,25.6.1991 n. 28, 16.1.1992 n. 3, 24.8.1992 n. 81. N Calendario delle giornate di riposo infrasettimanale, O degli orari e delle guardie farmaceutiche delle Farmacie della Provincia di Teramo COMUNE FARMACIA BASCIANO DI FEBBO FIRMINIO CANZANO DI CLEMENTE STEFANIA CASTELLALTO RASETTI LEO AMMASSARI S.A.S. DEL DR. FABRIZIO AMMASSARI & C. (CASTELNUOVO VOMANO) 2 CELLINO ATTANASIO CASTRIOTA ANDREA CERMIGNANO FARMATYKE SAS DI DEGLI ESPOSTI PAOLO & C. 0 MORRO D'ORO CHIERICHETTI DI CHIERICHETTI PATRIZIA E C. SNC (PAGLIARE) COMUNALE 2 NOTARESCO MAZZONI DOTT. BORRECA ALBERTO SCIARRETTA SNC DI CANDELORI DOTT. ALFEO & C. (GUARDIA VOMANO) 1 PENNA SANT'ANDREA ZUCCARINI SAS DEI DOTTORI CARLO ZUCCARINI E DE BELLIS REBECCA E C. (VAL VOMANO) 2021 SEDE FARMACEUTICA ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA CELLINO ATTANASIO FARMACIA CASTRIOTA 8:30 - 12:30 / 16:30 - 19:30 CERMIGNANO FARMATYKE SAS DI DEGLI ESPOSTI PAOLO & C. 8:30 - 13:00 / 16:00 - 19:30 NOTARESCO FARMACIA MAZZONI DOTT. BORRECA 8:30 - 13:00 / 16:00 - 19:30 CASTELNUOVO VOMANO FARMACIA AMMASSARI S.A.S. 8:30 - 12:45 / 16:00 - 19:30 GUARDIA VOMANO FARMACIA SCIARETTA DOTT. CADELORI 8:30 - 13:00 / 16:00 - 19:30 PAGLIARE DI MORRO D'ORO FARMACIA CHIERICHETTI SNC 8:30 - 13:00 / 16:00 - 19:30 Con l'adozione dell'ora legale viene effettuato il seguente orario estivo pomeridiano: 16:30/20:00 CASTELLALTO FARMACIA RASETTI 9:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00 tutto l'anno (Lunedì mattina 9:30 - 11:30) FARMACIA COMUNALE MORRO D'ORO ORARIO SOLARE 9:00 - 12:30 / 15:30 - 19:00 ORARIO LEGALE 9:00 - 12:30 / 16:00 - 19:30 CANZANO FARMACIA DI CLEMENTE 8:30 - 13:00 / 16:00 - 20:00 (tutto l'anno) VAL VOMANO FARMACIA ZUCCARINI SAS ORARIO 8:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00 BASCIANO FARMACIA DI FEBBO EST. -

Cellino Attanasio
Comune di Cellino Attanasio PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (Piano di Protezione Civile) livello speditivo (versione 1.0) Aggiornamento: 1 INDICE 1 PREMESSA .................................................................................................................3 2 PARTE GENERALE .....................................................................................................4 2.1 IL TERRITORIO COMUNALE ...............................................................................4 2.2 ORGANIGRAMMA COMUNALE...........................................................................4 2.3 MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA .....................4 3 RISCHIO IDROGEOLOGICO .......................................................................................6 3.1 SISTEMA DI ALLERTAMENTO ............................................................................6 3.2 SCENARI DI EVENTO ..........................................................................................7 3.3 PROCEDURE OPERATIVE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ....................10 4 RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO ..............................................................................58 4.1 SISTEMA DI ALLERTAMENTO ..........................................................................58 4.2 SCENARI DI EVENTO ........................................................................................59 4.3 PROCEDURE OPERATIVE PER IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI ..................61 5 RISCHIO SISMICO ...................................................................................................109 -
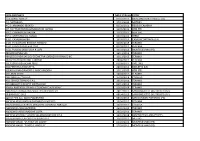
03/02/2015 Mosciano Sant'angelo (Te) A.C
ENTE OSPITANTE DATA STIPULA CITTA' "SOCCORSO AMICO" 03/02/2015 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) A.C. MATHEOLA 17/11/2010 MATERA A.C.D. ARMANDO SEGATO 03/01/2011 REGGIO CALABRIA A.P. DILETTANTISTICA GYMNASYUM-HATRIA 11/05/2011 ATRI (TE) A.P.D. GYMNASIUM HATRIA 11/05/2011 ATRI (TE) A.P.D. ORATORIO S.G. BOSCO 06/03/2012 TERNI A.S.D. CASALINGAMBA 16/09/2014 CASALINCONTRADA (CH) A.S.D. FC GAETANO BONOLIS TERAMO 31/05/2019 TERAMO A.S.D. GLADIUS PESCARA 2010 05/09/2011 PESCARA A.S.D. POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI 16/02/2016 MONTESILVANO (PE) ABRUZZI SONDA SAS 16/11/2013 TERAMO ABRUZZI SONDA SAS DEL GEOMETRA LORENZO DI FRANCO &C 16/11/2013 TERAMO ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO 20/06/2011 PESCARA ACCADEMIA DEI GIORNI FELICI 02/08/2011 AVELLINO ACD FEMMINILE BARLETTA 28/02/2011 BARLETTA (LE) ACEAFIN FINANZIAMENTI E ASSICURAZIONI 12/11/2020 ATRI (TE) ACLI ANNI VERDI 14/04/2011 TERAMO ACLI PROV.LE L'AQUILA 25/02/2014 L'AQUILA ACLI SERVICE TERAMO S.R.L. 16/03/2010 TERAMO ACS ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO 03/11/2015 TERAMO ADM & PARTNERS STP ARL- ECONOMICO AZIENDALE 15/03/2019 TERAMO ADRIATICA CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA 28/12/2011 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) AF BIANCUCCI SRLS 08/04/2015 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Agente FIFA Avv. ALDO PLACENTINO 08/01/2013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) AGENZIA ASSICURATIVA GASBARRO VINCENZO 13/04/2015 PESCARA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE ABRUZZO 14/02/2011 L'AQUILA AGENZIA DI ASSICURAZIONE 26/02/2010 TERAMO AGENZIA DI ASSICURAZIONE LUITA 26/02/2010 TERAMO AGENZIA GENERALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. -

Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Teramo
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO Teramo, 16 novembre 2015 Ns. Prot. n. 1532 Al Dirigente del settore lavori pubblici Comune di Roseto degli Abruzzi Dirigente tecnico Urbanistica e Edilizia Privata Arch. PATACCHINI Lorenzo [email protected] [email protected] Al Dirigente del settore lavori pubblici Comune di Giulianova Area IV° - Servizi alla Città ed al Territorio Responsabile: Mastropietro Maria Angela SERVIZI ALLA CITTA’ ED AL TERRITORIO [email protected] [email protected] Al Dirigente del settore lavori pubblici Comune di Silvi Funzionario Responsabile: Arch. DI PALMA Cesare [email protected] [email protected] Al Dirigente del settore lavori pubblici Comune di Martinsicuro AREA VI – LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE MAJELI Simonetta [email protected] [email protected] Al Dirigente del settore lavori pubblici Comune di Pineto Area Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente Responsabile: D'Evangelista Donato [email protected] [email protected] [email protected] Al Dirigente del settore lavori pubblici Comune di Alba Adriatica Ufficio lavori pubblici e politiche della casa Responsabile dell'ufficio: Arch. Luigi Irelli [email protected] [email protected] Al Dirigente del settore lavori pubblici Comune di Atri [email protected] -

GAL TERREVERDI TERAMANE “Insieme Per Un Territorio Di Qualità Che Cresce”
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER Piano di azione DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) GAL TERREVERDI TERAMANE “Insieme per un territorio di qualità che cresce” GAL Terreverdi Teramane Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sommario PIANO DI AZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) ................................................................................................................... 1 1. Introduzione: descrizione area gal ............................................................................................................................. 3 2. Analisi di contesto ..................................................................................................................................................... 7 2.1. SINTESI ANALISI SWOT ............................................................................................................................. 20 2.2. CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO PROPONENTE.................................................................. 23 3. Strategia del PSL ..................................................................................................................................................... 26 Il piano finanziario della SSL ........................................................................................................................................... 29 19.2 - Le azioni ................................................................................................................................................................ -

Archivio Storico Comunale Inventario 1799 – 1966
COMUNE DI PINETO (PROVINCIA DI TERAMO) ARCHIVIO STORICO COMUNALE INVENTARIO 1799 – 1966 A cura di Anna Maria Censorii Sabatina Marini Maria Teresa Piccioni ACTAINFO S.R.L. Ottobre 2006 Progetto per la costruzione di un acquedotto in Mutignano (A.S.C.P. b. 16 f. 68, class. X-4) Manifesto (A.S.C.P. b. 2 f. 8, class. I-III) Piano della linea di demarcazione del territorio di Mutignano e Atri (A.S.C.P. b. 7 f. 102, class. II-II) Progetto di Edificio scolastico in località Filiani (A.S.C.P. b. 4 f. 21, class. IX-2) Progetto di Lavatoio (A.S.C.P. b. 19 f. 80, class. X-4) COMUNE DI PINETO Profilo storico istituzionale Sul toponimo di Mutignano, comune fino al 1927 e frazione di Pineto dal 1929, sono state fatte diverse teorie. Secondo una fantasiosa interpretazione deriverebbe da Mutini Fanum, culto in onore del dio Priapo silvestre, dio degli orti e dell’agricoltura. Altre congetture derivano il nome da Mutini-Janus, legandolo ad un doppio culto, quello di Priapo e di Giano, oppure da Mons-tignarius, ossia ricco di travi. Più correttamente, il suo nome deriverebbe dal personale romano Mutius, trasformatosi poi in Mut(t)inius. Dalle fonti storiche risulta che la denominazione relativa a Mutignano abbia subito nel corso dei secoli diverse trasformazioni. Dal Catalogus Barorum (1150-1168) Berardo, abate del monastero di S. Giovanni in Venere, tenne in feudo “Mutiguianum”. Nel 1275 Giordano, abate del monastero di S. Giovanni in Venere, chiede che gli venga prestato giuramento di fedeltà per le sue quote di possesso di “Mitignano”.