Roma Alla Fine Del Settecento. Cultura, Storia E Urbanistica Questa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Urban Development of Rome in the Age of Alexander VII by Dorothy Metzger Habel Review By: John E
Masthead Logo Smith ScholarWorks Art: Faculty Publications Art 6-2006 Reviewed Work(s): The rbU an Development of Rome in the Age of Alexander VII by Dorothy Metzger Habel John E. Moore Smith College, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.smith.edu/art_facpubs Part of the Arts and Humanities Commons Recommended Citation Moore, John E., "Reviewed Work(s): The rU ban Development of Rome in the Age of Alexander VII by Dorothy Metzger Habel" (2006). Art: Faculty Publications, Smith College, Northampton, MA. https://scholarworks.smith.edu/art_facpubs/7 This Book Review has been accepted for inclusion in Art: Faculty Publications by an authorized administrator of Smith ScholarWorks. For more information, please contact [email protected] Review Reviewed Work(s): The Urban Development of Rome in the Age of Alexander VII by Dorothy Metzger Habel Review by: John E. Moore Source: Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 65, No. 2 (Jun., 2006), pp. 306-308 Published by: University of California Press on behalf of the Society of Architectural Historians Stable URL: http://www.jstor.org/stable/25068281 Accessed: 09-07-2018 15:51 UTC JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Your use of the JSTOR archive -

Edward J. Olszewski Dynamics of Architecture in Late Baroque Rome
Edward J. Olszewski Dynamics of Architecture in Late Baroque Rome. Cardinal Pietro Ottoboni at the Cancelleria Edward J. Olszewski Dynamics of Architecture in Late Baroque Rome. Cardinal Pietro Ottoboni at the Cancelleria Managing Editor: Monika Michałowicz Published by De Gruyter Open Ltd, Warsaw/Berlin Part of Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Munich/Boston This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 license, which means that the text may be used for non-commercial purposes, provided credit is given to the author. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. Copyright © 2015 Edward J. Olszewski ISBN 978-3-11-045245-7 e- ISBN 978-3-11-045246-4 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.dnb.de. Managing Editor: Monika Michałowicz www.degruyteropen.com Cover illustration: © Gabinetto Nazionale delle Stampe, Rome Contents Preface VIII Abbreviation X 1 Introduction 1 1.1 Origins 1 1.2 Papal Patronage 5 2 Architectural Beginnings 17 2.1 The First Architects 17 2.2 Early Theaters 21 2.3 Ottoboni Holdings 25 2.4 G.F. Pellegrini 31 2.5 Nicola Michetti 33 3 Theater Architecture 36 3.1 Ottoboni Theater & Filippo Juvarra 36 3.2 Juvarra’s Theater Drawings 39 3.3 The Lost Theater 40 3.4 Studies of Juvarra’s Theater Drawings 45 3.5 The Fate of Ottoboni’s Theater 53 3.6 Appearance of the Theater 53 4 Other Cancelleria Spaces 73 4.1 The Sala Riaria 73 4.2 Ludovico Rusconi Sassi 73 4.3 The Arcadian Academy 76 4.4 The Bosco Parrasio 78 4.5 San Lorenzo in Damaso 81 5 Architectural Collaboration 87 5.1 The Lateran Façade Competition 87 6 Fugitive Architecture 92 6.1 The Final Decade 92 6.2 Domenico Gregorini 96 6.3 Ottoboni’s Ephemeral Constructions 101 6.4 Alessandro Mauri 111 6.5 G.B. -

Plante DI ROMA DAL RINASCIMENTO AI CATASTI
CENTRO DI STUDI SULLA CULTURA E L'IMMAGINE DI ROMA d'intesa con ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI MlNTSTERO PER I BENI E LE ATTIVITA QjLTURALI • ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFICA cot patrocinio di CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ROMA PlANTE DI ROMA DAL RINASCIMENTO AI CATASTI a cura di MARIO BEVILACQLJA e MARCELLO FAGIOLO 00 Giovanni Battista Falda and Lievin Cruyl. Rivalry between Printmakers and Publishers in the Mapping of Rome JOSEPH CONNORS For years a reproduction of Falda's great map of 1676, in the Danesi to the work of Francesca Consagra on the De Rossi family. Her es- edition mounted on canvas, hung on my walls in successive homes sential studies unearthed in the archives much important informa- in Cambridge, Chicago, and New York. It was testimony to my tion on the economics of publishing and the importance of homesickness for the Urbs. Falda helped me walk in my imagination securing a papal privilege^. With this information in mind, it was through the streets of baroque Rome, "spatiando con gli occhi per possible to look with fresh eyes at the prints themselves, and the ri- tutte le vie, piazze, giardini, et contrade della Citta", as the pub- valry became more obvious than ever. Two different visions were lisher, Giovanni Giacomo De Rossi, says on the map. Now I know in competition, in the service of two different business models. A that I was not very original, and that many lovers of Rome have good publisher could offer a talented etcher fame and fortune, hung the Falda map on their walls. -

Rome Historic Trail ……………..…
Rome, Italy HISTORIC TRAIL ROME, ITALY TRANSATLANTICHISTORIC COUNCIL TRAIL How to Use This Guide This Field Guide contains information on the Rome Historical Trail designed by a members of the Transatlantic Council. The guide is intended to be a starting point in your endeavor to learn about the history of the sites on the trail. Remember, this may be the only time your Scouts visit Rome in their life so make it a great time! While TAC tries to update these Field Guides when possible, it may be several years before the next revision. If you have comments or suggestions, please send them to [email protected] or post them on the TAC Nation Facebook Group Page at https://www.facebook.com/groups/27951084309/. This guide can be printed as a 5½ x 4¼ inch pamphlet or read on a tablet or smart phone. Front Cover: Saint Peter’s Basilica in the Vatican City Front Cover Inset: Roman Coliseum ROME, ITALY 2 HISTORIC TRAIL Table of Contents Getting Prepared………………..…………4 What is the Historic Trail…….……… 5 Rome Historic Trail ……………..…. 6-24 Route Maps & Pictures……..….. 25-28 Quick Quiz……………………….……………29 B.S.A. Requirements………….…..…… 30 Notes……………………………..….………… 31 ROME, ITALY HISTORIC TRAIL 3 Getting Prepared Just like with any hike (or any activity in Scouting), the Historic Trail program starts with Being Prepared. 1. Review this Field Guide in detail. 2. Check local conditions and weather. 3. Study and Practice with the map and compass. 4. Pack rain gear and other weather-appropriate gear. 5. Take plenty of water. 6. Make sure socks and hiking shoes or boots fit correctly and are broken in. -
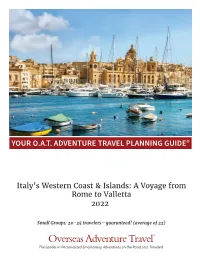
To View Online Click Here
YOUR O.A.T. ADVENTURE TRAVEL PLANNING GUIDE® Italy’s Western Coast & Islands: A Voyage from Rome to Valletta 2022 Small Groups: 20-25 travelers—guaranteed! (average of 22) Overseas Adventure Travel ® The Leader in Personalized Small Group Adventures on the Road Less Traveled 1 Dear Traveler, At last, the world is opening up again for curious travel lovers like you and me. And the O.A.T. Italy’s Western Coast & Islands: A Voyage from Rome to Valletta itinerary you’ve expressed interest in will be a wonderful way to resume the discoveries that bring us so much joy. You might soon be enjoying standout moments like these: I love to eat in Italy (who doesn’t?) and nothing compares to the fresh ingredients of the Aeolian Islands. You’ll see what I mean when you sit down with the owners of a small-scale caper farm for a farm-fresh lunch. First, you’ll spend A Day in the Life of this farm located on the island of Salina, where you’ll have a chance to get to know your hosts and come to learn the history of their farm. Then, you’ll learn about their organic and traditional farming practices during a stroll through their gardens followed by a savory lunch. After witnessing the beauty of Italy and its people, it saddens me to hear about darker chapters enmeshed in this vibrant culture. You’ll hear them, too, when you meet meet with survivor and advocate Francesco Zanardian to discuss how the Vatican and the Italian authorities have handled the Catholic Church’s sexual abuse scandal. -

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DI PESCARA A.A. 2010-11 CORSO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA II Prof
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DI PESCARA A.A. 2010-11 CORSO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA II Prof. Raffaele GIANNANTONIO PROGRAMMA DETTAGLIATO AGGIORNATO AL 17.11.2010 L’ARCHITETTURA DEL RINASCIMENTO Il quadro storico-politico. Le corti rinascimentali. La definizione del concetto. L’Umanesimo e la cultura del Rinascimento. La figura dell’architetto. La nuova concezione dell’arte. La prospettiva. La teoria delle proporzioni. L’ordine architettonico. La polemica contro il Gotico. Tipologia e metodo. Il rapporto con l’antico: la riscoperta di Vitruvio. Il sistema spaziale. I grandi temi: pianta centrale/longitudinale. La facciata. I grandi cantieri: la cupola di S. Maria del Fiore. L’ARCHITETTURA DEL QUATTROCENTO. FILIPPO BRUNELLESCHI: Concorso del 1401 per le formelle del Battistero di Firenze. Cupola di s. Maria del Fiore. Spedale degli Innocenti. Sacrestia “Vecchia” di s. Lorenzo. Cappella Pazzi. Tavole prospettiche. Chiesa di s. Lorenzo. Chiesa di s. Spirito. Gli edifici civili: palazzo Pitti; ampliamento del Palagio di Parte Guelfa. La pianta centrale: rotonda di s. Maria degli Angeli. LEON BATTISTA ALBERTI . L’esordio architettonico – Ferrara: arco del cavallo, campanile del Duomo. ROMA – IL PROGRAMMA DI NICCOLÒ V: Rassettamento delle mura urbane, degli acquedotti e dei ponti. Restauro delle 40 chiese “stazionali”. Restauro e ricostruzione del palazzo vaticano. Costruzione della basilica di s. Pietro. Costruzione del Borgo Vaticano. FIRENZE: le opere per Giovanni Rucellai: palazzo, loggia e cappella; facciata di s. Maria Novella . RIMINI E SIGISMONDO MALATESTA: Tempio Malatestiano . MANTOVA E LUDOVICO GONZAGA: s. Sebastiano, s. Andrea . UN’OPERA DEI GONZAGA A FIRENZE: tribuna dell’Annunziata. LA TOSCANA NEL QUATTROCENTO: LE CORRENTI POST-BRUNELLESCHIANE. -

Historic Trail
Rome, Italy HISTORIC TRAIL ROME, ITALY TRANSATLANTICHISTORIC COUNCIL TRAIL How to Use This Guide This Field Guide contains information on the Rome Historical Trail designed by a members of the Transatlantic Council. The guide is intended to be a starting point in your endeavor to learn about the history of the sites on the trail. Remember, this may be the only time your Scouts visit Rome in their life so make it a great time! While TAC tries to update these Field Guides when possible, it may be several years before the next revision. If you have comments or suggestions, please send them to [email protected] or post them on the TAC Nation Facebook Group Page at https://www.facebook.com/groups/27951084309/. This guide can be printed as a 5½ x 4¼ inch pamphlet or read on a tablet or smart phone. Front Cover: Saint Peter’s Basilica in the Vatican City Front Cover Inset: Roman Coliseum ROME, ITALY 2 HISTORIC TRAIL Table of Contents Getting Prepared………………..…………4 What is the Historic Trail…….……… 5 Rome Historic Trail ……………..…. 6-24 Route Maps & Pictures……..….. 25-28 Quick Quiz……………………….……………29 B.S.A. Requirements………….…..…… 30 Notes……………………………..….………… 31 ROME, ITALY HISTORIC TRAIL 3 Getting Prepared Just like with any hike (or any activity in Scouting), the Historic Trail program starts with Being Prepared. 1. Review this Field Guide in detail. 2. Check local conditions and weather. 3. Study and Practice with the map and compass. 4. Pack rain gear and other weather-appropriate gear. 5. Take plenty of water. 6. Make sure socks and hiking shoes or boots fit correctly and are broken in. -

Walking Tour and Visits of the Following Locations: A
The Digital Future of World Heritage A symposium on blended scholarship and management in the new millennium 2-4 April The University of Notre Dame in Rome Wednesday, 2 April 2014 9:00 pm-10:30 pm Walk 1 (Layers of Rome from antiquity to the Renaissance) 8:45 p.m. Group gathers in the lobby f Hotel Forum for transportation to Largo Argentina. 9:00p p.m. Walking tour and visits of the following locations: a. Santa Maria Sopra Minerva, Piazza Minerva The church of Santa Maria Sopra Minerva is an important church for the Dominicans, the Roman Catholic order of Preachers. The churches name derives from the fact that the first Christian church built on the site was built over the ruins of the temple dedicated to the Egyptian goddess Isis. It was thought for some time that the temple was dedicated to the Greco-Roman goddess Minerva. As a result Santa Maria Sopra Minerva literally means Saint Mary over Minerva. b. Pantheon, Piazza della Rotonda The Pantheon was originally commissioned by Marcus Agrippa during the reign of Augustus as a temple to all the gods of ancient Rome, and rebuilt by the emperor Hadrian about 126 AD. Almost two thousand years after it was built, the dome of the Pantheon, is still the world’s largest unreinforced concrete dome. The Pantheon has influenced the works of architects around the world and is one of the most copied works of architecture. c. Piazza Navona The distinct urban form of Piazza Navona derives from the fact that the piazza is situated on top of the Stadium of Domition, built in the 1st century AD. -

The Formal Kinship of Architecture and Urbanism: Design in the Italian Renaissance, Mannerism, and Baroque
RICE UNIVERSITY THE FORMAL KINSHIP OF ARCHITECTURE AND URBANISM: DESIGN IN THE ITALIAN RENAISSANCE, MANNERISM, AND BAROQUE by WILLIAM D. FAUGHT A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER IN ARCHITECTURE Houston, Texas May 1969 ABSTRACT The Formal Kinship of Architecture and Urbanism: Design in the Italian Renaissance/ Mannerism/ and Baroque. By William D. Faught This thesis investigates and defines the nature of the esthetic associated with historical styles in general, and examines in some detail the operation of an estheti upon the works of architecture and urbanism in each of the three periods which are its area of concern. Some historical background for each period is presented, the esthetic arising from those events is described, and specific architectural and urbanistic projects are examined which seem to be representation of the periods. The works of archi¬ tecture and urbanism will be seen to react in similar ways to changes in the Italian society. TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION Section A RENAISSANCE Section B I. Introduction B2 Events of the Times. * B2 The Renaissance Esthetic B6 II. The Renaissance Esthetic in Architecture... B12 Church Design ' £12 Palace Design £18 Function vs. Ideal Form in Renaissance Urbanism £20 III. The Renaissance Esthetic in Urbanism £24 The Ideal City - £24 Existing Italian Cities £26 Esthetic-will and Functional Need in Renaissance Urbanism £30 MANNERISM Section C I. Introduction • .C2 Events of the Times .C2 The Mannerist Esthetic .C6 II. The Mannerist Esthetic in Architecture • .CIO Andrea Palladio CIO Michelangelo C16 Projects by other Italian Mannerists .C20 III. Mannerist Urbanism C28 BAROQUE Section D I. -

The Urban Development of Rome in the Age of Alexander Vii / Dorothy Metzger Habel
P1: FHB 0521772648PRE 0521772648/Habel.cls May 14, 2002 12:23 THE URBAN DEVELOPMENT OF ROME IN THE AGE OF ALEXANDER VII Dorothy Metzger Habel University of Tennessee iii P1: FHB 0521772648PRE 0521772648/Habel.cls May 14, 2002 12:23 published by the press syndicate of the university of cambridge The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge, United Kingdom cambridge university press The Edinburgh Building, Cambridge cb2 2ru, uk 40 West 20th Street, New York, ny 10011-4211, usa 477 Williamstown Road, Port Melbourne, vic 3207, Australia Ruiz de Alarcon´ 13, 28014 Madrid, Spain Dock House, The Waterfront, Cape Town 8001, South Africa http://www.cambridge.org C Dorothy Metzger Habel 2002 This book is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. First published 2002 Printed in the United Kingdom at the University Press, Cambridge Typeface Adobe Garamond 11/13 pt. System LATEX 2ε [TB] A catalog record for this book is available from the British Library. Library of Congress Cataloging in Publication Data Metzger Habel, Dorothy, 1950– The urban development of Rome in the age of Alexander vii / Dorothy Metzger Habel. p. cm. Includes bibliographical references and index. isbn 0-521-77264-8 (hb) 1. City planning – Italy – Rome – History – 17th century. 2. Architecture, Baroque – Italy – Rome. 3. Architecture and state – Italy – Rome. 4. Alexander vii, Pope, 1599–1667. 5. Rome (Italy) – Buildings, structures, etc. i. Title. na9204.r7 m46 2002 711.40945632 – dc21 2001037675 isbn 0 521 77264 8 hardback iv P1: FHB 0521772648PRE 0521772648/Habel.cls May 14, 2002 12:23 CONTENTS List of Illustrations page ix Acknowledgments xvii List of Abbreviations xxi Introduction 1 1 Palazzo del Quirinale: “In Stato di Regia Magnificenza” 11 2 Piazza del Popolo and the Genesis of Alexander VII’s Program for Via del Corso 63 3 Piazza S.