Studio Di Fattibilita' Del Parco Smeraldo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ottobre 2020
NUMERO 07 ALFANotizie Notiziario delle principali attività svolte da Alfa S.r.l. per tipologia di servizio OTTOBRE 2020 Acquedotto ALFANotizie Acquedotto! 04 Attività La gestione dell’acquedotto è passata ad Alfa. Comuni interessati: Agra Dumenza Brissago Valtravaglia Ferrera di Varese Brusimpiano Montegrino Valtravaglia Cassano Valcuvia Porto Ceresio Castelveccana Rancio Valcuvia Curiglia Monteviasco Tronzano Lago Maggiore ALFANotizie Acquedotto! 05 Attività Interventi d’urgenza per il ripristino della fornitura a seguito delle interruzioni d’energia elettrica causate dal maltempo. Comuni interessati: Agra Gavirate Angera Gemonio Besozzo Laveno Mombello Casale Litta Mesenzana Cittiglio Saltrio Cuveglio Taino Duno ALFANotizie Acquedotto! 06 Attività Installazione di un nuovo avviatore, collegamento di nuove pompe e rifacimento del piping al rilancio Brusnago. Comune interessato: Azzio Rilancio Brusnago ALFANotizie Acquedotto! 07 Attività • Effettuato cambio carboni al pozzo Samarate. • Installate pompette di dosaggio del cloro per la disinfezione in tutti gli impianti. Comune interessato: Busto Arsizio ALFANotizie Acquedotto! 08 Attività Installazione di inverter resettabili da remoto al pozzo Firello 1 di Casale Litta. Comune interessato: Casale Litta Casale Litta Firello 1 Reset da remoto ALFANotizie Acquedotto! 09 Attività Installazione d’urgenza di una pompa di rilancio al serbatoio Menasi per far fronte a carenze idriche. Quest’ultima permette di supportare l’apporto sorgivo al serbatoio Martinello. Comune interessato: Castello Cabiaglio Serbatoio Menasi ALFANotizie Acquedotto! 10 Attività Sostituzione pressostati guasti e azionatore di potenza pompa 2 all’autoclave Vallè. Comune interessato: Gemonio Autoclave Vallè ALFANotizie Acquedotto! 11 Attività Installazione di pompette dosatrici del cloro al serbatoio Mondizza di Grantola. Comune Attività interessato: Installazione di un nuovo impianto di clorazione Grantola presso i pozzi S. -

NABA CALL for the ASSIGNMENT of FINANCIAL AID (DIRITTO ALLO STUDIO) BENEFITS Academic Year 2020/2021 – ACADEMIC YEAR 2020/2021
NABA CALL FOR THE ASSIGNMENT OF FINANCIAL AID (DIRITTO ALLO STUDIO) BENEFITS Academic Year 2020/2021 – ACADEMIC YEAR 2020/2021 Milan, 21st July 2020 – Prot. Nr. 46/2020 (TRANSLATION OF THE DSU NABA APPLICATION REQUIREMENTS AND REGULATIONS In case of discrepancies between the Italian text and the English translation, the Italian version prevails) CONTENTS 1) NABA SERVICES IMPLEMENTING THE RIGHT TO UNIVERSITY EDUCATION 3 2) ALLOCATION OF SCHOLARSHIPS 3 2.1) STRUCTURE AND NUMBER OF SCHOLARSHIPS 4 2.2) GENERAL TERMS AND CONDITIONS 5 2.3) SCHOLARSHIP ALLOCATION CLASSIFICATION LIST ADMITTANCE REQUIREMENTS 6 2.3.1) MERIT-BASED REQUIREMENTS 6 2.3.2) INCOME-BASED REQUIREMENTS 9 2.3.3) ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STATUS AND ASSETS OF FOREIGN STUDENTS 9 2.4) SCHOLARSHIP TOTAL AMOUNTS 10 3) SCHOLARSHIP FINANCIAL SUPPLEMENTS 12 12 3.1) STUDENTS WITH DISABILITIES 3.2) INTERNATIONAL MOBILITY 12 4) DRAWING UP OF CLASSIFICATION LISTS 13 5) APPLICATION SUBMISSION TERMS AND CONDITIONS 14 6) PUBLICATION OF PROVISIONAL CLASSIFICATION LISTS AND SUBMISSION OF APPEALS 15 6.1) INCLUSION OF STUDENTS IN THE CLASSIFICATION LISTS 15 6.2) PUBLICATION OF THE CLASSIFICATION LISTS AND SUBMISSION OF APPEALS 16 7) TERMS OF SCHOLARSHIP PAYMENTS 16 8) INCOMPATIBILITY – FORFEITURE – REVOCATION 18 9) TRANSFERS AND CHANGES OF FACULTY 18 10) FINANCIAL STATUS ASSESSMENTS 19 11) INFORMATION NOTE ON THE USE OF PERSONAL DATA AND ON THE RIGHTS OF THE DECLARANT 19 ANNEX A - LIST OF COUNTRIES RELATING TO THE LEGALISATION OF DOCUMENTS 22 ANNEX B – LIST OF MUNICIPALITIES RELATING TO THE DEFINITION OF COMMUTING STUDENTS 28 Financial Assistance Selection Process - A.Y. -

CV Segretario Comunale Dott. Michele Panariello
Curriculum Vitae Europass Informazioni personali Nome(i) / Cognome(i) Michele Panariello Domicilio c/o Comune di Gornate Olona, Piazza Parrocchetti n.1 Telefono(i) 0331-863823/28 E-mail [email protected] E-mail personale [email protected] Cittadinanza Italiana Settore professionale Giuridico Legale Conseguimento abilitazione forense presso Tribunale di Napoli Conseguimento idoneità professionale, ai fini dell’iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale (corso-concorso). Iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali. 1 Esperienza professionale Date 01.10.2014 – attualmente Lavoro o posizione ricoperti Segretario Comunale della sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Gornate Olona (capofila) e Nome e indirizzo del datore di lavoro di Castronno (VA). 01 Novembre 2012-30.09.2014 Segretario Comunale della sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Gornate Olona (capofila), Tronzano Lago Maggiore ed Agra (VA). Ottobre 2013-Febbraio 2014 Partecipazione Corso di specializzazione ex art. 14, comma 1, D.P.R. n. 465/97, denominato “Spe.S” edizione 2013. Luglio 2014 Componente, in qualità di Membro esperto, della commissione di gara per affidamento del servizio di tesoreria comunale presso i Comuni di Dumenza (VA) e di Brissago Valtravaglia (VA). Gennaio 2013 Componente, in qualità di membro esperto esterno, della commissione giudicatrice del concorso per l’assunzione di n. 1 dipendente a tempo indeterminato e parziale (25 ore) di un istruttore amministrativo presso la Comunità Montana del Piambello (VA). 01 Agosto 2011- 30 Ottobre 2012 Segretario Comunale della sede convenzionata di Segreteria tra i Comuni di Castelveccana (capofila), Tronzano Lago Maggiore, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore ed Agra (VA). -

Voglio Fare Il Volontario Di Protezione Civile…
VOGLIO FARE IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE….. DEVO FARE UNA SCELTA IMPORTANTE….. 1 IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE DEVE DISPORRE DI UNA: COMPONENTE UMANA; COMPONENTE TECNICA. TENACIA TEMPO DEDIZIONE CORAGGIO CUORE PROFESSIONALITA’ PASSIONE RISPETTO DEI RUOLI LAVORO DIDI SQUADRA 2 COSA SARETE CHIAMATI A FARE………… COME DIVENTO VOLONTARIO DI PC? “REGOLE D’INGAGGIO”: ESSERE MAGGIORENNI; NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI PER REATI DOLOSI CONTRO LE PERSONE O IL PATRIMONIO; 3 COME DIVENTO VOLONTARIO DI PC? “REGOLE D’INGAGGIO”: DEVO ESSERE ISCRITTO AD UN ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. GRUPPI COMUNALI ASSOCIAZIONI Organizzazioni Organizzazioni private, pubbliche e dipendono con un proprio statuto, direttamente dal presidente e consiglio Sindaco. direttivo. 4 GRUPPI COMUNALI ALBIZZATE CADEGLIANO VICONAGO ANGERA CAIRATE ARCISATE CANTELLO AZZIO CARDANO AL CAMPO BARDELLO CARNAGO BESNATE CARONNO PERTUSELLA BIANDRONNO CARONNO VARESINO BRENTA CASALE LITTA BRUNELLO CASALZUIGNO BUGUGGIATE CASORATE SEMPIONE GRUPPI COMUNALI CASSANO VALCUVIA CROSIO DELLA VALLE CASTELLANZA CUASSO AL MONTE CASTELLO CABIAGLIO CUGLIATE FABIASCO CASTELSEPRIO CUNARDO CASTIGLIONE OLONA CUVEGLIO CAZZAGO BRABBIA CUVIO CISLAGO DAVERIO CITTIGLIO DUNO COCQUIO TREVISAGO FAGNANO OLONA CREMENAGA FERRERA 5 GRUPPI COMUNALI GALLIATE LOMBARDO INDUNO OLONA GAVIRATE ISPRA GAZZADA SCHIANNO LAVENA PONTE TRESA GEMONIO LAVENO MOMBELLO GERENZANO LEGGIUNO GORLA MAGGIORE LONATE CEPPINO -

COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (VA) (SCADENZA: 19 GENNAIO 2018) Avviso Di Selezione Esplorativo Per La Copertura Di N
Newsletter n° 32/2017 CONCORSI IN PROVINCIA DI VARESE, COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, MILANO, NOVARA E VERBANIA 22 DICEMBRE 2017 A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI IL MONASTERO DI TORBA, COMUNE DI GORNATE OLONA (VA) AVVISI DI MOBILITÀ/CONCORSI SEGNALATI DIRETTAMENTE DAGLI ENTI COMUNE DI OLGIATE OLONA (VA) (SCADENZA: 12 GENNAIO 2018) Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia Locale” - Cat. C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Settore Comando Polizia Locale. (clicca qui per accedere al bando) COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (VA) (SCADENZA: 19 GENNAIO 2018) Avviso di selezione esplorativo per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato – Cat. C1 giuridica – inquadramento economico massimo C3 da inserire nell’”Area Segreteria/Affari Generali” da assumere mediante procedura di mobilità esterna. (clicca qui per accedere al bando) COMUNE DI PORTO CERESIO (VA) (SCADENZA: 20 GENNAIO 2018) Avviso esplorativo di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” – Cat. giuridica D – economica non superiore a D3, con attribuzione di incarico di Posizione Organizzativa, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Settore Tecnico. (clicca qui per accedere al bando) COMUNE DI TAINO (VA) (SCADENZA: 22 GENNAIO 2018) Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Contabile” – Cat. C1, a tempo pieno (36 ore) ed indeterminato, da destinarsi al Settore Finanziario e Tributi. (clicca qui per accedere al bando) COMUNE DI GORLA MINORE (VA) (SCADENZA: 24 GENNAIO 2018) Avviso esperimento procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. -

Allegato “A” Disposizioni Relative Alla Caccia Di Selezione Alla Specie Cinghiale Nell’Ambito Territoriale Di Caccia N
ALLEGATO “A” DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CACCIA DI SELEZIONE ALLA SPECIE CINGHIALE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1 (ATC 1) , N 2 (ATC2) E COMPRENSORIO ALPINO NORD VERBANO (CANV) STAGIONE VENATORIA 2020/2021 (Legge n. 157/92, L.R. n. 26/93 e s.m.i., L.R. n. 31/2008 e L.R. n.17 del 02.08.2004) Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 157/92, dalla L.R. n. 26/93 e s.m.i., in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, dalla L.R. n. 17 del 2 agosto 2004 - Attività venatoria in zona alpi - dalle D.G.R. n. 5/54912 del 19.07.1994 e n. 7/13854 del 29/07/2003 - Istituzione, organizzazione e funzionamento degli Ambiti Territoriali e Comprensori Alpini di Caccia - dal R.R. n. 16/2003, dalla LR. 19/2017, dal Regolamento Provinciale per la caccia agli ungulati (D.C.P. n. 28 del 23.06.2009 e s.m.i.), ove non in contrasto con la successiva normativa in materia di caccia dalla DGR XI/1019 del 17/12/2018 e s.m.i. “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - attuazione dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 “gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” e dalle norme sanitarie, sono approvate le seguenti disposizioni per la Stagione Venatoria 2019/2020, relative alla caccia di selezione alla specie cinghiale. Documentazione necessaria per praticare la caccia nel territorio della provincia di Varese Il cacciatore dovrà essere munito del tesserino venatorio regionale rilasciato dalla Regione, Uffici Territoriali, della licenza di caccia in corso di validità corredata dei versamenti della tassa di concessione governativa e regionale, della ricevuta del pagamento dell’assicurazione personale; dovrà inoltre essere munito del contrassegno di riconoscimento rilasciato dal Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia. -
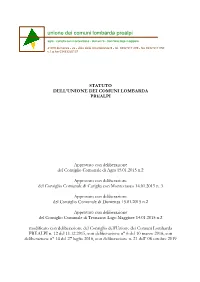
Unione Dei Comuni Lombarda Prealpi
unione dei comuni lombarda prealpi agra - curiglia con monteviasco - dumenza - tronzano lago maggiore 21010 dumenza - va - viale delle rimembranze 9 - tel. 0332 517 239 - fax 0332 517 050 c.f. p.iva 03483320127 STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Agra 15.01.2015 n.2 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Curiglia con Monteviasco 14.01.2015 n. 3 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Dumenza 15.01.2015 n.2 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Tronzano Lago Maggiore 14.01.2015 n.2 modificato con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Lombarda PREALPI n. 12 del 11.12.2015, con deliberazione n° 6 del 10 marzo 2016, con deliberazione n° 14 del 27 luglio 2016, con deliberazione n. 21 dell’ 08 ottobre 2019 Sommario Titolo I – Elementi costitutivi Articolo 1 – Principi fondamentali Articolo 2 – Finalità e funzioni Articolo 3 – Sede e stemma dell’Unione Articolo 4 – Durata e scioglimento dell’Unione Articolo 5 – Recesso Titolo II – Ordinamento Strutturale Articolo 6 – Organi dell’Unione Articolo 7 – Assemblea Articolo 8 – Deliberazioni degli organi collegiali Articolo 9 – Competenze dell’Assemblea Articolo 10 – Convocazione dell’Assemblea Articolo 11 – Validità delle sedute e delle deliberazioni dell’Assemblea Articolo 12 – Funzionamento dell’Assemblea Articolo 13 – Richiesta di convocazione Articolo 14 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell’Assemblea Articolo 15 – Dimissione, decadenza e sostituzione -

CITTA' CAP Milano 20121
CITTA' CAP Milano 20121 Milano 20122 Milano 20123 Milano 20124 Milano 20125 Milano 20126 Milano 20127 Milano 20128 Milano 20129 Milano 20131 Milano 20132 Milano 20133 Milano 20134 Milano 20135 Milano 20136 Milano 20137 Milano 20138 Milano 20139 Milano 20141 Milano 20142 Milano 20143 Milano 20144 Milano 20145 Milano 20146 Milano 20147 Milano 20148 Milano 20149 Milano 20151 Milano 20152 Milano 20153 Milano 20154 Milano 20155 Milano 20156 Milano 20157 Milano 20158 Milano 20159 Milano 20161 Milano 20162 Arluno, Bernate Ticino, Buscate, Casorezzo, Inveruno, Mesero, Pogliano Milanese, San Giorgio su Legnano, Vanzago, Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Canegrate, Cornaredo, Marcallo con 20010 Casone, Ossona, Pregnana Milanese, Santo Stefano Ticino, Vittuone Corbetta 20011 Cuggiono 20012 Magenta 20013 Nerviano 20014 Parabiago 20015 Pero 20016 Rho 20017 Sedriano 20018 Settimo Milanese 20019 Arconate, Arese, Busto Garolfo, Cesate, Dairago, Lainate, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Solaro, Vanzaghello, 20020 Villa Cortese, Baranzate, Bollate 20021 Castano Primo 20022 Cerro Maggiore 20023 Garbagnate Milanese 20024 Novate Milanese 20026 Rescaldina 20027 San Vittore Olona 20028 Turbigo 20029 Senago 20030 Cormano 20032 Paderno Dugnano 20037 Cambiago 20040 Grezzago 20056 Basiano, Bellinzago Lombardo, Bussero, Cassina de' Pecchi, Colturano, Gessate, Liscate, Masate, Mediglia, Pessano con 20060 Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Trezzano Rosa, Truccazzano, Vignate Carugate 20061 Cassano d'Adda 20062 Cernusco sul Naviglio 20063 Gorgonzola -

C08 RELAZIONE Pdr.Pdf
Ing. Franco Luraschi Arch. Donatella Cattaneo Arch. Francesca Porfiri Avv. Diego Granata Resp. VAS Ing. Stefano Franco R P E I A L A N Z O I O 1 1 6 8 . 0 1 N D 5 2 . 2 2 E 0 0 1 1 E 4 3 L L E R E G C 0 1 O 1 1 2 0 4 9 0 2 L 0 1 E 4 8 Piano di Governo del Territorio - Comune di Venegono Superiore – C08 Relazione Piano delle Regole INDICE C08.0 INTRODUZIONE pag. 1 C08.0.1 IL PIANO DELLE REGOLE pag. 1 C08.0.2 ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE pag. 1 C08.1 LA QUALITA’ pag. 2 C08.1.1 OBIETTIVI DI QUALITA’ DEL PIANO pag. 2 C08.1.2 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DEL PIANO pag. 3 C08.2 IL SISTEMA URBANO E IL SISTEMA NATURALE pag. 5 C08.2.1 SVILUPPO DEL TERRITORIO pag. 5 C08.2.2 I NUCLEI ANTICHI pag. 8 C08.2.3 IL TERRITORIO COMUNALE pag. 9 C08.2.4 IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO pag. 12 C08.2.5 IL SISTEMA NATURALE (RURALE - PAESISTICO - pag. 14 AMBIENTALE) C08.2.6 PIANI DI SETTORE pag. 18 C08.2.7 SISTEMA VINCOLISTICO pag. 24 i n g. F r a n c o L u r a s c h i a r c h. D o n a t e l l a C a t t a n e o a r c h. F r a n c e s c a P o r f i r i a v v. -

121 Km , 1854 M D+, 26 Muur Varese Van Vlaanderen 2016
Varese Van Vlaanderen 2016 121 Km , 1854 m D+, 26 muur MEDIA (Km/h) MEDIA (Km/h) km PARZ 33,0 15,0 DIR. LOCALITA' INDICAZIONI NOTE - - 9:00 10:00 PARTENZA ALLA FRANCESE TRA LE ORE 9:00 E LE ORE 10:00 CARDANO AL CAMPO Le Biolle Sporting 0,2 0,2 9:00 10:00 Cardano al Campo via Carreggia 1,0 0,8 9:01 10:04 Cardano al Campo via al Parco 1,2 0,2 9:02 10:04 Cardano al Campo via Mameli diventa Gerolamo da Cardano 1,6 0,4 9:02 10:06 Cardano al Campo via Napoleone Ruberto 1,8 0,2 9:03 10:07 Cardano al Campo via del Moncone 2,1 0,3 9:03 10:08 Cardano al Campo via del Moncone 2,3 0,2 9:04 10:09 Cardano al Campo via del Moncone 2,4 0,1 9:04 10:09 Cardano al Campo via per Castelnovate 2,5 0,1 9:04 10:10 Gallarate via Sebastiano De Albertis attraversamento 2,6 0,1 9:04 10:10 Gallarate via Sebastiano De Albertis scuole 2,8 0,2 9:05 10:11 Gallarate via Largo Pinetti Castelletti tennis club 2,9 0,1 9:05 10:11 Gallarate via Padre Igino Lega 3,1 0,2 9:05 10:12 Gallarate via Solferino 3,6 0,5 9:06 10:14 Gallarate via Corso Sempione 3,7 0,1 9:06 10:14 Gallarate via Corso Sempione 4,2 0,5 9:07 10:16 Gallarate via Felice Cavallotti 4,6 0,4 9:08 10:18 Gallarate via Giosuè Carducci 4,7 0,1 9:08 10:18 Gallarate via Cinque Giornate 4,9 0,2 9:08 10:19 Gallarate Viale dei Tigli 5,4 0,5 9:09 10:21 Gallarate inizio salita via Gerolamo Nascinbene / Lindenberg -26 MUUR 5,9 0,5 9:10 10:23 Crenna Piazza Chiesa San Zenone 6,0 0,1 9:10 10:24 Crenna via Giovanni Locarno 6,2 0,2 9:11 10:24 Crenna via Del Lavoro discesa 6,5 0,3 9:11 10:26 Crenna via Campo dei Fiori 6,6 - 9:12 10:26 Crenna via Monte Nevoso attenzione doppia svolta SX 6,9 0,3 9:12 10:27 Crenna inizio salita via Piero Giobetti / Goebetmuur -25 MUUR 7,2 0,3 9:13 10:28 sv. -

Esito Test Di Posizionamento Seconda Edizione
Esito Test di Posizionamento Seconda Edizione Cognome Nome Scuola Livello Addazio Lucia VAIC81900A IST.COMP. DI VIGGIU' M. LONGHI - VIGGIU' B1 Anatra Sarina VAIC86800G IC GAVIRATE CARDUCCI - GAVIRATE A1 Arreghini Emanuela VAPS03000P L. SCIENT. "G. FERRARIS" - VARESE - VARESE A2 Assenza Costanza VAIS008004 ISIS ANDREA PONTI - GALLARATE B2 Astori Marvi VAIC86800G IC GAVIRATE CARDUCCI - GAVIRATE A2 Avanzato Valentina VAIC87400V I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI" - VARESE C1 Barbieri Maria Vittoria VAPC020001 ERNESTO CAIROLI - VARESE - VARESE B1 Beverina Luciana VAIC822006 I.C. MARCHIROLO GIOVANNI XXIII - MARCHIROLO ASS Bianchi Nadia VAPS03000P L. SCIENT. "G. FERRARIS" - VARESE - VARESE B1 Bisignano Lucia VAIC822006 I.C. MARCHIROLO GIOVANNI XXIII - MARCHIROLO C1 Bizzaro Marzia VAIS01100X "DON MILANI" - TRADATE B2 Bizzotto Debora VAIC87100B IC VARESE 4 "A.FRANK " - VARESE B1 Borrelli Anna VAIC83700X I.C.CASTRONNO E.DE AMICIS - CASTRONNO A2 Bosoni Elisabetta VAIC830005 I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI - CUVEGLIO B1 Bottin Roberta VAIS01700V ISAAC NEWTON - VARESE B1 Brunelli Veronica VAIC822006 I.C. MARCHIROLO GIOVANNI XXIII - MARCHIROLO A2 Candelmo Maria Giovanna VAIC831001 I.C. MALNATE "IQBAL MASIH" - MALNATE ASS Cannataro Vincenzo VAIS008004 - ISIS ANDREA PONTI A1 Capoccia Dante VAIS008004 - ISIS ANDREA PONTI ASS Cappelli Marinella VAIS00400R IS VALCERESIO - BISUSCHIO B1 Caruso Laura VAIC86900B IC VARESE 1 "DON RIMOLDI" - VARESE A2 Casti Maria VAIC86800G IC GAVIRATE CARDUCCI - GAVIRATE ASS Cavalleri Alberta VAIC827009 I.C. GEMONIO "E. CURTI" - GEMONIO A2 Chinelli Paola VAIC830005 I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI - CUVEGLIO A0 Chirichiello Gerardo VAIC82500N I.C. MESENZANA "D. ZURETTI" - MESENZANA A0 Cipolla Cristina VASL01000A L. ART. "CANDIANI" - BUSTO ARSIZIO - BUSTO ARSIZIO B1 Cocchi Francesco VAIS01800P "JOHN M. KEYNES" - GAZZADA SCHIANNO ASS Cocquio Raffaella VAIC83200R I.C. -

Arriva L'ecocard
Piattaforma ecologica Piattaforma ecologica DICEMBRE 2007 di Maccagno di Porto Valtravaglia Arriva l’ECOCARD LA TESSERA MAGNETICA PER ACCEDERE ALLE PIATTAFORME ECOLOGICHE DI via Reschigna località Trigo DUMENZA, LUINO, MACCAGNO E PORTOVALTRAVAGLIA GIORNI ED ORARIO DI APERTURA - Stampato su carta- Stampato riciclata – Lunedì 9.00/12.00 - 14.00/17.30 Martedì 9.00/12.00 - 14.00/17.30 Giovedì 9.00/12.00 - 14.00/17.30 Design [1] Anonima Grafica Grafica - Venerdì 9.00/12.00* - 14.00/17.30 GIORNI ED ORARIO DI APERTURA Sabato 9.00/12.00 - 14.00/17.30 * solo utenze commerciali/produttive Lunedì 9.00/12.00 Mercoledì 9.00/12.00 - 14.00/17.30 Sabato 9.00/12.00 - 14.00/17.30 (MI) 4 · 20020 Solaro Cellini, Via , Airone ServiziAirone srl Concept Concept Gentile Cittadino, spettabile ditta, con la presente si consegna la tessera magnetica personalizzata che dovrà essere utilizzata ogni qualvolta sarà necessario accedere alle piattaforme ecologiche di INDICAZIONI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDICAZIONI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI Dumenza, Luino, Maccagno e Porto VEGETALI: le ramaglie vanno allestite in fascine e i rami di grossa dimensione devono essere tagliati a pezzi. VEGETALI: le ramaglie vanno allestite in fascine e i rami di grossa dimensione devono essere tagliati a pezzi. Valtravaglia. INGOMBRANTI: vanno ridotti di volume e separati per tipologia di materiale (ferro, legno, plastica ecc.) INGOMBRANTI: vanno ridotti di volume e separati per tipologia di materiale (ferro, legno, plastica ecc.) L’introduzione della tessera magnetica consentirà di disciplinare al meglio il LEGNO: i mobili in legno vanno smontati e separati dalle parti in metallo e in plastica.