Innescare Il Cambiamento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
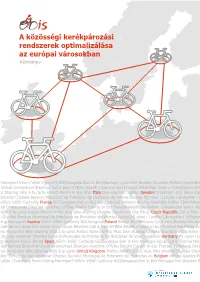
Optimising Bike Sharing in European Cities by OBIS Consortium © OBIS, 2011
A közösségi kerékpározási rendszerek optimalizálása az európai városokban Kézikönyv Sevici Bicing Homeport Vélo'v Vélib' Cyclocity BiZiZaragoza Bari in Bici Barclays Cycle Hire Bicimia Hourbike Réflex Chemnitzer Stadtfahr- rad Bicincittà Velodi Greenstreet BikeOne Call a Bike OYBike BikeMi C'entro in bici Freiradl VéloMagg Örebro Cykelstaden Vélo+ Nbici Punto Bici Bike Sharing Vélo à la carte Ambici Rimini in Bici Atac Italy bike sharing Citybike Sweden Stockholm City Bikes Call a Bike Ter- lizzi by bike Ambiciat Citybike Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas de Vitoria-Gasteiz På cykel i Lundby Lånecyklar i Göteborg Sevici Bicing Vélo'v Vélib' Cyclocity France BiZiZaragoza Bari in Bici Noleggio bici Bolzano Bicimia Hourbike Réflex Chemnitzer Stadtfahrrad Bicincittà Velodi Greenstreet BikeOne nextbike OYBike BikeMi C'entro in bici Freiradl VéloMagg Örebro Cykelstaden Vélo+ Nbici Punto Bici Bike Sharing Vélo à la carte Ambici Rimini in Bici Atac bike sharing Citybike Stockholm City Bikes Czech Republic Call a Bike Terlizzi by bike Ambiciat Citybike Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas de Vitoria-Gasteiz På cykel i Lundby Lånecyklar i Göteborg Sevici FREIRADL Bicing Homeport Austria Vélo'v Vélib' Cyclocity BiZiZaragoza Poland Bari in Bici Barclays Cycle Hire Bicimia Hourbike Réflex Chemnitzer Stadtfahrrad Bicincittà Velodi Greenstreet BikeOne Call a Bike OYBike BikeMi C'entro in bici Freiradl VéloMagg Örebro Cykelsta- den Vélo+ Nbici Punto Bici Bike Sharing Vélo à la carte Ambici Rimini in Bici Atac bike sharing Citybike -
![[Title Over Two Lines (Shift+Enter to Break Line)]](https://docslib.b-cdn.net/cover/4038/title-over-two-lines-shift-enter-to-break-line-134038.webp)
[Title Over Two Lines (Shift+Enter to Break Line)]
BUS TRANSFORMATION PROJECT White Paper #2: Strategic Considerations October 2018 DRAFT: For discussion purposes 1 1 I• Purpose of White Paper II• Vision & goals for bus as voiced by stakeholders III• Key definitions IV• Strategic considerations Table of V• Deep-dive chapters to support each strategic consideration Contents 1. What is the role of Buses in the region? 2. Level of regional commitment to speeding up Buses? 3. Regional governance / delivery model for bus? 4. What business should Metrobus be in? 5. What services should Metrobus operate? 6. How should Metrobus operate? VI• Appendix: Elasticity of demand for bus 2 DRAFT: For discussion purposes I. Purpose of White Paper 3 DRAFT: For discussion purposes Purpose of White Paper 1. Present a set of strategic 2. Provide supporting analyses 3. Enable the Executive considerations for regional relevant to each consideration Steering Committee (ESC) to bus transformation in a neutral manner set a strategic direction for bus in the region 4 DRAFT: For discussion purposes This paper is a thought piece; it is intended to serve as a starting point for discussion and a means to frame the ensuing debate 1. Present a The strategic considerations in this paper are not an set of strategic exhaustive list of all decisions to be made during this considerations process; they are a set of high-level choices for the Bus Transformation Project to consider at this phase of for regional strategy development bus transformation Decisions on each of these considerations will require trade-offs to be continually assessed throughout this effort 5 DRAFT: For discussion purposes Each strategic consideration in the paper is 2. -

Public Bicycle Schemes
Division 44 Water, Energy and Transport Recommended Reading and Links on Public Bicycle Schemes September 2010 Reading List on Public Bicycle Schemes Preface Various cities around the world are trying methods to encourage bicycling as a sustainable transport mode. Among those methods in encouraging cycling implementing public bicycle schemes is one. The public bicycle schemes are also known as bicycle sharing systems, community bicycling schemes etc., The main idea of a public bicycle system is that the user need not own a bicycle but still gain the advantages of bicycling by renting a bicycle provided by the scheme for a nominal fee or for free of charge (as in some cities). Most of these schemes enable people to realize one way trips, because the users needn’t to return the bicycles to the origin, which will avoid unnecessary travel. Public bicycle schemes provide not only convenience for trips in the communities, they can also be a good addition to the public transport system. Encouraging public bike systems have shown that there can be numerous short that could be made by a bicycle instead of using motorised modes. Public bike schemes also encourage creative designs in bikes and also in the operational mechanisms. The current document is one of the several efforts of GTZ-Sustainable Urban Transport Project to bring to the policymakers an easy to access list of available material on Public Bike Schemes (PBS) which can be used in their everyday work. The document aims to list out some influential and informative resources that highlight the importance of PBS in cities and how the existing situation could be improved. -

MOBY - Living Lab E-Micromobility
Activity Deliverable MOBY - Living lab e-micromobility Description of business models EIT Urban Mobility - Mobility for more liveable urban spaces EIT Urban Mobility Stockholm | 2020-10-09 eiturbanmobility.eu Reporting year 2020 Activity code 20034 Deliverable No. DEL04 Deliverable title Description of business models Document information Author(s) and contributing partner(s) - if any Name Organization Contribution Mats Engwall KTH Royal Institute of Qualitative business model analysis Technology for Stockholm Frida Borin KTH Royal Institute of Qualitative business model analysis Technology for Stockholm Gyözö Gidofalvi KTH Royal Institute of Quantitative business modelling Technology analysis Coordination Elina Merdymshaeva KTH Royal Institute of Quantitative business modelling Technology analysis Amnon Frenkel Technion - Israel Institute of Qualitative business model analysis Technology for Tel-Aviv Clement Lemardelé UPC Technology Center Qualitative business model analysis for Barcelona Quantitative business modelling analysis Mireia Gilibert Junyent Seat SA Qualitative business model analysis for Barcelona and Madrid Sebastian Pretzsch Fraunhofer Society for the Qualitative business model analysis Advancement of Applied for Munich Research 1 Contents Document information ................................................................................................................................. 1 1. Executive Summary ................................................................................................................................ -

Public Bicycles
New Seamless Mobility Services Public Bicycles 4 PolicyPliocyoeslli y notes t NICHES is a Coordination Action funded by the European Commission under the Sixth Framework Programme for R&D, Priority 6.2 Sustainable Surface Transport What is it about? Characteristics Public Bicycles: • are innovative schemes of rental or free bicycles in urban areas; Example: Vélo’v in Lyon • can be used for daily mobility as one-way-use is possible and they can be seen as part of the public How did the French City of Lyon transport system; encourage thousands of people to • differ from traditional, mostly leisure-oriented bicycle use the bicycle as urban transport rental services as they provide fast and easy access; mode within a few months? • have diversifi ed in organisational layout, the business A big part of this success story is models and the applied technology towards “smart bikes” due to the introduction of the (rental process via smart card or mobile phone). Public Bicycle scheme vélo’v. Each of the 2,000 bicycles available The transferability of Public Bicycle schemes to cities at racks throughout the city centre with appropriate framework conditions for cycling has is used on average 16 times on a been proven in many cases (e.g. in France, Germany, typical summer day. Within the Scandinavia and Spain). fi rst six months after its introduction, 2 Million trips were made with the Public Bicycles, Key benefi ts replacing around 150,000 car trips. In combination with the The implementation of a Public Bicycle scheme... increased use of private bicycles, • provides a fast, convenient and fl exible inner urban the scheme helped to increase the transport option; bicycle share in the modal split. -

Vergelijkende Studie Van Stedelijke Fietsverhuursystemen
Academiejaar 2009 – 2010 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Vergelijkende studie van stedelijke fietsverhuursystemen Jeroen Jonckheere Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Master in de Toegepaste Economische Promotor: Wetenschappen logistiek en transport Prof. dr. Ann Verhetsel Academiejaar 2009 – 2010 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Vergelijkende studie van stedelijke fietsverhuursystemen Jeroen Jonckheere Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Master in de Toegepaste Economische Promotor: Wetenschappen logistiek en transport Prof. dr. Ann Verhetsel Voorwoord Een masterproef schrijven is een proces dat ongeveer een jaar duurt. In de loop van dit jaar krijg je hulp van een heleboel mensen. Ik wil dan ook gebruik maken van dit voorwoord om deze mensen te bedanken. De eerste persoon die ik wens te bedanken is professor Ann Verhetsel. Als promotor van mijn masterproef verbeterde zij op gepaste tijden mijn schrijfsels en gaf ze een aantal nuttige adviezen waarmee ik verder aan de slag kon. In tweede instantie zou ik ook Jan Schaeken van het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen willen danken voor het geven van alle informatie die ik nodig had om het Antwerpse stedelijk fietsverhuursysteem te vergelijken met de al bestaande fietsverhuursystemen. In laatste instantie wil ik ook mijn ouders bedanken. Zij hebben er voor gezorgd dat ik 4 jaar lang heb kunnen studeren. Daarnaast wil ik hen ook nog bedanken voor het nalezen -
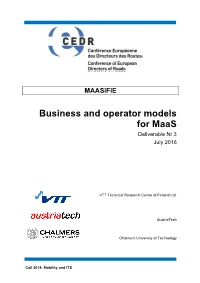
Deliverable 3: Business and Operator Models for Maas. Maasifie Project Funded by CEDR
MAASiFiE Business and operator models for MaaS Deliverable Nr 3 July 2016 VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. AustriaTech Chalmers University of Technology Call 2014: Mobility and ITS Call 2014: Mobility and ITS Project Nr. 850704 Project acronym: MAASiFiE Project title: Mobility As A Service For Linking Europe MAASiFiE Deliverable Nr 3 – Business and operator models for MaaS Due date of deliverable: 31.07.2016 Actual submission date: 29.07.2016 Revised submission date: 22.09.2016 Start date of project: 01.06.2015 End date of project: 31.05.2017 Authors of this deliverable: David König, AustriaTech, Austria Jenni Eckhardt, VTT, Finland Aki Aapaoja, VTT, Finland Jana Sochor, Chalmers University of Technology, Sweden MariAnne Karlsson, Chalmers University of Technology, Sweden Version: final When citing this report, please use: König, D., Eckhardt, J., Aapaoja, A., Sochor, J. & Karlsson, M. (2016). Deliverable 3: Business and operator models for MaaS. MAASiFiE project funded by CEDR. For Figures citation, please see the Figure. For example Figure 22: Eckhardt, J. & Aapaoja, A. (2016) In: König, D., Eckhardt, J., Aapaoja, A., Sochor, J. & Karlsson, M. (2016). Deliverable 3: Business and operator models for MaaS. MAASiFiE project funded by CEDR. Page 2 of 71 Call 2014: Mobility and ITS Executive summary The transnational research programme “Call 2014: Mobility and ITS” was launched by the Conference of European Directors of Roads (CEDR). Funded within that program, Mobility as a Service for Linking Europe (MAASiFiE) is a two-year project that investigates the prerequisites for organizing user-oriented and ecological mobility services in order to provide consumers with flexible, efficient and user-friendly services covering multiple modes of transport on a one-stop-shop principle. -
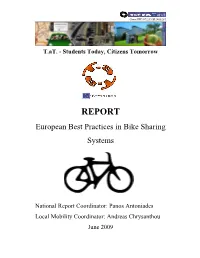
European Best Practices in Bike Sharing Systems
Grant EIE/07/239/SI2466287 T.aT. - Students Today, Citizens Tomorrow REPORT European Best Practices in Bike Sharing Systems National Report Coordinator: Panos Antoniades Local Mobility Coordinator: Andreas Chrysanthou June 2009 Grant EIE/07/239/SI2466287 Index Index________________________________________________________________ 2 1. Introduction ______________________________________________________ 3 2. Bike Sharing System _______________________________________________ 7 3. Overview of bike share systems elements ______________________________ 9 4. Types of Bike Sharing System_______________________________________ 12 4.1. Unregulated________________________________________________________ 13 4.2. Deposit ___________________________________________________________ 13 4.3. Membership _______________________________________________________ 13 4.3.1. Public-private partnership ___________________________________________ 13 4.4. Long-term checkout _________________________________________________ 14 4.5. Partnership with railway sector ________________________________________ 14 4.6. Partnership with car park operators ____________________________________ 15 5. Evolution of Bike Sharing System ___________________________________ 15 6. Operations ______________________________________________________ 17 7. European best practises____________________________________________ 21 8. Conclutions _____________________________________________________ 51 9. References ______________________________________________________ 54 2 T.aT. – Students -

Pro Gradu -Tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede
Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede HELSINGIN KAUPUNKIPYÖRÄJÄRJESTELMÄ: KÄYTÖN ALUEELLISET JA AJALLISET RAKENTEET Mikko Raninen 2018 Ohjaajat: Maria Salonen Henrikki Tenkanen Tuuli Toivonen Sami Moisio HELSINGIN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS MAANTIEDE PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2) 00014 Helsingin yliopisto Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Laitos/Institution– Department Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Geotieteiden ja maantieteen laitos Tekijä/Författare – Author Mikko Raninen Työn nimi / Arbetets titel – Title Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä: käytön alueelliset ja ajalliset rakenteet Oppiaine /Läroämne – Subject Suunnittelumaantiede Työn laji/Arbetets art – Level Aika/Datum – Month and year Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2018 84 s. + liitteet 11 s. Tiivistelmä/Referat – Abstract Kaupunkien kasvava väestö ei kestä henkilöautoliikenteen kasvua samassa suhteessa, vaan liikenteen järjestämiseksi on löydettävä kestävämpiä keinoja. Henkilöautoliikenteen negatiiviset ulkoisvaikutukset, kuten hiilidioksidipäästöt, melu ja muut ympäristöhaitat sekä liikenteen ruuhkautuminen, ovat merkittävä ongelma kaupungeissa. Autoilua voidaan vähentää rajoituksilla, kuten ruuhkamaksuilla, mutta tärkeää on myös tarjota kilpailukykyisiä vaihtoehtoja kaupungissa liikkumiseen. Erityisesti ihmisten vapaa-ajan liikkumisen on todettu lisääntyneen, minkä vuoksi liikenteen kestävälle järjestämiselle on kysyntää. Kävelyn ja pyöräilyn -

Public Bicycles
EuroTest http://www.eurotestmobility.com/eurotest.php?itemno=418&la... MEMBERS log in newsletter drivers home | news | EuroTests | downloads | co EuroTests - EuroTest 2012 - Public Bicycles Back to list Results Back to Public Bicycles test Click here to view the overall ranking of the 40 systems Bikes-to-go are looking pretty good Almost all of the 40 public bicycle hire schemes in this first-time comparison of schemes in cities throughout Europe offer their bikes at permanent rental stations in their area. But that's were the similarities end. With such a diverse range of offers, differences in quality have to be expected. This becomes obvious as soon as we look at the number of stations where bikes can be picked up. This ranges from just a single station in the case of BUGA in Aveiro, Portugal, to 1,751 in the case of Vélib' in Paris. France's capital also holds the record for the number of bicycles: 23,900. Compared to second-place Barclay's Cycle Hire in London with its 558 stations and 9,200 bicycles, we can see just how impressive this record is. And the winner is: France But still, Paris, which is certainly setting an example for the rest of the world, only received a "Good" rating and came second in this European comparison. The capital city was nipped at the post by fellow countryman vélo'v in Lyon, the only scheme to receive a "Very good" rating. 343 stations with 4,000 bicycles, available to anyone all year round, linked to local public transport, easy and free registration, fully automated bicycle pick-up and return at any station, information provided in several languages and accessible in many different ways - that's pretty close to the perfect bike-to-go system. -
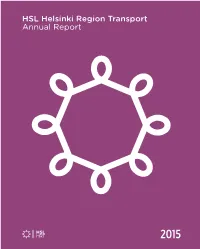
HSL Helsinki Region Transport Annual Report 2015 HSL Helsinki Region Transport Annual Report
HSL Helsinki Region Transport Annual Report 2015 Annual Report Transport HSL Helsinki Region HSL Helsinki Region Transport Annual Report 2015 HSL Helsinki Region Transport Annual Report 2015 Content This is HSL 4 Executive Director’s Review 6 Year at a glance 8 Customers 14 Personnel 16 Environment 20 Public transport in figures 22 Finances 26 Administration and organization 30 In 2015, commuter train ridership increased by 8.9 percent. VALUES Cooperation OBJECTIVES Environmental responsibility Smooth journeys Clear services Customers’ travel chain is We provide our customers with based on the public transport up-to-date information before and during their journeys as VISION 2025 feeder services. well as clear, easy-to-use and Public transport is the reasonably priced tickets. number one choice for travel. Helsinki region is a bellwether Customer focus for intelligent, sustainable and safe mobility. Increasing public transport use Compact and attractive region A transport system based on rail to public transport, walking services creates a more compact and cycling. urban structure and makes the region more attractive. Continuous development Fewer emissions Eective finances We increase the share of low- We make public transport more BASIC TASK emission public transport. Helsinki Region Transport the funding base of the entire develops and provides smooth, transport system. reliable transport solutions to customers’ needs. Strategic goals and their achievement 2015 In 2015, HSL had nine strategic goals. Progress towards these goals was measured -

Research for Tran Committee - Tourism and the Sharing Economy: Challenges and Opportunities for the Eu
DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHESION POLICIES TRANSPORT AND TOURISM RESEARCH FOR TRAN COMMITTEE - TOURISM AND THE SHARING ECONOMY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR THE EU STUDY This document was requested by the European Parliament's Committee on Transport and Tourism. AUTHORS University of Central Lancashire, United Kingdom: Paul Peeters, Corné Dijkmans, Ondrej Mitas, Boukje Strous, Jeroen Vinkensteijn RESPONSIBLE ADMINISTRATOR Piero Soave Policy Department Structural and Cohesion Policies European Parliament B-1047 Brussels E-mail: [email protected] LINGUISTIC VERSIONS Original: EN ABOUT THE EDITOR To contact the Policy Department or to subscribe to its monthly newsletter please write to: [email protected] Manuscript completed in October 2015. © European Union, 2015. Print ISBN 978-92-823-8467-1 doi:10.2861/261804 QA-04-15-922-EN-C PDF ISBN 978-92-823-8466-4 doi:10.2861/965550 QA-04-15-922-EN-N This document is available on the Internet at: http://www.europarl.europa.eu/studies DISCLAIMER The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the author and do not necessarily represent the official position of the European Parliament. Reproduction and translation for non-commercial purposes are authorized, provided the source is acknowledged and the publisher is given prior notice and sent a copy. DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHESION POLICIES TRANSPORT AND TOURISM RESEARCH FOR TRAN COMMITTEE - TOURISM AND THE SHARING ECONOMY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR THE EU STUDY Abstract The impacts, challenges and opportunities caused by the fast-growing sharing economy in tourism are assessed.