Relazione Geologica Generale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Andrea Penna
Andrea Penna, PhD Associate Professor Department of Civil Engineering and Architecture University of Pavia Via Ferrata 3, I-27100 Pavia, Italy [email protected] Phone + 39 0382 5169824 / +39 0382 985467 ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6457-7827 ResearcherID: N-7278-2015 Scopus Author ID: 24438325600 https://scholar.google.it/citations?user=JDCqZ6sAAAAJ&hl=it ANDREA PENNA CURRICULUM OF SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ACTIVITIES Current academic position Associate Professor of Structural Engineering University of Pavia Department of Civil Engineering and Architecture (since October 1st, 2015) Other affiliations. Fellow, European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering, Pavia, Italy. (since 2012) Personal data Born in Genoa (Italy) on 21.05.1973 Home address: Via Severino Capsoni 17 I-27100 Pavia (PV), Italy Previous work experiences 2011-15 Assistant Professor of Structural Engineering University of Pavia Department of Structural Mechanics Department of Civil Engineering and Architecture (since 2012) 2003-11 Researcher European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering (EUCENTRE), Pavia 2002-03 Post-doc in Structural Engineering University of Genoa Department of Structural and Geotechnical Engineering 1/29 Post-doct - scale risk EC FP5 RISK-UE Project) Education 1999-2002 PhD in Earthquake Engineering Polytechnic of Milan (Italy) Department of Structural Engineering PhD Advisors: Prof. E. Faccioli (Politecnico di Milano), Prof. S. Lagomarsino (University of Genoa). External reviewer: Prof. M. Tomazevic (ZAG, -

2022 Tour Brochure
UNCOVERING THE HIDDEN DELIGHTS OF ITALY.....TOGETHER!! 2022 TOUR BROCHURE Lombardy Delights Pty Ltd. (Trading as Italian Delights Tours) ABN – 82 886 161 696 www.italiandelights.com.au EMAIL: [email protected] PH: (AUS) 1300 681 822 (INT) +61 39018 6624 Postal Address: PO Box 95 Bentleigh, VIC 3204 2022 Tour Dates 15 Day Fine Food, Wine and Wonders Tour Sep 15th to 29th (See Page 3) 12 Day Treasures of Tuscany, Umbria and Lombardy Tour Aug 30th to Sep 10th (See Page 4) 8 Day Classic Hidden Delights Tour Sep 22nd to 29th (See Page 5) 8 Day Southern Treasures & Secret Delights of Basilicata & Puglia Tour Oct 17th to 24th (See Page 6) 12 Day Walks and Wonders Tour Oct 1st to 12th (See Page 7) ALL OF OUR TOURS CAN BE TAKEN AS PRIVATE TOURS WITH A GROUP SIZE OF 4 OR MORE GUESTS CLICK HERE FOR A MORE IN DEPTH LOOK AT OUR OUR EXTENDED STAY TOURS 1 5 D a y F i n e F o o d , W i n e a n d W o n d e r s T o u r 2022 START DATES SEP 15TH(& PRIVATE TOURS BY APPOINTMENT - MIN. 4 GUESTS) If you love great food, great wine and gorgeous views, then this is the tour for you! Apart from many hidden delights, experience the stunning Lakes Como and Maggiore. Be swept away by the dizzying heights of St. Moritz and the Italian and Swiss Alps! Enjoy the big bold reds of the famous Barolo wine region and go truffle hunting with our friend and truffle grower Giorgio and his lovely wife Grazia. -
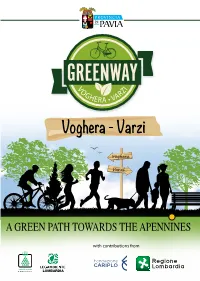
Greenway V O I G Rz Hera • Va
GREENWAY V O I G RZ HERA • VA Voghera - Varzi Voghera Varzi A GREEN PATH TOWARDS THE APENNINES with contributions from Credits Voghera - Varzi Greenway: a green path towards the Apennines • The guide to the route is a project promoted by Provincia di Pavia in partnership with Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese and Legambiente Lombardia, with contributions from the Fondazione Cariplo and Regione Lombardia. Editing, design, graphics, text, layout and printing: Bell&Tany, Voghera, bell-tany.it. Finished printing in the month of June 2021. ©Province of Pavia 2021 ©Bell&Tany 2021 All rights reserved. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited. www.provincia.pv.it www.visitpavia.com www.greenwayvogheravarzi.it This guide is printed respecting the environment on recycled paper. discovering the OLTREPÒ PAVESE 2044 0053 AT / 11 / 002 GREENWAY V O I G RZ HERA • VA Voghera - Varzi Exploring Walking Cycling Savouring discovering the OLTREPÒ PAVESE 2 The Voghera - Varzi Greenway is ready. It is a 33 kilometers long dream, begone when dreaming cost nothing. When thinking of recovering the old railway line was a romantic, good and appealing idea, yet so unlikely. Still we succeeded. With passion, persistence, and a lot of good will. If it is true, as Eleanor Roosevelt wrote, “that the future belongs to the ones who believe in the beauty of their dreams”, therefore today we are giving Oltrepò a little something to hope a different, better future. Discovering the territory, experiencing the natural beauty, sharing the pleasure of good food, letting the silence of unexpected and magical places conquer ourselves, being together with friend hoping the time will never pass. -

Commissione Provinciale Di Pavia
Allegato 1 COMMISSIONE PROVINCIALE per l’indicazione dei valori fondiari medi di PAVIA - Costituita con decreto n. 12701 del 26/10/2020 Tabella dei valori fondiari medi dei terreni valida per l’Anno 2020 Reg. Ag. 1 Reg. Ag. 2 Reg. Ag. 3 Reg. Ag. 4 Reg. Ag. 5 Reg. Ag. 6 Reg. Ag. 7 Reg. Ag. 8 Reg. Ag. 9 Reg. Ag. 10 Reg. Ag. 11 COLTURA €/mq. €/mq. €/mq. €/mq. €/mq.. €/mq. €/mq. €/mq. €/mq. €/mq. €/mq. Seminativo 0,78 2,00 1,35 3,00 3,40 3,50 3,80 3,30 3,00 3,80 3,30 Seminativo Arb. 0,85 2,20 1,05 === === === === === === 3,75 === Seminativo Irr. === === === 3,50 3,95 4,25 4,90 3,80 3,40 === 3,70 Prato 0,56 1,70 1,05 === === === === === === === === Prato Irriguo === 2,17 === 2,40 2,90 3,36 3,10 2,56 === 2,70 2,80 Prato a Marcita === === === 2,30 3,00 3,10 3,00 2,43 2,45 === 2,50 Risaia Stabile === === === 3,00 2,86 3,30 3,50 3,00 2,78 === 3,00 Pascolo 0,33 0,36 0,33 === === === === === === === === Pascolo Arb. 0,34 0,37 0,34 === === === === === === === === Orto === 3,07 === 2,78 3,09 2,77 2,95 2,77 2,77 3,44 2,77 Orto Irriguo === === === 3,60 4,25 4,35 5,10 3,90 3,40 3,90 3,80 Vigneto I.G.P. 1,27 4,00 3,20 === === === === === === 3,20 2,20 Vigneto D.O.C. === 5,04 4,00 === === === === === === 4,00 2,68 Frutteto 2,75 3,30 2,90 === === === === === === 3,80 2,50 Bosco Alto F. -

Males Females Total
10/2/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Lombardia / Province of Pavia / Cecima Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Alagna Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Fortunago AdminstatAlbaredo logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Arnaboldi FrascaroloITALIA Albonese Galliavola Albuzzano Gambarana Arena Po Gambolò Badia Pavese Garlasco Bagnaria Gerenzago Barbianello Giussago Bascapè Godiasco Salice Terme Bastida Pancarana Golferenzo Battuda Gravellona Lomellina Belgioioso Gropello Cairoli Bereguardo Inverno e Borgarello Monteleone Borgo Priolo Landriano Borgo San Siro Langosco Borgoratto Lardirago Mormorolo Linarolo Bornasco Lirio Bosnasco Lomello Brallo di Pregola Lungavilla Breme Magherno Bressana Marcignago Bottarone Marzano Broni Mede Calvignano Menconico Campospinoso Mezzana Bigli Candia Mezzana Lomellina Rabattone Canneto Pavese Mezzanino Carbonara al Miradolo Terme Ticino Montalto Casanova Pavese Lonati Montebello Casatisma della Battaglia Casei Gerola Powered by Page 3 Casorate Primo Montecalvo L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Versiggia Cassolnovo Adminstat logo Montescano DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Castana ITALIA Montesegale Casteggio Monticelli Castelletto di Pavese Branduzzo Montù Beccaria Castello -

P.G.T. Valutazione Ambientale Strategica
P.G.T. Valutazione Ambientale Strategica Comune di BAGNARIA SINTESI NON TECNICA Adeguamento novembre 2011 VAS – SINTESI NON TECNICA INDICE 1. Obiettivi e contenuti del Rapporto Ambientale VAS 3 2. Il contesto di riferimento ambientale 8 3. Scenario di riferimento per il PGT 11 4. Proposte di Progetto: le azioni strategiche 15 5. Criteri ambientali e misure di mitigazione per l’attuazione del PGT 18 6. Sistema di monitoraggio 28 PGT BAGNARIA 2 VAS – SINTESI NON TECNICA Sintesi non tecnica 1. Obiettivi e contenuti del Rapporto Ambientale VAS Questo documento rappresenta la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale VAS del Documento di Piano di Bagnaria Il Rapporto Ambientale è realizzato ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato I della Direttiva europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica e conforme agli Indirizzi generali per la valutazione ambientalie di piani e programmi, deliberati dal consiglio regionale della Regione Lombardia con d.c.r. n. 351 del 13 marzo 2007 e della DGR 6420 del 30 dicembre 2007, aggiornata dalla DGR 10971 del 30/12/2009. Il documento è predisposto nell’intento di aumentare la comprensione delle ricadute ambientali derivanti dalle azioni antropiche e di favorire la partecipazione collettiva ai processi di pianificazione. La documentazione prodotta nell’ambito della VAS è parte integrante del Documento di Piano nonché del PGT. La procedura di VAS, ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie rispetto agli obiettivi di sostenibilità del PGT e le possibili sinergie con altri strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore. Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione che devono essere recepite dallo stesso strumento urbanistico. -

Piano Annuale Dell'offerta Abitativa 2021
COMUNE DI VOGHERA Provincia di Pavia PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE Comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Casei Gerola,Cecima, Codevilla, Colli Verdi, Corana, Cornale e Bastida, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, Varzi, Voghera, Zavattarello PIANO ANNUALE DELL’OFFERTA ABITATIVA 2021 CONTESTO Il presente Piano Annuale dell’Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali è stato predisposto in conformità all’articolo 4 del Regolamento Regionale n. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni e sulla base dei dati forniti dai Comuni dell’Ambito e dall’ALER di Pavia-Lodi, che è stata sentita prima di sottoporre la proposta all’Assemblea dei Sindaci. L’Ambito Territoriale Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese è composto dai Comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Casei Gerola, Cecima, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Colli Verdi, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, Varzi, Voghera e Zavattarello. In data 9.05.2019 l’Assemblea dei Sindaci ha designato il Comune di Voghera quale Ente capofila dell’Ambito per la programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale. Il Presente Piano Annuale 2021 dell’offerta abitativa, come indicato dal punto 3 del Comunicato regionale n. 45 del 2 aprile 2019, contiene tutti i dati indicati come contenuti minimi ed essenziali inviati dai Comuni dell’Ambito territoriale e dall’ALER di Pavia-Lodi. -

Denominazione E Ragione Sociale Sede Legale Sede
SEDE SECONDARIA CON DATA PRESENTAZIONE STORICO E RICHIESTE DI RINNOVO DENOMINAZIONE E RAGIONE CODICE FISCALE PARTITA STATO DELLA SCADENZA SEDE LEGALE RAPPRESENTANZA STABILE IN ISTANZA DI ISCRIZIONE O ATTIVITA' PER CUI E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN ISTRUTTORIA (*BDNA=banca dati SOCIALE IVA PRATICA ISCRIZIONE ITALIA DI RINNOVO nazionale antimafia) TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA CONTO TERZI - 27100 Pavia, Via ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E 5 M AUTOTRASPORTI S.R.L. 01483150189 02/11/2018 ISCRITTA 14/02/2020 Sagliona n. 240 MATERIALI INERTI- NOLLI A CALDO - AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI Parona Lomellina, via ABONECO RECYCLING S.R.L. 02194460180 25/09/2018 ISCRITTA 06/03/2020 TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTO TERZI S.S. km.35 SNC TRASPORTO MATERIALI A DISCARICA CONTO TERZI - Parona Lomellina, Strada TRASPORTO, ANCHE TRANSFRONTALIERO E ABONECO S.R.L. 01280780188 15/01/2019 ISCRITTA 07/03/2020 Statale 494 Km 35 s.n.c. SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTO TERZI - NOLI A CALDO - AUTOTRASPORTO CONTO TERZI 27043 Broni, via A. da In corso istruttoria per rinnovo ACHILLE GIANCARLO CHLGCR65D16B201P 30/10/2019 IN AGGIORNAMENTO AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI Giussano n. 46 iscrizione Ferrera Eerbognone, TRASPORTO, ANCHE TRANSFRONTALIERO E ACTA S.R.L. 02386550186 15/05/2019 ISCRITTA 09/07/2020 Cascina Gallona snc SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTO TERZI Pieve del Cairo, Via ESTRAZIONE,FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E AEP COSTRUZIONI S.R.L 12053840158 30/04/2018 ISCRITTA 10/05/2020 RINNOVO CON BDNA Guasca n.1 MATERIALI INERTI - NOLI A CALDO ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO TERRA E Mezzana Bigli, Via SCADUTA MATERIALI INERTI - CONFEZIONAMENTO FORNITURA E AGEST COSTRUZIONI S.R.L. -

Aziende Provincia Di PAVIA.Xlsx
Aziende provincia di PAVIA.xlsx PRODOTTI INFORMAZIONI PER LA DISPONIBILI PER DOVE CONSEGNA CONSEGNA/RAGGIO IN TIPO DI NOME AZIENDA INDIRIZZO COMUNE TELEFONO MAIL SITO CONSEGNA A KM ZONA DI PAGAMENTO DOMICILIO CONSEGNA PROVINCIA DI ORLANDI ANNIBALE FRUTTA FRAZ. CASCINONE ALBAREDO ARNABOLDI 0385 277644 [email protected] 30 KM RIMESSA DIRETTA PAVIA FRUTTA, SUINI (A PROVINCIA DI CIGNOLI ANDREA VIA SAN ROCCO ARENA PO 335 7764763 [email protected] 30 KM RIMESSA DIRETTA BREVE SALUMI) PAVIA CONTRADA BORGORATTO, PROVINCIA DI MALASPINA CURRADO VINO BOBBIO 339-2310638 [email protected] 30 KM RIMESSA DIRETTA 26 PAVIA Consegne possibili in tutta la Provincia di Vendita vino in Pavia e limitrofi. Per Chiamare almeno un Az. Agr. Ca' Däl Prèvi di Cristiano In contanti alla bottiglie e in Loc. Albergognone, 8 BORGO PRIOLO 3441194613 [email protected] ordini un pò più giorno prima della Forlino consegna. damigiana consistenti anche in consegna. tutta la Regione Lombardia. Provincia di Pavia, Provincia di Milano, Pagamento alla Az. Agr. Piaggi Francesco. Fradé 342/1815111 [email protected] Bottiglie di vino Loc. Boffenisio 3 BORGO PRIOLO Valenza, Sale e Consegna in 48/72h consegna in contanti, Wine 340/7137234 www.fradewine.it comuni limitrofi, per carta o bancomat. altre zone contattateci. AZ.AGR. LA BIANCHINA DI PROVINCIA DI FRUTTA/ORTICOLE LOC. TORRE BIANCHINA 3 BORGO PRIOLO 3939053452 [email protected] 70 KM RIMESSA DIRETTA CREMONESI ELISA PAVIA RIVA DEL BORGO SOCIETA' PROVINCIA DI VINO LOCALITA' RIVAZZA -

“BONARDA DELL'oltrepò PAVESE” Approvata Come T
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “BONARDA DELL’OLTREPÒ PAVESE” Approvata come tipologia della DOC “Oltrepò Pavese” con D.P.R. 06.08.70, G.U. n. 273 - 27.10.70 Approvato DOC con D.M. 03.08.2010 G.U. 193 – 19.08.2010 Modificato con D.M. 03.11.2010 G.U. 269 – 17.11.2010 Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Articolo 1 Denominazione e vini La Denominazione di Origine Controllata “Bonarda dell’Oltrepò Pavese” è riservata ai vini, anche nella tipologia “frizzante”, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 Base ampelografica I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Croatina: dall’85% al 100%; - Barbera, Ughetta (Vespolina), Uva rara: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%. Articolo 3 Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Bonarda dell’Oltrepò Pavese" comprende la fascia vitivinicola collinare dell’“Oltrepò Pavese” per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate. -

COMUNE DI VOGHERA Provincia Di Pavia PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE
COMUNE DI VOGHERA Provincia di Pavia PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI (D.G.R. N. 4138/2020) ANNO 2021. FINALITÀ Il presente bando disciplina l’erogazione del buono sociale finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare e/o le prestazioni di personale di assistenza regolarmente impiegato, secondo quanto previsto dalla D.G.R. N. 4138/2020 (Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2020 esercizio 2021). DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA Sono destinatari del buono sociale le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti: - di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale; - in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. n. 508/1988; - con i seguenti valori massimi ISEE di riferimento: sociosanitario fino a un massimo di € 25.000,00 e ISEE ordinario in caso di minori fino a un massimo di € 40.000,00. Possono presentare domanda per l’ottenimento del buono sociale le persone residenti nei Comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Casei Gerola, Cecima, Codevilla, Colli Verdi, Corana, Cornale e Bastida, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, Varzi, Voghera, Zavattarello. -

Comuni Associati Analisi
INDICE 1. Oggetto dell’analisi pag. 1 2. Quadro normativo di riferimento pag. 6 2.1 Commercio al dettaglio in sede fissa: definizioni e forme pag. 6 2.2 Commercio al dettaglio in sede fissa: tipologie pag. 6 2.3 Commercio al dettaglio in sede fissa: la programmazione commerciale regionale pag. 7 2.4 Commercio al dettaglio in sede fissa: la programmazione commerciale provinciale pag. 9 2.5 Centri di telefonia fissa (Phone Center) pag. 10 2.6 RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI pag. 11 2.6.1 Premessa pag. 11 2.6.2 I distributori di carburante pag. 11 3. Quadro ricognitivo territoriale e demografico pag. 13 3.1 Inquadramento territoriale pag. 13 3.2 Inquadramento demografico pag. 15 4. Quadro conoscitivo del sistema distributivo comunale pag. 21 4.1 Evoluzione del sistema distributivo pag. 21 4.2 Lo stato di fatto del commercio al dettaglio in sede fissa pag. 23 4.2.1 Il Comune di Bagnaria pag. 23 4.2.2 Il Comune di Cecima pag. 25 4.2.3 Il Comune di Ponte Nizza pag. 25 4.2.4 Il Comune di Val di Nizza pag. 26 4.2.1 Situazione complessiva pag. 27 4.3 La distribuzione territoriale dei punti di vendita al dettaglio in sede fissa pag. 30 4.4 Lo stato di fatto dei centri di telefonia fissa pag. 33 4.5 Gli impianti di distribuzione carburanti presenti sul territorio pag. 33 4.5 Rapporto tra domanda e offerta pag. 34 5. Ipotesi di sviluppo del sistema distributivo comunale pag. 36 ALLEGATI Allegato 1 – Quadro del sistema distributivo nazionale e lombardo pag.