Download Download
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The MICHELIN LTX Force H4 and S5 Ready for Sardinia's Rough Ride
MEDIA INFORMATION 2017 FIA World Rally Championship (WRC) Round 7: Rally Italia Sardegna The MICHELIN LTX Force H4 and S5 ready for Sardinia’s rough ride Since 2015, Rally Italia Sardegna has been based on the Mediterranean gem’s east coast, in Alghero, where the harbourside service park exudes something of a holiday feel, an impression amplified by the location’s backdrop of blue sea, sailing boats and nearby white beaches. That said, it is on the other side of the island that the event will actually kick off on Thursday evening with a super-special in Olbia where the real start will get under way the following morning. The total distance of this year’s event is 1,495.36km, including 19 stages totalling 321.46km. The first full day’s menu features four tests totalling 125.46km, including two particularly rough classics – Terranova and Monte Olia – which are back on the programme and stand out as the chief change compared with last year. The longest and potentially hardest leg for the crews and their cars comes on Saturday with six stages totalling 143.16km in the Monte Acuto region. The Italian event then concludes on Sunday with two visits to two coastal tests north of Alghero for a competitive distance of 42.04km. To cope with Rally Italia Sardegna’s specific challenges, Michelin’s WRC partners will be able to choose between the MICHELIN LTX Force H4 (hard compound) and S5 (soft), while the options for their WRC2 counterparts are the MICHELIN Latitude Cross H90 and S80. “Since the WRC stopped going to Greece, Rally Italia Sardegna is the only event that takes place on such hard ground,” notes Jacques Morelli, manager of Michelin’s WRC programme. -

Economic Survey of North Sardinia 2014
Economic Survey of North Sardinia 2014 Economic Survey of North Sardinia 2014 PAGE 1 Economic Survey of North Sardinia 2014 Introduction Through the publication of the Economic Survey of North Sardinia, the Chamber of Commerce of Sassari aims to provide each year an updated and detailed study concerning social and economic aspects in the provinces of Sassari and Olbia-Tempio and, more generally, in Sardinia . This survey is addressed to all the entrepreneurs and institutions interested in the local economy and in the potential opportunities offered by national and foreign trade. Indeed, this analysis takes into account the essential aspects of the entrepreneurial activity (business dynamics, agriculture and agro-industry, foreign trade, credit, national accounts, manufacturing and services, etc…). Moreover, the analysis of the local economy, compared with regional and national trends, allows to reflect on the future prospects of the territory and to set up development projects. This 16th edition of the Survey is further enriched with comments and a glossary, intended to be a “guide” to the statistical information. In data-processing, sources from the Chamber Internal System – especially the Business Register – have been integrated with data provided by public institutions and trade associations. The Chamber of Commerce wishes to thank them all for their collaboration. In the last years, the Chamber of North Sardinia has been editing and spreading a version of the Survey in English, in order to reach all the main world trade operators. International operators willing to invest in this area are thus supported by this Chamber through this deep analysis of the local economy. -

Comuni Dell'anglona E Gallura Che Abbracciano La Bassa Valle Del Coghinas Valledoria
COMUNI DELL’ANGLONA E GALLURA CHE ABBRACCIANO LA BASSA VALLE DEL COGHINAS VALLEDORIA Valledoria (fino al 1960 Codaruina , Codaruìna in gallurese e sassarese ) è un comune di 4.125 abitanti della provincia di Sassari , nell'antica regione dell' Anglona . Il paese si affaccia sul Golfo dell' Asinara , nei pressi della foce del fiume Coghinas . Il paese sorge sul sito dell’antico borgo romano di Codes , da cui deriva appellativo Codaruina . Nel medioevo fu sede della Diocesi di Ampurias , distrutta ripetutamente dai pirati barbari. Appartenuta al Giudicato di Torres e passato alla famiglia genovese dei Doria , dopo la conquista aragonese , la valle del Coghinas fu colpita da epidemie catastrofiche (secolo XV) che portarono allo spopolamento di queste terre. La ripresa demografica si ebbe, come del resto in tutta la bassa gallura , verso la metà dell’ Ottocento , grazie all’afflusso di famiglie galluresi da Aggius e Tempio Pausania che occuparono le vaste pianure deserte e fertilissime, dando vita all'insediamento di Codaruina, oggi Valledoria centro. Nel 1960 Codaruina si rese comune autonomo con il nome di Valledoria comprendendo le frazioni di La Muddizza, La Ciaccia, San Pietro, Baia Verde e Maragnani, il cui territorio era compreso nei comuni di Sedini e Castelsardo . Nel 1983 si è staccata la frazione di Santa Maria Coghinas divenuta comune autonomo. SANTA MARIA COGHINAS Santa Maria Coghinas (Cuzina in gallurese , Santa Maria Cutzinas in sardo ) è un comune di 1.439 abitanti della provincia di Sassari Il centro abitato sorge nella regione storica dell'Anglona , sulla riva occidentale del fiume Coghinas e ai piedi delle colline che delimitano la fertilissima valle alluvionale con una media di 2 m s.l.m. -

Calendario Venatorio 2017-2018
CALENDARIO VENATORIO 2017-2018 PROVINCIA DI SASSARI Regione Autonoma della Sardegna - Decreto DecA/ 25 del 21.07.2017 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SETTORE AMBIENTE-AGRICOLTURA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE Specie cacciabili e periodi di attività venatoria Limiti di carniere Orario di caccia ed ulteriori prescrizioni mesi Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Orari di caccia decadi I° II° III° I° II° III° I° II° III° I° II° III° I° II° III° I° limiti di carniere giornaliero limiti di carniere stagionale nei giorni 1 e 4 settembre dalle ore 6.00 alle ore 20.30 (orario legale) giornata intera sino alle 14.00 intera il giorno 25 settembre dalle ore 6.20 alle ore 14.00 (orario legale) Tortora (Streptopelia t.) 3,7 Tortora 10 Tortora: non più di 20 capi a stagione il giorno 2 ottobre dalle ore 6.30 alle ore 14.00 (orario legale) Pernice sarda 24 1 Pernice sarda 2 Pernice sarda: non più di 4 capi a stagione dal 6 al 27 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.30 (orario legale) Lepre sarda 24 1 Lepre sarda 1 Lepre sarda: non più di 2 capi a stagione Dal 30 ottobre al 15 novembre dalle ore 6.00 alle ore 18.15 (orario solare) Coniglio selvatico 24 1 Dal 5 Al 31 Coniglio selvatico 5 Dal 16 al 30 novembre dalle ore 6.15 alle ore 18.00 (orario solare) Germano reale 24 1 Dal 5 Al 28 Germano reale 10 Dal 1 al 15 dicembre dalle ore 6.30 alle ore 18.00 (orario solare) Alzavola 24 1 Dal 5 Al 28 Alzavola 10 Non più di 15 capi Dal 16 al 31 dicembre dalle ore 6.45 alle ore 18.00 (orario solare) Non più di 10 capi CHIUSURA 5 complessivamente -
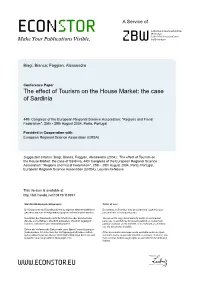
The Case of Sardinia
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra Conference Paper The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra (2004) : The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia, 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/116951 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

Calendari Giovanissimi Ss
* Delegazione di Sassari * F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI * SARDEGNA * ************************************************************************ * * * GIOVANISSIMI SASSARI GIRONE: A * * * ************************************************************************ .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 11/10/15 | | RITORNO: 7/02/16 | | ANDATA: 15/11/15 | | RITORNO: 13/03/16 | | ANDATA: 20/12/15 | | RITORNO: 24/04/16 | | ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 6 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 11 G I O R N A T A | ORE....: | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | AMPURIAS - CANOPOLENO CALCIO | | ALGHERO - FRASSATI | | C.U.S.SASSARI - WILIER | | FRASSATI - TERGU PLUBIUM | | C.U.S.SASSARI - PATTADA | | CANOPOLENO CALCIO - ALGHERO | | LA CANTERA SORSO - C.U.S.SASSARI | | CANOPOLENO CALCIO - TERGU PLUBIUM | | FRASSATI - AMPURIAS | | NETTUNO - SPORTING SASSARI | | JUNIOR SAN NICOLA CALCIO - NETTUNO | | PATTADA - QUARTIERI RIUNITI | | QUARTIERI RIUNITI - WILIER | | QUARTIERI RIUNITI - LA CANTERA SORSO | | SACRO CUORE CALCIO - NETTUNO | | SACRO CUORE CALCIO - JUNIOR SAN NICOLA CALCIO | | SOGMA - AMPURIAS | | SPORTING SASSARI - JUNIOR SAN NICOLA CALCIO | | SOGMA - ALGHERO | | SPORTING SASSARI - SACRO -

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus 113 113 Laerru Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 113 (Laerru) ha 3 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Laerru: 13:45 - 16:32 (2) Perfugas: 06:45 (3) Valledoria: 15:26 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 113 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 113 Direzione: Laerru Orari della linea bus 113 13 fermate Orari di partenza verso Laerru: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 13:45 - 16:32 martedì 13:45 - 16:32 Perfugas 84 Via Giuseppe Mazzini, Perfugas mercoledì 13:45 - 16:32 Viddalba giovedì 13:45 - 16:32 S.M.Coghinas (Via Sardegna-Poste) venerdì 13:45 - 16:32 sabato 13:45 - 16:32 Valledoria 2 Via Regina Elena, Codaruina domenica Non in servizio La Ciaccia 1 Via Giovanni Pascoli, Valledoria La Muddizza Informazioni sulla linea bus 113 3 Via Pietro Micca, Valledoria Direzione: Laerru Fermate: 13 Multeddu Durata del tragitto: 65 min La linea in sintesi: Perfugas, Viddalba, Castelsardo La Pianedda S.M.Coghinas (Via Sardegna-Poste), Valledoria, La 2B Via Sedini, Castelsardo Ciaccia, La Muddizza, Multeddu, Castelsardo La Pianedda, Lu Bagnu Centro, Tergu, Sedini, Bulzi, Lu Bagnu Centro Laerru 1 Via Lazio, Lu Bagnu Tergu 4 Traversa dei Benedettini, Tergu Sedini Bulzi Laerru Direzione: Perfugas Orari della linea bus 113 13 fermate Orari di partenza verso Perfugas: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 06:45 martedì 06:45 Laerru mercoledì 06:45 Bulzi giovedì 06:45 Sedini venerdì 06:45 Tergu sabato 06:45 4 Traversa dei Benedettini, Tergu domenica -

Guida Alla Scoperta Dell'anglona E Delle
ITINERARI AGRITURISTICI NELL’ANGLONA Guida alla scoperta dell’Anglona e delle sue aziende agrituristiche Panorama dell’agro di Perfugas 1 GUIDA ALLA SCOPERTA DELL’ ANGLONA E DELLE SUE AZIENDE AGRITURISTICHE A CURA DI: Maria Sale Responsabile del progetto ed elaborazione testi Antonio Cossu Fotografie, elaborazione testi e aggiornamenti per internet Gianni Muru Cartografia Massimo Tola e Leonardo Addis Elaborazione cartografica digitale Serafino Pes Coordinatore del Centro Zonale Ersat Centro Zonale di Castelsardo Via Colombo, 15 07040 Castelsardo Telefono e fax: 079470652 2 PRESENTAZIONE Il mondo degli agriturismo della Sardegna di giorno in giorno è diventato il deposi- tario di un forte patrimonio enogastronomico e culturale dell’ambito nazionale. Dare vita a strutture imprenditoriali di grande qualità ha segnato, infatti, un passo avanti, soprattutto grazie alla costante presenza dell’assistenza tecnica dell’Ersat, nella deter- minazione di nuove strade dell’economia isolana nell’ambito agricolo e turistico. È dunque consequenziale che iniziative tese alla valorizzazione delle strutture agri- turistiche e del patrimonio storico e culturale della Sardegna, trovino rapidamente il consenso dovuto in tutti gli ambiti. É evidente che, con questa pubblicazione cura- ta dall’Ersat, anche la vocazione turistico rurale e quella gastronomica dell’Anglona, viene messa in risalto rappresentando un ulteriore nicchia di interesse nel settore del mercato del turismo e più in generale, dei servizi destinati al turista. Il servizio che rendiamo alle aziende dell'Anglona, produrrà certamente delle conoscenze interessanti utili a capire la dinamica agricola imprenditoriale di un’a- rea in forte sviluppo economico. Il consolidarsi dei flussi agroturistici in questa parte dell’isola, oltretutto, potrà indubbiamente contribuire ad affermare definiti- vamente quel tanto auspicato rapporto tra turismo costiero e turismo interno che tanti operatori considerano indispensabile alla costante riorganizzazione economi- ca e sociale della Sardegna. -

Anglona Coros, Terre Di Tradizioni
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO Centro Regionale di Programmazione Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 15/INT Anglona Coros, Terre di Tradizioni Unione dei Comuni dell’Anglona e Unione dei Comuni del Coros della Bassa Valle del Coghinas Bulzi Osilo Cargeghe Ossi Chiaramonti Perfugas Codrongianos Ploaghe Erula Santa Maria Coghinas Florinas Putifigari Laerru Sedini Ittiri Tissi Martis Tergu Muros Uri Nulvi Olmedo Usini SOMMARIO 1. IL SOGGETTO PROPONENTE ........................................................................................................................... 3 1.1 ELENCO DEI COMUNI ADERENTI E RELATIVA UNIONE DI APPARTENENZA .................................................. 3 1.2 LE FUNZIONI FONDAMENTALI E I SERVIZI GESTITI IN ASSOCIAZIONE .......................................................... 4 1.3 NUOVE FUNZIONI E/O SERVIZI DA ASSOCIARE PER LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ....................... 5 2. IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO .................................................................................................................... 6 3. INFORMAZIONI GENERALI SUL PROCESSO ....................................................................................................22 3.1 ALTRI SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA DEFINIZIONE DEL PST ................................................. 22 3.2 I TAVOLI TEMATICI INDIVIDUATI ............................................................................................................... -

Golfo Dell'asinara
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE SCHEDA D’AMBITO N° 14 GOLFO DELL’ASINARA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SCHEDA AMBITO N. 14 GOLFO DELL’ASINARA Piano Paesaggistico Regionale – Ambiti di Paesaggio Scheda Ambito n 14 Golfo dell’Asinara 2 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DESCRIZIONE DELL’AMBITO STRUTTURA L’Ambito comprende i territori afferenti al Golfo dell’Asinara. L’apertura del golfo descrive un contesto territoriale che si apre e si relaziona in diverse forme con il sistema costiero. L’arco costiero è sottolineato dalla presenza di un sistema insediativo rappresentato dai centri di Stintino, Portotorres, Sassari (Platamona), Sorso (La Marina), Sennori, Castelsardo. Il sistema ambientale è dominato dal complesso della penisola di Stintino, dell’Isola Piana e dell’Asinara che costituiscono l’elemento di separazione fra i due “mari”, mare di dentro, interno al golfo, e mare di fuori, il mar di Sardegna. Nell’Isola dell’Asinara si identificano diversi paesaggi. Le piane di Campu Perdu e Trabuccato un tempo utilizzati come seminativi e in continuità le formazioni arbustive caratterizzate dalla consistente presenza dell’Euphorbia dendroides. Tra le specie arboree che occupano limitati ambiti, lungo la costa che raggiunge La Reale, si rilevano i ginepri e ad Elighe Mannu una formazione boschiva di lecci. La copertura vegetale dell’isola caratterizzata dalla presenza di piante endemiche ed associata ad una consistente presenza faunistica, risulta minacciata dal rilevante numero di specie di mammiferi allo stato brado. L’isola Piana, infine, presenta una copertura vegetale costituita essenzialmente da specie arbustive ed erbacee. È rilevante, lungo la costa e in relazione con il paesaggio dei pascolativi, la presenza degli ecosistemi degli stagni di Pino e Cesaraccio e la connessione tra il sistema delle dune e l’insediamento turistico del Bagaglino. -

Anglona. Quadro Tendenziale
1 MACROAREA DELL’ANGLONA: QUADRO TENDENZIALE 1 Tutti i confronti a livello provinciale proposti in questo documento si intendono riferiti all’attuale configurazione amministrativa della Provincia di Sassari Bilancio demografico Allo scopo di cogliere le diverse specificità e vocazioni del territorio, il processo di pianificazione strategica provinciale propone la ripartizione della provincia di Sassari in macroaggregazioni omogenee. In questo modo sono state individuate quattro macroaree: Sassarese, Anglona, Goceano-Monte Acuto e Meilogu. In particolare, la macroarea dell’Anglona comprende i Comuni di Bulzi, Castelsardo, Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Santa Maria Coghinas, Sedini, Tergu, Valledoria e Viddalba. La popolazione della macroarea all’1/1/2007 ammontava a 24.942 abitanti, pari al 7,43% del totale provinciale; la densità media è risultata di 45,3 abitanti per Kmq, valore inferiore sia al dato provinciale (circa 78 ab. per Kmq), che a quello regionale (69 ab. per Kmq). Come evidenziato dalla seguente figura, dal 2002 al 2007 la popolazione della macroarea è rimasta sostanzialmente stabile, con un aumento, in termini relativi, pari allo 0,6%. Figura 1 – Anglona - Popolazione residente, anni 2002 - 2007 28.000 27.000 26.000 25.000 24.000 23.000 22.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: ISTAT Gli incrementi della popolazione si registrano soprattutto nei comuni costieri di Castelsardo e Valledoria (i quali presentano densità molto elevate), e, in misura più limitata, in quelli di Santa Maria Coghinas e Tergu. -

Business Dynamics in North Sardinia Edition 2015
Data-processing (2014) th REPORT ON BUSINESS DYNAMICS IN4 NORTH SARDINIA EDITION 2015 Data-processing (2014) on database Unioncamere-Infocamere INTRODUCTION The study of business dynamics is one of the main sources of economics studies, providing structural information and data that allow to better understand the economic and social aspects of a territory. In fact, statistical surveys are not only instrument of knowledge for all users, but they are crucial tools for the decision makers in the public and private sectors, researchers and planners. One of the key functions of the Chambers of Commerce is actually the analysis of local economy data, providing enterprises with in-depth information of the socio-eco- nomic situation in the area. The Chamber of Commerce of North Sardinia monitors its economic system, in order to assist entrepreneurs in decision-making. Through its Statistical and Research Office, this Chamber of Commerce analyses social and economic phenomena publishing Statistical“ Indexes”, the “Survey on Business Dynamics” and the “Economic Survey of North Sardinia”. “Statistical Indexes” are quarterly updated, whereas the “Survey on Business Dynamics” and the “Economic Survey of North Sardinia” are annually published. The “Survey on Business Dynamics” focuses the attention on enterprises data, while the “Economic Survey of North Sardinia” takes into account many other economic and social aspects (such as agriculture and agro-industry, foreign trade, credit, national accounts, employment, manufacturing, services, etc...). The great performance of North Sardinia Comparing 2014 with the previous year, enterprises growth rate in North Sardinia has registered a +0,83% (the province of Sassari +0,37% and the province of Ol- bia-Tempio +1,52%), with 57.493 registered enterprises, of which 47.414 operating.