Le Motivazioni Della Sentenza
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Estratto Le Terre Dei Re
UN FANTASTICO ITINERARIO STORICO E ARCHITETTONICO TRA MEDIOEVO Itineraries E RINASCIMENTO A great historical and architectural tour trough the Middle Ages and Reinassance Le Terre dei Re DAI LONGOBARDI AI VISCONTI The Lands of Kings FROM THE LONGOBARDS TO THE VISCONTI LA PROVINCIA DI PAVIA, THE PROVINCE OF PAVIA, con la forza della qualità e della bellezza, ha selezionato Confident of the beauty of the territory and what it has con gli operatori del territorio 4 itinerari che favoriscono to offer visitors, the provincial authorities have joined with la scoperta di luoghi di grande attrattiva. various organisations operating in the area to draw up four itineraries that will allow travellers to discover intriguing Sono 4 itinerari che suggeriscono approcci diversi new destinations. e che valorizzano le diverse vocazioni di un territorio poco conosciuto e proprio per questo contraddistinto Four different itineraries that present the varied vocations da una freschezza tutta da scoprire. of a little-known territory just waiting to be discovered. Un turismo intelligente fruibile tutti i giorni dell’anno, Intelligent tourism accessible all year-round in the heart vissuto nel cuore del territorio lombardo, fra pianura, of Lombardy - ranging from the plains to the hills and the colline e Appennino, ideale per scoprire la storia, Appenine Mountains, a voyage into the history, the culture la cultura e la natura a pochi passi da casa. and the natural beauty that lies just around the corner. • VIGEVANO • MEDE • PAVIA • MIRADOLO TERME • MORTARA • LOMELLO -

FILE VENDITA DIRETTA Aggiornatox
LA VENDITA DIRETTA DEI NOSTRI PRODOTTI IMPRESE AGRICOLE PRODOTTO AGRICOLO INDIRIZZO COMUNE PROV. TELEFONO MAIL CONSEGNE FRUTTA E VERDURA ABBATE FRANCESCA CIPOLLA ROSSA BREME VIA PO 21 BREME PV 0384 77049 ADAMI IVONE PATRIZIO FRUTTA E VERDURA VIA TERESIO OLIVELLI 11 VIGEVANO PV 338 4465653 [email protected] AGRIBIO DI FILIPPINI ENRICA ORTAGGI FRESCHI FRAZ. GRAZZI 75/B ROMAGNESE PV 333 4319680 [email protected] AGRICORTI SS AGR. NOCI C.NA MARLENZONE PONTECURONE AL 0131 887213 [email protected] AZ.AGR. LA BIANCHINA DI CREMONESI ELISA FRUTTA,ORTICOLE,PIANTE AROMATICHE, FIORI EDIBILI LOC. TORRE BIANCHINA 3 BORGO PRIOLO PV 393 9053452 [email protected] AZIENDA LA CORTE DI GAROFALO ALESSIA FRUTTA,VERDURA, CONSERVE CASCINA CHIARABELLA BARBIANELLO PV 349 4314751 [email protected] NO BAZZANO CESARE FRUTTA, VERDURA, CONFETTURA VIA MORTARA 78 - F.NE REMONDO' GAMBOLO' PV 333 8086282 [email protected] CAMPANINI GIAN PAOLO ZUCCHE VIA CANNOBBIO 8 LUNGAVILLA PV 334 3556661 [email protected] CHIOSSA LUIGI ZUCCA BIOLOGICA VIA UMBERTO I 694 LUNGAVILLA PV 0383 76001 [email protected] CIGNOLI ANDREA FRUTTA, SUINI VIA SAN ROCCO ARENA PO PV 335 7764763 [email protected] SI BREGA NICOLA FRUTTA E VERDURA VIA ALBERICIA CAMPOSPINOSO PV 0385 277534 [email protected] SI FARAVELLI PAOLO LUIGI DIEGO FRUTTA FRAZ. SORIASCO SANTA MARIA DELLA VERSA PV 347 2927327 [email protected] NO FRIGERIO FRANCESCO FRUTTA,VERDURA, CONSERVE, RISO VIA ALAGNA 70/3 GARLASCO PV 339 7765477 [email protected] -

Elenco Comuni Lombardia – Classificazione Istat Zona Altimetrica
ELENCO COMUNI LOMBARDIA – CLASSIFICAZIONE ISTAT ZONA ALTIMETRICA Provincia Codice ISTAT Denominazione Comune Zona altimetrica ISTAT Comune Comune Bergamo 016001 Adrara San Martino Montagna Bergamo 016002 Adrara San Rocco Montagna Bergamo 016003 Albano Sant'Alessandro Collina Bergamo 016004 Albino Montagna Bergamo 016005 Almè Collina Bergamo 016006 Almenno San Bartolomeo Collina Bergamo 016007 Almenno San Salvatore Collina Bergamo 016008 Alzano Lombardo Collina Bergamo 016009 Ambivere Collina Bergamo 016010 Antegnate Pianura Bergamo 016011 Arcene Pianura Bergamo 016012 Ardesio Montagna Bergamo 016013 Arzago d'Adda Pianura Bergamo 016014 Averara Montagna Bergamo 016015 Aviatico Montagna Bergamo 016016 Azzano San Paolo Pianura Bergamo 016017 Azzone Montagna Bergamo 016018 Bagnatica Pianura Bergamo 016019 Barbata Pianura Bergamo 016020 Bariano Pianura Bergamo 016021 Barzana Collina Bergamo 016022 Bedulita Montagna Bergamo 016023 Berbenno Montagna Bergamo 016024 Bergamo Collina Bergamo 016025 Berzo San Fermo Montagna Bergamo 016026 Bianzano Montagna Bergamo 016027 Blello Montagna Bergamo 016028 Bolgare Pianura Bergamo 016029 Boltiere Pianura Bergamo 016030 Bonate Sopra Pianura Bergamo 016031 Bonate Sotto Pianura Bergamo 016032 Borgo di Terzo Montagna Bergamo 016033 Bossico Montagna Bergamo 016034 Bottanuco Pianura Bergamo 016035 Bracca Montagna Bergamo 016036 Branzi Montagna Bergamo 016037 Brembate Pianura Bergamo 016038 Brembate di Sopra Pianura Bergamo 016040 Brignano Gera d'Adda Pianura Bergamo 016041 Brumano Montagna Bergamo 016042 Brusaporto -

Comune Di Miradolo Terme
COMUNE DI MIRADOLO TERME PROVINCIA DI PAVIA PGT Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n 12 6 DdP Documento di Piano IL PAESAGGIO ED IL RAPPORTO Fascicolo CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del SINDACO PROGETTISTA Gianpaolo Troielli dott. arch. Mario Mossolani COLLABORATORI dott. urb. Sara Panizzari dott. Ing. Giulia Natale SEGRETARIO dott. ing. Marcello Mossolani Dott. Flavia Fulvio geom. Mauro Scano TECNICO COMUNALE Geom. Orazio Pacella STUDI NATURALISTICI dott. Massimo Merati dott. Niccolò Mapelli STUDIO MOSSOLANI urbanistica architettura ingegneria via della pace 14 – 27045 casteggio (pavia) - tel. 0383 890096 - telefax 0383 82423 – www.studiomossolani.it PGT del Comune di Miradolo Terme PAESAGGIO COMUNE DI MIRADOLO TERME Provincia di Pavia PGT Piano di Governo del Territorio DOCUMENTO DI PIANO Il Paesaggio INDICE 1..PAESAGGIO: RIFERIMENTI NORMATIVI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ..................................................................................................... 8 1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................................. 8 1.2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO .......................................................................... 9 PARTE I IL PIANO DEL PAESAGGIO DI MIRADOLO TERME SECONDO LE INDICAZIONI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE ..................... 11 2..IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE PPR ............................................... 12 2.1. CONTENUTI DEL PPR ...................................................................................... -

Sample Deliverables 17 Pilot Applications
SAMPLE DELIVERABLES 17 PILOT APPLICATIONS Grant agreement No: SSH - CT - 2007 - 217565 Project Acronym: SAMPLE Project Full title: Small Area Methods for Poverty and Living Conditions Estimates Funding Scheme: Collaborative Project - Small or medium scale focused research project Deliverable n.: D17 Deliverable name: Pilot applications WP n.: 2 Lead Beneficiary: 1, 5 Nature: Report Dissemination level: PU Status: Final Due delivery date: September 30th, 2010 Actual delivery date: November 16th, 2010 Project co-ordinator name: Monica Pratesi Title: Associate Professor of Statistics - University of Pisa Organization: Department of Statistics and Mathematics Applied to Economics of the University of Pisa (UNIPI-DSMAE) Tel.: +39-050-2216252, +39-050-2216492 Fax: +39-050-2216375 E-mail: [email protected] Project website address: www.sample-project.eu PILOT APPLICATIONS Project Acronym: SAMPLE Project Full title: Small Area Methods for Poverty and Living Conditions Estimates Project/Contract No: EU-FP7-SSH-2007-1 Grant agreement No: 217565 Work Package 2: Small area estimation of poverty and inequality indicators Document title: Pilot applications Date: October 30th, 2010 Type of document: Deliverable D17 Status: Final Editors: I. Molina, D. Morales, M. Pratesi and N. Tzavidis Authors: Monica Pratesi ([email protected]), UNIPI-DSMAE Caterina Giusti ([email protected]), UNIPI-DSMAE Stefano Marchetti ([email protected]fi.it), UNIPI-DSMAE Nicola Salvati ([email protected]), UNIPI-DSMAE Nikos Tzavidis ([email protected]), -

PRINCIPALI TIPOLOGIE IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI - Anno 2016
PRINCIPALI TIPOLOGIE IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI - Anno 2016 Cassolnovo Gravellona Lomellina Confienza Siziano Cilavegna Vigevano Casorate Primo Landriano Bascape' Robbio XW Palestro Rognano Alb$+onese Vidigulfo Nicorvo Trovo Parona " A@ ) Giussago Torrevecchia Pia BattudaVellezzo Bellini Bornasco Castelnovetto Trivolzio Zeccone Gambolo' ! Ceranova Rosasco Bereguardo Ceretto Lomellina MarcignagoCertosa di Pavia Marzano Mortara Borgo San Siro Sant'angelo Lomellina ! Borgarello Lardirago San Genesio Ed Uniti Torre d'Arese Castello d'Agogna Roncaro Villanterio Torre d'Isola Sant'alessio Con Vialone Langosco Magherno Zerbolo' Cozzo Tromello Vistarino Olevano di Lomellina Cura Carpignano Garlasco Gerenzago Cergnago Pavia Copiano Inverno E Monteleone Zeme Albuzzano A@*# Filighera Candia Lomellina San Giorgio di Lomellina Gropello Cairoli Carbonara Al Ticino Miradolo Terme Valle Salimbene XW$+ Alagna Villanova d'Ardenghi Corteolon$+a e Genzone Velezzo Lomellina San Martino Siccomario Valle Lomellina Ottobiano Santa Cristina E Bissone Linarolo ! Valeggio Dorno )"* Travaco' Siccomario Chignolo Po BelgioiosoTorre De'Negri Semiana Costa De' Nobili Breme Scaldasole Zinasco Mezzanino Monticelli Pavese Cava Manara Badia Pavese Lomello Sommo Spessa Rea Albaredo Arnaboldi Verrua Po San Zenone Al Po Monticelli Pavese San Cipriano Po Zerbo Sartirana Lomellina Ferrera Erbognone Pieve Albignola Pieve Porto Morone Mezzana Rabattone Mede Sannazzaro De'Burgondi Bastida Pancarana Portalbera Galliavola Pancarana Casanova LonatiCampospinoso Villa Biscossi Silvano -

Infrastrutture Di Mobilità in Provincia Di Pavia: Opere Strategiche E ‘Costi Del Non Fare’
Confindustria Pavia | Università di Pavia Indagine 2018 sulle Infrastrutture di Mobilità in Provincia di Pavia: opere strategiche e ‘costi del non fare’ Stefano Denicolai Federico Montagna Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali Università degli Studi di Pavia 1 Indice 1. OBIETTIVI E METODOLOGIA ................................................................................................... 3 2. LO STATO DELLE INFRASTRUTTURE IN PROVINCIA DI PAVIA ................................... 5 2.1. LA DOTAZIONE DI INFRASTRUTTURE: SGUARDO D’INSIEME ........................................................... 5 2.2. LA DOMANDA DI INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ .......................................................................... 10 2.3. APPROFONDIMENTO: LA “QUESTIONE PONTI” ............................................................................... 14 2.3.1. OVERVIEW DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AI PONTI DEL TERRITORIO ....................................................... 14 2.3.2. IL PONTE DELLA BECCA ........................................................................................................................................... 15 2.3.3. IL PONTE DI BRESSANA ............................................................................................................................................ 17 2.3.4. IL PONTE DI GEROLA ................................................................................................................................................ 17 2.3.5. IL PONTE DI PIEVE PORTO MORONE .................................................................................................................... -

Comuni Serviti Da Pavia Acque Comune Acquedotto Fognatura
Comuni serviti da Pavia Acque Comune Acquedotto Fognatura ALAGNA SERVITO SERVITO ALBAREDO ARNABOLDI SERVITO SERVITO ALBONESE SERVITO SERVITO ALBUZZANO SERVITO SERVITO ARENA PO SERVITO SERVITO BADIA PAVESE SERVITO SERVITO BAGNARIA SERVITO SERVITO BARBIANELLO SERVITO SERVITO BASCAPE' SERVITO SERVITO BASTIDA PANCARANA SERVITO SERVITO BATTUDA SERVITO SERVITO BELGIOIOSO SERVITO SERVITO BEREGUARDO SERVITO SERVITO BORGARELLO SERVITO SERVITO BORGO PRIOLO SERVITO SERVITO BORGO SAN SIRO SERVITO SERVITO BORGORATTO MORMOROLO SERVITO SERVITO BORNASCO SERVITO SERVITO BOSNASCO SERVITO SERVITO BRALLO DI PREGOLA SERVITO SERVITO BREME SERVITO SERVITO BRESSANA BOTTARONE SERVITO SERVITO BRONI SERVITO SERVITO CALVIGNANO SERVITO SERVITO CAMPOSPINOSO SERVITO SERVITO CANDIA LOMELLINA SERVITO SERVITO CANNETO PAVESE SERVITO SERVITO CARBONARA AL TICINO SERVITO SERVITO CASANOVA LONATI SERVITO SERVITO CASATISMA SERVITO SERVITO CASEI GEROLA SERVITO SERVITO CASORATE PRIMO SERVITO SERVITO CASSOLNOVO SERVITO SERVITO CASTANA SERVITO SERVITO CASTEGGIO SERVITO SERVITO CASTELLETTO DI BRANDUZZO SERVITO SERVITO CASTELLO D'AGOGNA SERVITO SERVITO CASTELNOVETTO SERVITO SERVITO CAVA MANARA SERVITO SERVITO CECIMA SERVITO SERVITO CERANOVA SERVITO SERVITO CERETTO LOMELLINA SERVITO SERVITO CERGNAGO SERVITO SERVITO CERTOSA DI PAVIA SERVITO SERVITO CERVESINA SERVITO SERVITO CHIGNOLO PO SERVITO SERVITO CIGOGNOLA SERVITO SERVITO Comune Acquedotto Fognatura CILAVEGNA SERVITO SERVITO CODEVILLA SERVITO SERVITO COLLI VERDI (ex Canevino, Ruino, Valverde) SERVITO SERVITO CONFIENZA SERVITO SERVITO -

Per Il Curriculum Vitae
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome CROPANO GIULIA Indirizzo Telefono Fax E-mail Nazionalità Data di nascita 04/07/1980 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (dal 01.06.2016 ad oggi) Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Tribiano (MI) e Belgioioso (PV) (da novembre 2015 – al 31.05.2016 ) Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Castelnuovo Bocca d’Adda; Meleti e Maccastorna (LO). Responsabile dell’Area Amministrazione Generale del Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO) (Dal 01.05.2016 al 31.05.2016) Segretario comunale reggente dei Comuni di Tribiano (MI) e Belgioioso (PV) (da maggio 2015 a novembre) Segretario comunale reggente del Comune di Landriano (PV) Responsabile dell’Area Amministrazione Generale del Comune di Landriano (PV) Segretario comunale reggente del Comune di Magherno (PV) (da ottobre 2015 a febbraio 2016) Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Spessa; (da gennaio 2014 a settembre 2014) Costa de’ Nobili e Zerbo (PV). Responsabile del Servizio Personale del Comune di Spessa (PV) Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Mezzanino; Spessa e Barbianello (PV). (da dicembre 2011 a dicembre 2013) Responsabile del Servizio Personale del Comune di Spessa (PV) Segretario comunale supplente del Comune di Bressana Bottarone (PV) Segretario comunale reggente del Comune di Pietra de’ Giorgi (PV) (dal 2011 al 2014 ) Segretario comunale -

27047 MONTECALVO VERSIGGIA (PV) - Italy Tel
Nello stesso periodo risale una "leggenda" che ha come sfondo il castello, riportata da Alberto Carlo Pisani Dossi, nipote di Luigia e Carlo Pisani, letterato di fama e diplomatico, nato a Zenevredo nel 1849. "I miei vecchi avevano non solo la debolezza di bere molte bottiglie di vino, ma di riporne rilevanti quantità in nascondigli. A Montecalvo dura tuttora la tradizione che Donna Luigia, moglie del nonno, abbia fatto murare ne' sotterranei del castello 10.000 bottiglie di moscato bianco." Qualche anno prima lo stesso episodio era però stato raccontato in un'altra versione: diverso il vino in questione e, soprattutto, molto inferiore il numero delle bottiglie nascoste. "Mi racconta il prevosto di Soriasco che Donna Luigia, quando dovette abbandonare il castello al marito, fece nascondervi e murare in un sotterraneo 2.000 bottiglie di Malvasia eccellente." Dai Pisani Dossi la proprietà del castello passò ai marchesi Brignole di Genova. E' a questo periodo che risale una descrizione di Cavagna Sangiuliani. "Vecchio e da lunga mano disabitato castello s'alza a pochi passi da questa piazza, sull'eminenza della collina che sovrasta il paesello. Una lunga e spaziosa terrazza, sostenuta da grosse ed alte muraglie, e alcune basse torri fiancheggiano il maschio del castello, che più ha aspetto di signorile e grandioso palagio medioevale, che foggia di rocca feudale; ad ogni buon conto i grossi mattoni, rossi, compatti, solidissimi, della forma e della cottura oggigiorno obliata, e le formidabili mura che gli girano intorno gli danno altezzosa forza, burbanzosa imponenza. Questo castello che fece parte dell'antico feudo dei Beccaria e poi di quello dei Belcredi.. -
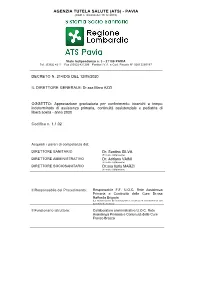
214 DC2020 Con Allegati.Pdf
AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR n. X/4469 del 10.12.2015) Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187 DECRETO N. 214/DGi DEL 12/05/2020 IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI OGGETTO: Approvazione graduatoria per conferimento incarichi a tempo indeterminato di assistenza primaria, continuità assistenziale e pediatria di libera scelta - anno 2020 Codifica n. 1.1.02 Acquisiti i pareri di competenza del: DIRETTORE SANITARIO Dr. Santino SILVA (Firmato digitalmente) DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Adriano VAINI (Firmato digitalmente) DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Ilaria MARZI (Firmato digitalmente) Il Responsabile del Procedimento: Responsabile F.F. U.O.C. Rete Assistenza Primaria e Continuità delle Cure Dr.ssa Raffaella Brigada (La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso) Il Funzionario istruttore: Collaboratore amministrativo U.O.C. Rete Assistenza Primaria e Continuità delle Cure Franco Brasca L'anno 2020 addì 12 del mese di Maggio IL DIRETTORE GENERALE Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni; Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"; Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. -

Salice Terme Tel.0383/944916 Fax.0383/934583 [email protected] Tutti I Diritti Sono Riservati
Anno 8 - N° 85 Seguici anche su Novembre 2014 Facebook 20.000 COPIE e sul sito www.ilperiodiconews.it Terme di Salice: da S.p.A. a S.r.l. Cambia l'assetto societario Bassanese all'attacco della giunta Barbieri Bressana: la fontana della discordia La Versa: la salvezza Allarme in Oltrepo arriva da Brescia? dopo il maltempo: la Provincia sotto accusa Ospedali di Varzi e Stradella Maroni assicura: stop alla chiusura e via al potenziamento news il Periodico EDITORE DIRETTORE RESPONSABILE ALESSANDRO DISPERATI [email protected] Responsabile P.R. ORNELLA REPETTI [email protected] Direzione, redazione, amministrazione, grafica, marketing, pubblicità Viale delle Terme N° 97 27052 Godiasco Salice Terme tel.0383/944916 fax.0383/934583 www.ilperiodiconews.it [email protected] Tutti i diritti sono riservati. E’ vietata la riproduzione, di testi e foto. STAMPA: San Biagio Stampa S.p.A. - Genova Registrazione presso il Tribunale di Voghera N. 178 del 31/03/2011 Distribuzione Gratuita il Periodico 2 NOVEMBRE 2014 il Periodico 3 NOVEMBRE 2014 Sindaci Oltrepo, saper vincere e avere il TERZA PAGINA coraggio delle proprie azioni. Siamo in molti casi malmessi, purtroppo per noi! COMMENTO DI ANTONIO LA TRIPPA In Oltrepo dopo le ultime primaverili elezioni comu- nali, in molti comuni sono stati confermati i vecchi sindaci ed amministratori, in altri ne sono stati eletti nuovi, non tutti necessariamente "nuovi", alcuni sono cavalli di ritorno ed in questo non ci vedo nulla di male, sono le regole della democrazia. Quello che mi sembra invece non molto corretto è l'atteggiamento di molti che hanno vinto e di molti che hanno perso, evidentemente essendo su due fronti contrapposti ave- vavo ed hanno, si spera, idee diverse, ma quello che lascia perplessi è il loro modo di esternarli.