N. 95 Il Summit Per La Democrazia Di Joe Biden
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
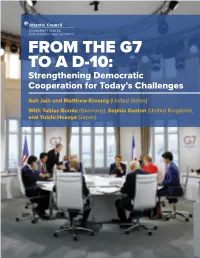
FROM the G7 to a D-10: Strengthening Democratic Cooperation for Today’S Challenges
FROM THE G7 TO THE D-10 : STRENGTHENING DEMOCRATIC COOPERATION FOR TODAY’S CHALLENGES FROM THE G7 TO A D-10: Strengthening Democratic Cooperation for Today’s Challenges Ash Jain and Matthew Kroenig (United States) With Tobias Bunde (Germany), Sophia Gaston (United Kingdom), and Yuichi Hosoya (Japan) ATLANTIC COUNCIL A Scowcroft Center for Strategy and Security The Scowcroft Center for Strategy and Security works to develop sustainable, nonpartisan strategies to address the most important security challenges facing the United States and the world. The Center honors General Brent Scowcroft’s legacy of service and embodies his ethos of nonpartisan commitment to the cause of security, support for US leadership in cooperation with allies and partners, and dedication to the mentorship of the next generation of leaders. Democratic Order Initiative This report is a product of the Scowcroft Center’s Democratic Order Initiative, which is aimed at reenergizing American global leadership and strengthening cooperation among the world’s democracies in support of a rules-based democratic order. The authors would like to acknowledge Joel Kesselbrenner, Jeffrey Cimmino, Audrey Oien, and Paul Cormarie for their efforts and contributions to this report. This report is written and published in accordance with the Atlantic Council Policy on Intellectual Independence. The authors are solely responsible for its analysis and recommendations. The Atlantic Council and its donors do not determine, nor do they necessarily endorse or advocate for, any of this report’s conclusions. © 2021 The Atlantic Council of the United States. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission in writing from the Atlantic Council, except in the case of brief quotations in news articles, critical articles, or reviews. -

Transatlantic Collective Identity in A
THE TRANSATLANTIC RELATIONSHIP AND THE FUTURE GLOBAL GOVERNANCE ISSN 2281-5252 WORKING PAPER 45 | OCTOBER 2014 Social constructivists have always thought of September 11, 2001, reveals that the repre- NATO as the institutionalization of the trans- sentatives of NATO member states often voice atlantic security community, based quite different understandings of their on a collective identity of a collective identity. While there community of liberal is still a lot of agreement democracies. Unfor- among the speakers, the tunately, most re- debates also reflect searchers have Transatlantic Collective a heterogeneous just postulated “identity terrain”, this collec- shaped by diverg- tive iden- Identity in a Nutshell. ing conceptions tity without of constitutive studying its Debating Security Policy norms, differ- content and ent interpreta- contestation tions of NATO’s in detail. An at the Munich Security purpose, various analysis of the interpretations speeches given Conference (2002-2014) of its relationship at the annual with other actors, Munich Security and diverse cogni- Conference, often Tobias Bunde tive models concerning dubbed the “transat- diplomacy and the use of lantic family meeting”, since force. THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION’S SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION UNDER GRANT AGREEMENT NO 290454 T ransatlantic Collective Identity in a Nutshell Debating Security Policy at the Munich Security Conference (2002-2014) Tobias Bunde* NATO Security Elites Summits Transatlantic relations Introduction Social constructivists have long argued that the transatlantic security partnership and its institutional embodiment, the North Atlantic Treaty Organization (NATO), are more than just another military alliance based on common interests. Instead, it should be considered as a “security community” built on a shared collective identity (Risse-Kappen 1996, Gheciu 2005). -

Personal Invitation to the Inaugural Copenhagen Democracy Summit, June 22, 2018
12 June 2018 Personal invitation to the inaugural Copenhagen Democracy Summit, June 22, 2018 Dear Gregory Miller, It is my great pleasure to invite you to attend the inaugural Copenhagen Democracy Summit on June 22, 2018. Located at the scenic Royal Danish Playhouse in Central Copenhagen, the Summit will gather business executives and political leaders from the world’s democracies to discuss the future of democracy, trade, and technology. Organized by the Alliance of Democracies Foundation, the annual Copenhagen Democracy Summit will help build stronger interpersonal links between key leaders, binding the world’s democracies closer together politically, economically, and culturally. Limited to a select group of 250 participants, the Summit offers top-level networking opportunities in an intimate and intellectually vibrant atmosphere during Denmark’s beautiful midsummer season. Confirmed speakers include: - Joe Biden, former Vice President, United States - Felipe Calderon, former President of Mexico - Jose Maria Aznar, former Prime Minister of Spain - Stephen Harper, former Prime Minister of Canada - Nick Clegg, former Deputy Prime Minister of the United Kingdom - Lars Løkke Rasmussen, Prime Minister of Denmark The post-World War II international order based on democracy and free trade has come under increasing pressure in recent years from rising autocracies and terrorist organizations. Many of the world’s leading democracies are marred by self-doubt and internal divisions amplified by blatant Copenhagen · Denmark · [email protected] © ALLIANCE OF DEMOCRACIES FOUNDATION 2018 12 June 2018 election interference, misinformation and manipulation by antidemocratic forces. At this time, it is critical to renew our faith in democracy and develop new commercial links between our nations. -

Project Associate with the Alliance of Democracies Foundation
Project Associate with the Alliance of Democracies Foundation Position: Project Associate (freelance position) Period: February to October 2021 Location: Berlin Are you a young professional within the field of politics, communications, international relations, or similar, looking for a hands-on job experience tackling one of global democracy’s most pressuring challenges? Do you agree that foreign election interference is a major threat to the universal right of people to take part in democratic processes? Then apply for this position as Project Associate with the Alliance of Democracies Foundation (AoD). About the Alliance of Democracies The Alliance of Democracies Foundation is a non-profit organization founded in 2017 by Anders Fogh Rasmussen, former NATO Secretary General and Prime Minister of Denmark. The Foundation is dedicated to the advancement of democracy and free markets across the globe and runs three programs: • The Campaign for Democracy: A campaign that engages supporters of democracy worldwide and builds a powerful intellectual movement for the cause of democracy. One of the campaign’s flagships is the Transatlantic Commission on Election Integrity, which seeks to fill a critical gap by fostering a global and collective approach to curb the ongoing wave of election interference and raises awareness of public and governments about the risks of disinformation and election meddling. • The Copenhagen Democracy Summit: An annual conference bringing together political and business leaders in the Royal Danish Playhouse, including heads of government, from the world’s democracies. Previous year’s summits have featured, among many others, Joe Biden, Tony Blair, Felipe Calderón, Mike Pompeo, Tsai Ing-Wen, Joshua Wong, and Brad Smith. -

Anders Fogh Rasmussen, Former NATO Secretary General and Prime Minister of Denmark
Testimony to House Intelligence Committee By Anders Fogh Rasmussen, former NATO Secretary General and Prime Minister of Denmark Chairman Schiff, Ranking Member Nunes and esteemed Members of the Committee, thank you for the invitation to offer my thoughts for this hearing on ‘Autocracy’s Advance and Democracy’s Decline’. I have dedicated my political life to promoting freedom and democracy. And to advocating the benevolent force of a US-led Western Alliance. An Alliance that united to defeat the tyrannies of Nazism and Communism. However, tyranny is once again awaking from its slumber. Last year my foundation, the Alliance of Democracies, produced the single biggest international survey of attitudes towards democracy. It found that people in autocracies are more satisfied with their governments than those living in democracies. It is high time for the world’s democracies to come together and fight back against autocracy. If the free world fails to unite against the autocratic challenge, the personal and economic liberties that we often take for granted today will slowly but surely decline in the coming years. After the fall of communism, many people, including myself, were hoping to see China and Russia become part of the free world. We must now conclude that the opposite has happened. China and Russia have descended back into autocracy and become openly hostile geopolitical rivals of the world’s democracies. Autocracies like Russia and China are systematically seeking to undermine our political systems. They exploit and abuse economic relationships, building elaborate debt traps and energy dependencies. They use covert influence to disturb our politics and undermine trust and confidence in our democratic institutions. -

Disinformation, Deepfakes & Democracy
Disinformation, Deepfakes & Democracy The European response to election interference in the digital age #DefendDemocracy 2 About the publication & author This report has been written by Christoffer Waldemarsson and published by The Alliance of Democracies Foundation on April 27th 2020 as a contribution to the continuous work of the Foundation, including the activities of the Transatlantic Commission on Election Integrity and its mission to highlight the issue of foreign election interference and protect the integrity of democratic elections. The report and its recommendations reflect the opinions of the author. Christoffer Waldemarsson holds a Bachelor of Science in Economics and Political Science from Lund University and a Master of Science in International Business and Politics from Copenhagen Business School. With a background in the Swedish Ministry for Foreign Affairs and the Nordic Council of Ministers, he has previously published reports on the state of democracy in the Nordic countries and academic articles on what effect democracy has on economic growth. Christoffer Waldemarsson is working at the Alliance of Democracies Secretariat in Copenhagen. The Alliance of Democracies Foundation The Alliance of Democracies Foundation is a non-profit organization founded in 2017 by former Danish Prime Minister and NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen, dedicated to the advancement of democracy and free markets across the globe. With a rising scepticism towards free and liberal values and a retreat in American global leadership, the foundations aims to become the world’s leading “megaphone” for the cause of democracy and to encourage greater cooperation between nations who share common values, to counter spoilers and support those who wish to bring more democracy to their countries. -

Transatlantic Collective Identity in a Nutshell Debating Security Policy at the Munich Security Conference (2002-2014)
THE TRANSATLANTIC RELATIONSHIP AND THE FUTURE GLOBAL GOVERNANCE ISSN 2281-5252 WORKING PAPER 45 | OCTOBER 2014 Social constructivists have always thought of September 11, 2001, reveals that the repre- NATO as the institutionalization of the trans- sentatives of NATO member states often voice atlantic security community, based quite different understandings of their on a collective identity of a collective identity. While there community of liberal is still a lot of agreement democracies. Unfor- among the speakers, the tunately, most re- debates also reflect searchers have Transatlantic Collective a heterogeneous just postulated “identity terrain”, this collec- shaped by diverg- tive iden- Identity in a Nutshell. ing conceptions tity without of constitutive studying its Debating Security Policy norms, differ- content and ent interpreta- contestation tions of NATO’s in detail. An at the Munich Security purpose, various analysis of the interpretations speeches given Conference (2002-2014) of its relationship at the annual with other actors, Munich Security and diverse cogni- Conference, often Tobias Bunde tive models concerning dubbed the “transat- diplomacy and the use of lantic family meeting”, since force. THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION’S SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION UNDER GRANT AGREEMENT NO 612782 Transatlantic Collective Identity in a Nutshell Debating Security Policy at the Munich Security Conference (2002-2014) Tobias Bunde* NATO Security Elites Summits Transatlantic relations Introduction Social constructivists have long argued that the transatlantic security partnership and its institutional embodiment, the North Atlantic Treaty Organization (NATO), are more than just another military alliance based on common interests. Instead, it should be considered as a “security community” built on a shared collective identity (Risse-Kappen 1996, Gheciu 2005). -
Internship at the Alliance of Democracies Foundation
Internship at the Alliance of Democracies Foundation Position: Junior Analyst (full-time internship) Period: August 17 to December 31, 2020 Location: Copenhagen Are you a student within the field of politics, communications, international relations, or similar, looking for a hands-on learning experience to supplement your studies? Are you eager to promote democracy and free markets across the world, and are you a hardworking and talented individual? Then apply for this position as Junior Analyst (fall term) at the Alliance of Democracies Foundation. About the Alliance of Democracies The Alliance of Democracies Foundation is a non-profit organization founded in 2017 by Anders Fogh Rasmussen, the former NATO Secretary General and former Prime Minister of Denmark. The Foundation is dedicated to the advancement of democracy and free markets across the globe and runs three programs: • The Copenhagen Democracy Summit: An annual conference bringing together political and business leaders in the Royal Danish Playhouse, including heads of government, from the world’s democracies. Previous year’s summits have featured, among many others, Joe Biden, Tony Blair, and Felipe Calderón. • The Expeditionary Economics Program: A program that supports successful entrepreneurial projects in emerging democracies and post-conflict areas • The Campaign for Democracy: A campaign that engages supporters of democracy worldwide and builds a powerful intellectual movement for the cause of democracy. The campaign also comprises the Transatlantic Commission on Election Integrity, working to prevent the next wave of election interference and the new technological challenges facing democracy. About the position As Junior Analyst at the Alliance of Democracies Foundation, you will work alongside the team in Copenhagen. -

Alliance of Democracies Foundation, Fond Annual
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Phone 36 10 20 30 Fax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Alliance of Democracies Foundation, Fond Bredgade 71, 1st floor right 1260 Copenhagen K Business Registration No 39209349 Annual report 21.12.2017 - 31.12.2018 The Board of Directors adopted the annual report on 13.05.2019 Chairman of the Board of Directors Name: Anders Fogh Rasmussen Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Alliance of Democracies Foundation, Fond Contents Page Entity details 1 Statement by Management on the annual report 2 Independent auditor's report 3 Management commentary 6 Income statement for 2017/18 13 Balance sheet at 31.12.2018 14 Statement of changes in equity for 2017/18 16 Notes 17 Accounting policies 18 niandersen/9.05.2019 - 13:11/W.8.0.1 EMS/MStC_C Selskaber/E.18.2019 /ERST: W /Status II: * Alliance of Democracies Foundation, Fond 1 Entity details Entity details Entity Alliance of Democracies Foundation, Fond Bredgade 71, 1st floor right 1260 Copenhagen K Central Business Registration No (CVR): 39209349 Registered in: Copenhagen Financial year: 21.12.2017 - 31.12.2018 Board of Directors Anders Fogh Rasmussen, Chairman Fritz Henrik Schur Klaus Søgaard Auditors Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Alliance of Democracies Foundation, Fond 2 Statement by Management on the annual report Statement by Manage ment o n the annual report The Board of Directors has today considered and approved the annual report of Alliance of Democracies Foundation, Fond for the financial year 21.12.2017 - 31.12.2018. -

Rptr Foradori Edtr Humke National Security
1 RPTR FORADORI EDTR HUMKE NATIONAL SECURITY IMPLICATIONS OF THE RISE OF AUTHORITARIANISM Tuesday, February 26, 2019 U.S. House of Representatives, Permanent Select Committee on Intelligence, Washington, D.C. The committee met, pursuant to call, at 10:00 a.m., in room 210, Cannon House Office Building, the Honorable Adam Schiff (chairman of the committee) presiding. Present: Representatives Schiff, Himes, Sewell, Carson, Speier, Quigley, Swalwell, Castro, Heck, Welch, Maloney, Demings, Nunes, Conaway, Turner, Wenstrup, Stewart, Crawford, Stefanik, Hurd, and Ratcliff. 2 The Chairman. The committee will come to order. Before we begin, I want to remind all of our members that we are in open session, and as such, we will discuss unclassified matters only. Without objection, the chair may declare a recess at any time. I want to welcome our members and this panel of esteemed witnesses to the committee's first open hearing of the new Congress. When the Berlin Wall fell in late 1989, followed 2 years later by the demise of the Soviet Union, it seemed that the enlightenment ideals that animated the birth of the Nation, democracy, equality, and Jefferson's unalienable rights had finally triumphed. As the academic, Francis Fukuyama, put it then, we had reached the end of history and liberal democracy represented an end to ideology and presaged a new era of political harmony. As humanity's bloodiest century drew to a close, a century that had seen two cataclysmic wars and titanic ideological struggles between Fascism and democracy, between Soviet communism and capitalism, between colonialism and self-determination, the optimism of the 1990s was understandable. -

Anders Fogh Rasmussen – Chairman, Rasmussen Global and Former Secretary General, NATO
Anders Fogh Rasmussen – Chairman, Rasmussen Global and former Secretary General, NATO Anders Fogh Rasmussen has been at the centre of European and global politics for three decades as Secretary General of NATO, Prime Minister of Denmark, Danish Minister of Economic Affairs, Danish Minister for Taxation and a leading Danish parliamentarian. During the Danish Presidency of the European Union in 2002, he played a key role in concluding accession negotiations with 10 candidates for EU- membership. In 2009 Anders Fogh Rasmussen was appointed NATO’s 12th Secretary General between 1 August 2009 and 30 September 2014. His tenure in NATO marked a fundamental transformation of the Alliance. He oversaw the Alliance’s operational peak with six operations on three continents including Afghanistan, Kosovo and Libya, as well as counter-piracy along the Somali coast, a training mission in Iraq and a counter-terrorism operation in the Mediterranean. He developed a new Strategic Concept, which sets the Alliance’s core future priorities and he launched “Smart Defence” to help nations make more efficient use of their resources through more multinational cooperation. In response to Russia’s aggression against Ukraine, he initiated a “Readiness Action Plan” to strengthen the collective defence to an unprecedented level since the end of the Cold War. On 1 October 2014, Anders Fogh Rasmussen established Rasmussen Global. The firm advises clients on a wide range of issues such as international security, transatlantic relations, the European Union, and emerging markets. Rasmussen Global draws on an extensive network of leading policy experts, former officials, business executives and consulting firms across the globe. -

U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress
U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress Updated January 19, 2021 Congressional Research Service https://crsreports.congress.gov R44891 SUMMARY R44891 U.S. Role in the World: Background and Issues January 19, 2021 for Congress Ronald O'Rourke The U.S. role in the world refers to the overall character, purpose, or direction of U.S. Specialist in Naval Affairs participation in international affairs and the country’s overall relationship to the rest of the world. The U.S. role in the world can be viewed as establishing the overall context or framework for U.S. policymakers for developing, implementing, and measuring the success of U.S. policies and actions on specific international issues, and for foreign countries or other observers for interpreting and understanding U.S. actions on the world stage. While descriptions of the traditional U.S. role in the world since the end of World War II vary in their specifics, it can be described in general terms as consisting of four key elements: global leadership; defense and promotion of the liberal international order; defense and promotion of freedom, democracy, and human rights; and prevention of the emergence of regional hegemons in Eurasia. The issue for Congress is whether the U.S. role in the world has changed, and if so, what implications this might have for the United States and the world. A change in the U.S. role could have significant and even profound effects on U.S. security, freedom, and prosperity. It could significantly affect U.S. policy in areas such as relations with allies and other countries, defense plans and programs, trade and international finance, foreign assistance, and human rights.