In Questo Numero
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CALIFORNIA DEPARTMENT of INSURANCE Holocaust Era
CALIFORNIA DEPARTMENT OF INSURANCE Source: AXA, Dutch Insurance Assn., MONY Life, European archive Holocaust Era Insurance Registry Insurer Certification Policyholder / Policyholder Named Insured Insurer Which Insurer Current Distribution Amount Name Address Named Insured Named Beneficiary Policy Type Issued Policy Currently Responsible Status of Proceeds Unpaid Payment to Other Pd Q., Guiseppe (Named Insured) Not Available, Genoa, Italy Q., Guiseppe Not Available, Life Mutual Of New York Mony Life Insurance Company Paid Bene/Heir/Owner - - Quadagnini, Aug (Named Pd Insured) Not Available, Vienna, Austria Quadagnini, Aug Not Available, Not Available Mutual Of New York Mony Life Insurance Company Paid Bene/Heir/Owner - - Quadrelli, Luigi (Named Pd Insured) Not Available, Genoa, Italy Quadrelli, Luigi Quadrelli, Elvira Imperatori Endowment Mutual Of New York Mony Life Insurance Company Paid Bene/Heir/Owner - - Quagliero, Antonio (Named Pd Insured) Not Available, Genoa, Italy Quagliero, Antonio Wife And Children, Life Mutual Of New York Mony Life Insurance Company Paid Bene/Heir/Owner - - Quaglietti Fu Luigi, Gini Pd (Named Insured) Not Available, Genoa, Italy Quaglietti Fu Luigi, Gini Self, Life Mutual Of New York Mony Life Insurance Company Paid Bene/Heir/Owner - - Transfer To 10 Rue De La Liberte Cachan Generales Quanon, (Named Insured) Seine, Paris, France Quanon, Not Available, Not Available Mutual Of New York Mony Life Insurance Company Vie Not Available - Quarti, Eugenio (Named Pd Insured) Not Available, Genoa, Italy Quarti, Eugenio -

The Evolution of Landscape in Venetian Painting, 1475-1525
THE EVOLUTION OF LANDSCAPE IN VENETIAN PAINTING, 1475-1525 by James Reynolds Jewitt BA in Art History, Hartwick College, 2006 BA in English, Hartwick College, 2006 MA, University of Pittsburgh, 2009 Submitted to the Graduate Faculty of The Dietrich School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2014 UNIVERSITY OF PITTSBURGH KENNETH P. DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by James Reynolds Jewitt It was defended on April 7, 2014 and approved by C. Drew Armstrong, Associate Professor, History of Art and Architecture Kirk Savage, Professor, History of Art and Architecture Jennifer Waldron, Associate Professor, Department of English Dissertation Advisor: Ann Sutherland Harris, Professor Emerita, History of Art and Architecture ii Copyright © by James Reynolds Jewitt 2014 iii THE EVOLUTION OF LANDSCAPE IN VENETIAN PAINTING, 1475-1525 James R. Jewitt, PhD University of Pittsburgh, 2014 Landscape painting assumed a new prominence in Venetian painting between the late fifteenth to early sixteenth century: this study aims to understand why and how this happened. It begins by redefining the conception of landscape in Renaissance Italy and then examines several ambitious easel paintings produced by major Venetian painters, beginning with Giovanni Bellini’s (c.1431- 36-1516) St. Francis in the Desert (c.1475), that give landscape a far more significant role than previously seen in comparable commissions by their peers, or even in their own work. After an introductory chapter reconsidering all previous hypotheses regarding Venetian painters’ reputations as accomplished landscape painters, it is divided into four chronologically arranged case study chapters. -

Il Caso Di Don Tonino Bello
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE L’ANTIMAFIA ETICA: IL CASO DI DON TONINO BELLO Elaborato finale di: Valeria Biasco Relatore: Prof. Fernando dalla Chiesa Anno Accademico 2014 / 2015 ! 1! A Seba, il mio angelo biondo. ! 2! “L’etica è il primo argine all’illegalità. Nei contesti professionali non può mai essere vista come un <<di più>>: non è un obiettivo fra gli altri, ma ciò che deve fare da sfondo a ogni progetto, a ogni investimento e scelta strategica. Essa è il fine di un’attività professionale, raggiungibile solo se le persone che coinvolge (i dipendenti, i collaboratori) sono a loro volta fine, e mai strumento. Il nostro lavoro è <<etico>> quando non presta il fianco ai compromessi, alle scorciatoie, alle prepotenze di chi vuole calpestare i diritti in nome del privilegio. Dunque, non solo <<etica delle professioni>>, ma etica come professione di tutti” don Luigi Ciotti ! 3! Indice 6 INTRODUZIONE Capitolo primo: 10 IL RAPPORTO TRA DON TONINO BELLO E LA SOCIETÀ: UN APOSTOLATO SENZA CONFINI 11 1.1: Il rapporto tra la chiesa e la comunità 23 1.2: L’impegno quotidiano con i più deboli 29 1.3: L’attenzione costante ai giovani Capitolo secondo: 37 LA TESTIMONIANZA LOCALE DI DON TONINO BELLO 37 2.1: La responsabilità dell’impegno: continuità, condivisione e corresponsabilità 42 2.2: Tre casi di impegno civile e sociale: 42 • Casa per la Pace e La Meridiana 46 • Comunità di Accoglienza, Solidarietà e Amicizia Capitolo Terzo: 50 DAVANTI ALLA CRIMINALITA’ PUGLIESE 53 3.1: La criminalità pugliese fino agli anni Ottanta 59 3.2: La nascita -
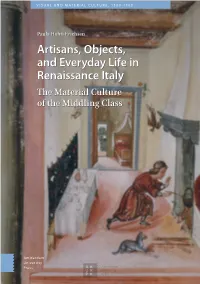
Observing Protest from a Place
VISUAL AND MATERIAL CULTURE, 1300-1700 Hohti Erichsen Paula Hohti Erichsen Artisans, Objects, and Everyday Life in Renaissance Italy The Material Culture of the Middling Class in Renaissance Italy Life Everyday and Objects Artisans, Artisans, Objects, and Everyday Life in Renaissance Italy Visual and Material Culture, 1300–1700 A forum for innovative research on the role of images and objects in the late me- dieval and early modern periods, Visual and Material Culture, 1300–1700 publishes monographs and essay collections that combine rigorous investigation with critical inquiry to present new narratives on a wide range of topics, from traditional arts to seemingly ordinary things. Recognizing the fluidity of images, objects, and ideas, this series fosters cross-cultural as well as multi-disciplinary exploration. We consider proposals from across the spectrum of analytic approaches and methodologies. Series Editor Dr. Allison Levy, an art historian, has written and/or edited three scholarly books, and she has been the recipient of numerous grants and awards, from the National Endowment for the Humanities, the American Association of University Women, the Getty Research Institute, the Dumbarton Oaks Research Library of Harvard Uni- versity, the Whiting Foundation and the Bogliasco Foundation, among others. www. allisonlevy.com. Artisans, Objects, and Everyday Life in Renaissance Italy The Material Culture of the Middling Class Paula Hohti Erichsen Amsterdam University Press The research leading to the completion of this book has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program (grant agreement No. 726195) Cover illustration: Il Sodoma, Scenes from the Life of Saint Benedict (detail), sixteenth century. -

When the Rabbi's Soul Entered a Pig: Melchiorre Palontrotti and His
Jewish History (2020) 33: 351–375 © The Author(s) 2020 https://doi.org/10.1007/s10835-020-09367-y When the Rabbi’s Soul Entered a Pig: Melchiorre Palontrotti and His Giudiata against the Jews of Rome MARTINA MAMPIERI Lichtenberg-Kolleg, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germany E-mail: [email protected] Abstract This essay analyzes an unpublished manuscript of a giudiata, a poem mocking Jew- ish funerals that was written and performed in Rome in the mid-seventeenth century. Mel- chiorre Palontrotti, the author of the composition, was a Roman polemist and author of other published works against Italian Jews, including, among others, the Venetian rabbi Simone Luzzatto, between 1640 and 1649. After furnishing information on the author and the histor- ical background in which the song was written, and following an analysis of the origins of giudiate and their diffusion in early modern Rome, this paper explores the content, language, and style of the giudiata text. The appendix includes a bibliography of Palontrotti’s writings and a transcription of the manuscript. Keywords Jewish-Christian Relations · Jewish History · Anti-Jewish Polemics · Early Modern Polemics · Seventeenth Century · Rome In the rich manuscript collection belonging to Giovanni Pastrizio (ca. 1636– 1708),1 a lecturer in theology at the Collegio Urbano de Propaganda Fide and scriptor hebraicus at the Vatican Library from 1695, there is a brief but extremely interesting rhymed composition.2 This text, handwritten by Pas- trizio, consists of a canzone contro gli ebrei (“song against the Jews”) in 1On Pastrizio, also known as Ivan Paštric,ˇ and his activity in Rome from the first half of the seventeenth century until his death, see Notizie istoriche degli Arcadi morti, tomo secondo, in Roma, nella Stamperia di Antonio de Rossi, 1720, f. -

AATI Newsletter
AMERICAN ASSOCIATION OF TEACHERS OF ITALIAN SPRING 2011 AATI Newsletter Messaggio del presidente Care colleghe e cari colleghi, Innanzitutto a nome di tutta la nostra associazione vorrei esprimere la nostra solidarietà al popolo giapponese, assieme alle nostre condoglianze e a nome dei credenti dell’AATI anche le nostre preghiere. Vorrei anche incoraggiare tutti quelli che leggeranno questo messaggio, di essere generosi e mandare aiuti e denaro per le vittime di questa immane catastrofe. Le donazioni possono essere inviate all’American Red Cross. Grazie di cuore a tutti. Dall’ultimo messaggio molti eventi si sono succeduti. Insieme a Bancheri e a Nuessel si è fatto molto per definire il convegno in programma ad Erice che dalle partecipazioni si presenta stimolante e interessante. Stiamo anche per dar inizio alla votazione per apportare dei cambiamenti alla costituzione e per nominare nuovi Regional Representatives e prego tutti gli iscritti di partecipare. Colgo l’occasione di ringraziare tutti i Regional Representatives uscenti per l’ottimo lavoro svolto. Sabato 12 marzo si è tenuto al Calandra Institute di New York l’AP Workshop sponsorizzato dalla nostra associazione, appuntamento dedicato ai cambiamenti che il College Board ha apportato all’esame AP e ai corsi. Vorrei IN THIS ISSUE ringraziare tutti gli insegnati d’italiano che si sono iscritti, abbiamo ricevuto 95 richieste ma abbiamo potuto accoglierne 67. Grazie anche a tutti i docenti, al 1. Messaggio del presidente Console Generale di New York, al Primo consigliere dell’Ambasciata Italiana, a 4. Details on reinstated AP Italian Joseph Sciame, Chairman of the Conference of Presidents of Major Italian 6. -

Society for Seventeenth-Century Music Twelfth Annual Conference
Society for Seventeenth-Century Music A SOCIETY DEDICATED TO THE STUDY AND PERFORMANCE OF 17TH-CENTURY MUSIC Twelfth Annual Conference La Jolla, California 1517 April 2004 ABSTRACTS OF PRESENTATIONS * Index of presentations * Abstracts * Program Committee Index of Presentations Antonia L. Banducci (University of Denver), “Staging Music: The Dramatic Role of Preludes and Ritournelles in French Baroque Opera” Gregory Barnett (Rice University), “Church Music, Musical Topoi, and the Ethos of the Sonata da chiesa” Grey Brothers (Westmont College) and the Westmont Chamber Singers, “The Polyphonic Passion in Mexico City: The Passio secundum Mattheum of Antonio Rodríguez de Matta (d. 1643)” Michele Cabrini (Princeton University), “From the Visual to the Aural: Tempête and the Power of Instrumental Sound in the French Cantata” Stuart Cheney (Goucher College), ”Transcriptions for Solo Viol of the Music of Jean- Baptiste Lully” Michael R. Dodds (Southern Methodist University), “Plainchant at Florence Cathedral in the Late Seicento: Unwritten Sharps and Shifting Concepts of Tonal Space” David Dolata (Eastern Washington University), “Bellerofonte Castaldi’s Extraordinary Capricci a due stromenti” Don Fader (Indiana University), “Marin Mersenne and the French View of Musical Rhetoric” Alex Fisher (University of British Columbia), “Approaching Music and Religious Identity in Early Modern Germany: Sacred Music in Augsburg during the Thirty Years’ War" Wendy Heller (Princeton University), “I pianti d’Apollo: Desire, Melancholy, and the Power of Song” -

Antonio Ghini and Andrea Di Francesco Guardi: Two 15Th-Century Tuscan Artists in the Service of Local Governments
Antonio Ghini and Andrea di Francesco Guardi: Two 15th-century Tuscan Artists in the Service of Local Governments Sandra Cardarelli Although the medieval and renaissance artist dwelled within a rigidly structured society whereby his life and work were strictly related to his affiliation to a guild, a confraternity, a political faction or some other form of corporate association that could grant him identity and protection, his world was far from restricted by the geographical boundaries of his city.1 Maginnis argued that early Sienese painters enjoyed great fame outside their native city thanks to foreign patrons.2 Simone Martini left Siena at the apex of his career as favourite painter of the commune to work for mendicant orders in Pisa, Orvieto and Assisi, and then at the service of the Angevins in Naples before moving to the papal court in Avignon.3 Likewise, the case of the Florentine sculptor Donatello, who worked in the rival city of Siena by request of a petition of the Balia in 1457,4 demonstrates that the wish to commission art This paper draws from material researched for my doctoral thesis: Siena and its contado: Art, Iconography and Patronage in the Diocese of Grosseto from c. 1380 to c. 1480, University of Aberdeen, PhD, 2011. A specific section in the thesis discusses the work of travelling artists in the diocese of Grosseto, and this first approach to the notion of artists and travel was later developed further and resulted in the session ‘Travelling artists in medieval and Renaissance Europe’ at the 38th annual conference of the Association of Art Historians, Milton Keynes, 29-31 March 2012. -

Abandoned Children of the Italian Renaissance Terpstra, Nicholas
Abandoned Children of the Italian Renaissance Terpstra, Nicholas Published by Johns Hopkins University Press Terpstra, Nicholas. Abandoned Children of the Italian Renaissance: Orphan Care in Florence and Bologna. Johns Hopkins University Press, 2005. Project MUSE. doi:10.1353/book.60316. https://muse.jhu.edu/. For additional information about this book https://muse.jhu.edu/book/60316 [ Access provided at 25 Sep 2021 12:58 GMT with no institutional affiliation ] This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 01Terpstra FM 10/18/05 4:09 PM Page i Abandoned Children of the Italian Renaissance 01Terpstra FM 10/18/05 4:09 PM Page ii The Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science 123rd series (2005) 1. Stephen G. Alter, William Dwight Whitney and the Science of Language 2. Bethany Aram, Juana the Mad: Sovereignty and Dynasty in Renaissance Europe 3. Thomas Allison Kirk, Genoa and the Sea: Policy and Power in an Early Modern Maritime Republic, 1559–1684 4. Nicholas Terpstra, Abandoned Children of the Italian Renaissance: Orphan Care in Florence and Bologna 01Terpstra FM 10/18/05 4:09 PM Page iii Abandoned Children of the Italian Renaissance Orphan Care in Florence and Bologna Nicholas Terpstra The Johns Hopkins University Press Baltimore 01Terpstra FM 10/18/05 4:09 PM Page iv This book has been brought to publication with the generous assistance of the Lila Acheson Wallace–Reader’s Digest Publications Subsidy at Villa I Tatti. © 2005 The Johns Hopkins University Press All rights reserved. Published 2005 Printed in the United States of America on acid-free paper 987654321 The Johns Hopkins University Press 2715 North Charles Street Baltimore, Maryland 21218-4363 www.press.jhu.edu Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Terpstra, Nicholas. -

Part Two: Five Case Studies (Rome, Athens, Durham, Magdeburg, Vézelay)
J. Jokilehto, A History of Architectural Conservation D. Phil Thesis, University of York, 1986 Part Two: Five Case Studies (Rome, Athens, Durham, Magdeburg, Vézelay) Page 122 J. Jokilehto Chapter Eight Case Study: Italy, Restoration in Rome 8.1 Conservation in the Papal States, 1800- The Camera Apostolica, the Papal government, 1809 had two departments that had special responsibilities regarding the conservation of cultural property. After the Papal States were restored to the Pope One was the so called Camerlengato, the general with the withdrawal of the French in 1799, Pius VII administration of Papal States. Its director was called (1800-1823) arrived in Rome to assume the throne of the Camerlengo. This office was responsible, among St. Peter in June 1800. His first concern was to re- other duties, for the general legislation, inspection establish the Papal administration; special emphasis and evaluation of antiquities and works of art. The was given to improved protection for the antiquities Inspector of Fine Arts and the Commissioner of and works of art that had suffered during the French Antiquities were nominated by the Camerlengo. domination. There had been several edicts in the past The other office responsible for conservation was to protect them and control their exportation (e.g. the Treasury, under the direction of the Chief 1624, 1646, 1717, 1726, 1733, 1750). (1) However, Treasurer. His duties covered the financial aspects these had not been efficiently enforced and with and corresponding legislative acts, as well as the the impoverishment of the Papal States, the sale of execution of works. These included excavation, art collections to foreigners had become common. -
Naturalizations in Ontario County, NY
NAME SPOUSE TOWN DATE ABBOTT, ABE ABBOTT, SUSIE MANCHESTER 1929 ABBOTT, CHARLIE SAMUEL MANCHESTER 1922 ABBOTT, GEORGE ABBOTT, CATHERINE MANCHESTER 1911 ABBOTT, JAMES GENEVA 1910 ABBOTT, JOE GENEVA 1915 ABBOTT, MURPHY MIKE ABBOTT, ANNA LOUISE GENEVA 1922 ABBOTT, SAM ABBOTT, SALOME SHORTSVILLE 1915 ABBS, ROBERT WILLIAM SENECA 1918 ABERMAN, MORRIS JOHN ABERMAN, ROSE CANANDAIGUA 1919 ABRAHAM, ALBERT ABRAHAM, SARAH GENEVA 1915 ABRAHAM, BEATRICE EMMA CANANDAIGUA 1930 ABRAHAM, GEORGE DELLAH ABRAHAM, FREIDA B. GENEVA 1943 ABRAHAM, JAMES SOLOMON SHORTSVILLE 1919 ABRAHAM, JOHN ABRAHAM, MARY GENEVA 1909 ABRAHAM, JOHN ABRAHAM, EMMA GENEVA 1919 ABRAHAM, JOSEPH ABRAHAM, HELEN GENEVA 1927 ABRAHAM, PHILIP THOMAS ABRAHAM, SADIE GENEVA 1935 ABRAHAM, RACHEL BEATRICE CANANDAIGUA 1926 ABRAHAM, TOM GENEVA 1910 ABRAHAM, WILLIAM EDWARD ABRAHAM, BEATRICE EMMA CANANDAIGUA 1927 ACQUILANO, ANGELINA GENEVA 1945 ADAMS, ELISABETH ADAMS, JOHN P. NAPLES 1953 ADAMS, JOHN NAPLES 1929 ADAMS, MARY ESTELLE CLIFTON SPRINGS 1941 ADLAM, LEONARD FREDERICK GENEVA 1916 ADONA, ALESSANDRO ADONA, MARY GENEVA 1936 ADONA, ALESSANDRO ADONA, MARIE GENEVA 1923 ADRIAN, FREDERICK HUGO GENEVA 1917 AGOSTINELLI, PASQUALE CANANDAIGUA 1911 AGOSTINI, NED AGOSTINI, LOUISA GENEVA 1918 AHO, EDWARD AHO, MARY DE WEAVER MANCHESTER 1932 AHO, MARY JENNIE AHO, EDWARD PORT GIBSON 1950 AIELLO, ROCCO AIELLO, STELLA MANCHESTER 1927 AINZUA, JUAN CANANDAIGUA 1931 ALBAS, MARIANO GIRALT CANANDAIGUA 1931 ALBERT, LEO ABDALIA GENEVA 1923 ALBIFONDO, MICHELE ALBIFONDO, ANGELINA CANANDAIGUA 1912 ALBINO, NUNZIO ALBINO, -
Notaio Torotto Francesco
Notaio TOROTTO Francesco di Carlo Emiliano di Varallo 1691-1707 ARCHIVIO DI STATO DI VARALLO Inventario analitico a cura di Maria Grazia Cagna - Digitalizzazione a cura di Bruna Crivelli Anno 2011 - Revisione 2018 1 N. B. : nella data si omette la località, quando si tratta di Varallo Data Primo contraente Natura del contratto Collocazione 19-12-1704 Giuseppe Allegra Vendita di terreno a Campertogno a 10289 f. 1 Giovanni Battista Badarello 14-12-1704 Gaudenzio Della Gula Rilascio di un terreno a Morca a Bartolomeo 10289 f. 2 Della Gula 8-12-1704 Giovanni Battista Draghetti Vendita di un terreno alla Lozza di Varallo, a 10289 f. 3 Francesco Mecco 4-12-1704 Domenico Molino Cessione di un credito a Giovanni Andrea 10289 f. 4 Giacobino, procuratore di Giovanni Giuliani, patrono della cappellania di S. Maria Maddalena di Valmaggia 4-12-1704 Francesco Torotto, notaio Obbligo verso Giovanni Andrea Giacobino 10289 f. 5 per un mutuo 17-11-1704 Francesco Antonio Antonietti Cessione di un credito al mercante 10289 f. 6 Gaudenzio Turcotti 13-11-1704 Carlo Martinetti Remissione di colpa a favore di Bernardino 10289 f. 7 Marchino, Francesco e Marco Selletti, per le ferite ricevute 10-11-1704 Domenico Molino Cessione di un credito a don Francesco 10289 f. 8 Antonio Perotti, canonico di S. Gaudenzio 5-11-1704 Antonio Chiarino Vendita di un censo a Bartolomeo Uberti 10289 f. 9 23-10-1704 Giovanni Battista Durio Rivendita di un censo ad Antonio Martinolo 10289 f. 10 21.-10-1704 Francesco Maurizio Zenda, Obbligo verso Francesco Antonio Antonietti 10289 f.