Studi Di Storia Medioevale E Di Diplomatica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Financial Statements As of 31St December 2016
Financial Statements as of 31st December 2016 111th Financial year Financial Statements as of 31st December 2016 111th Financial year 1 2 3 4 5 Contents COMPANY PROFILE PAGE 9 MANAGEMENT REPORT PAGE 15 SUSTAINABILITY REPORT PAGE 115 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PAGE 159 SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS PAGE 239 1 COMPANY PROFILE 1.1 Letter to Shareholders 11 1.2 Corporate Governance 12 1.3 Shareholder Structure 13 1.1 Letter to Shareholders Dear Shareholders, the year 2016 was characterised, in line with the property company model adopted by joining the SIIQ status and in line with international Reits, by the purchase of fixed return investments and the main development projects for further input to the revenue portfolio in the medium term. In particular, the Group has anticipated the Plan’s objectives in terms of investment, purchasing a property portfolio for commercial use and a portofolio for office use, increasing by 90% the rental level on an annual basis that has reached 11 Euro 18 million approximately. In line with expectations the development has been completed of Phase 6 of the Serravalle Designer Outlet. The expansion of the shopping centre, in which Aedes SIIQ S.p.A. owns 50.1%, affected some 8,748 square meters of rd retail space. The opening to the public on 3 PROFILE November with 75% of occupancy marked an important milestone for the Group. Also during the year, work has begun on preliminary development of Phase C of Serravalle Retail Park, which is expected to open in spring 2018, and authorisation has been completed for the activities of Caselle development OMPANY C project, prior to the signature of the urban planning agreement expected in the first half of 2017. -

SITI DI INTERESSE Mappa Di Alcuni Siti Naturali, Ambientali O Storici Alle Porte Di Milano
SITI DI INTERESSE Mappa di alcuni siti naturali, ambientali o storici alle porte di Milano www.terrdedeinavigli.com 1 1 Case Nuove Volandia Lonate Pozzolo 1 1 Parabiago Nerviano Nosate Castano Primo Busto Garolfo 2 1 SS 33 1 A8 A8 RHO MI Turbigo Rho 3 Robbechetto con Induno 3 Vanzago Rho Casorezzo Rho-Fiera 2 2 4 Inveruno Cuggiono 3 A4 TORINO TRIESTE A50 Arluno 1 Castelletto di Mesero A4 Cuggiono SP 31 Marcallo Mesero Cornaredo 8 Vittuone 7 Settimo Milanese 5 2 2 4 Marcallo Alluno, Corbetta Santo Stefano Bareggio Bernate Ticino MILANO 5 A4 TORINO TRIESTE 5 Corbetta Boalora Magenta LEGENDA A4 Sopra il Ticino Magenta 2 4 5 6 2 SP 11 Ponte Nuovo DA NON PERDERE SS 11 6 3 2 6 1. VOLANDIA 5 2. BERNATE TICINO - CANONICA E PALAZZO VISCONTEO Ponte Vecchio Novara 4 6 Cusago 3. ROBECCO SUL NAVIGLIO Castellazzo 4 Milano san Cristoforo Ferrovia Torino - Milano Cisliano 7 4. MORIMONDO 1 de’ Barzi Riazzolo 5. VIGEVANO SS 11 9 8 6. CERTOSA DI PAVIA Trecate Robecco 3 sul Naviglio 3 Trezzano Corsico 7. PAVIA Bestazzo 1 Casterno sul Naviglio Trecate Corsico 2 LUOGHI LEONARDESCHI Cassinetta di 5 Albairate 6 NAVIGLIETTO Trezano sul Naviglio Castello e piazza Ducale, Vigevano Lugagnano 3 Fagnano 10 Molino Mora Bassa, Vigevano 11 16 SS 494 La Sforzesca, Cascina Colombarone Gaggiano SP 526 6 Buccinasco VISCONTA 8 15 5 9 BORGHI IMPORTANTI 12 13 A50 TANGENZIALE OVEST MILANO 1 Castelletto di Cuggiono e Villa Clerici Albairate-Vermezzo Gaggiano 2 Corbetta 7 9 2 3 7 3 4 NAVIGLIO GRANDE 3. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus Z556
Orari e mappe della linea bus Z556 Z556 Motta Visconti - Abbiategrasso Visualizza In Una Pagina Web La linea bus Z556 (Motta Visconti - Abbiategrasso) ha 2 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Motta Visconti: 07:02 - 18:52 (2) Abbiategrasso: 06:25 - 18:15 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus Z556 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus Z556 Direzione: Motta Visconti Orari della linea bus Z556 17 fermate Orari di partenza verso Motta Visconti: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 07:02 - 18:52 martedì Non in servizio Motta Visconti Via Soriani Via Soriani, Motta Visconti mercoledì Non in servizio Motta Visconti Via Matteotti giovedì Non in servizio Motta Visconti Via De Gasperi/Matteotti venerdì Non in servizio sabato Non in servizio Motta Visconti Via Borgomaneri Via Gigi Borgomaneri, Motta Visconti domenica Non in servizio Besate Str. Per Casorate Strada per Casorate Primo, Besate Fallavecchia Est Informazioni sulla linea bus Z556 Direzione: Motta Visconti Fallavecchia Nord Fermate: 17 Durata del tragitto: 37 min Morimondo C.na Basiano La linea in sintesi: Motta Visconti Via Soriani, Motta Visconti Via Matteotti, Motta Visconti Via De Morimondo C.na Coronate Gasperi/Matteotti, Motta Visconti Via Borgomaneri, Besate Str. Per Casorate, Fallavecchia Est, Morimondo Via Roma Fallavecchia Nord, Morimondo C.na Basiano, Morimondo C.na Coronate, Morimondo Via Roma, 30 Via Aldo Moro, Morimondo Caselle Bivio, Caselle, Ozzero, Vecchia Soria, Caselle Bivio Abbiategrasso Mirabella, Abbiategrasso -

INFORMAZIONI PERSONALI Nome SAGARIA GIOVANNI Data Di Nascita 09/07/1954 Qualifica Segretario Comunale Amministrazione COMUNE DI
INFORMAZIONI PERSONALI SAGARIA GIOVANNI Nome Data di nascita 09/07/1954 Qualifica Segretario Comunale Amministrazione COMUNE DI ROZZANO Incarico attuale DIRIGENTE – Direzione Affari Generali Numero telefonico 028226282 dell’ufficio Fax dell’ufficio 0289200788 e-mail istituzionale [email protected] TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE Titolo di studio Diploma di LAUREA in GIURISPRUDENZA - Master di specializzazione Universitario di II° Livello. Roma 2007 – idoneità a Segretario Generale di fascia “A” Corso SE.F.A – (art.14, c.2, DPR Altri titoli di studio e 465/1997) ; Professionali: - Corso di Aggiornamento e Formazione per Direttori Generali - Milano 2004 -SSPAL - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - Titolo di Perfezionamento per Segretari Comunali – Scuola di Direzione Aziendale Bocconi di Milano – SDA. Milano maggio-dicembre 1997. 1 – Corso COPERFEL – Titolo riconosciuto con Decreto Rettorale 7696 n.4027 ai sensi del DPR 10/03/1982 n. 162 art. 16- Castello di San Gaudenzio di Cervesina (Pavia). - Corso di Aggiornamento e Formazione Permanente – Università “SACRO CUORE” Milano - (ottobre 1995 gennaio 1996 )- - Corso di Aggiornamento Professionale - Ministero degli Interni Roma –( febbraio- marzo 1992 ) - Vice Procuratore Onorario della Repubblica presso il Tribunale di Pavia D.M. Ministero della Giustizia 19.1.2006 (aprile 2006); Qualificazioni - Commentatore dell’Ordine al Merito della professionali e Repubblica Italiana. Onorificenze Decreto 2 giugno 2007 Presidente della -

Carta Del Rischio 1:25.000 MAGENTA TAV.5
A B C D E F G H I J T San Vittore Olona CantalupoCantalupo A Cantalupo ORIGGIO Magnago o S R LEGNANO SAN VITTORE OLONA r LEGNANO S A r 3 V e AÆÆ Magnago BUSTO ARSIZIO San Giorgio Su Legnano Ê 3 Cantalupo n CERRO MAGGIORE O LEGNANO Æ ÆÇ N t - Vanzaghello e AÆ O Legnano T A N S 8 VANZAGHELLO e - N . n A ÆÇ P !d O SAN GIORGIO SU LEGNANO U o 2 . T R ! > 1 r O 1 A e ÆÇ Æ S AÊÆ . 0 S MAGNAGO P T . ÆÇ 1 R S Ê S A S Dairago b D 3 A! í 4 ÆÇÆ Canegrate ÆÇ M 1 ÆÇ I Æ X LA N Villa Cortese A!Æ O ÆVILLA CORTESE - VA DAIRAGO S O R . CANEGRATE E P S . E 1 esi 9 2 llor 1 8 Vi 1 2 ale 1 an C . S P .P X . T . o LAINATE 11 S ÆÇ r 9 Æ re Æ Ê Æ n te Æ !d B o ÆÇ z AÆ í! z e > ÆÇ n ²! ! t ÆÇ . 32 e Ê S.P F Ê iu Cascina Saronna m O Lainate ÆÇ Ê e Parabiago AÆ ÆÇ O ÆÇ Nerviano lo Castano Primo Æ > S > n Æ O . a X O ÆÇ P O ! . b 1 NERVIANO! 0 ÆÇÊ 9 í! > Ê ÊÆÇ PARABIAGO Busto Garolfo AÆ Cascina Bruciata CASTANOÆ PRIMO ÆÇ Passirana BUSCATE ! ! ÆÇÆ í XÆÇÆ dir S Ê BUSTO GAROLFO S.P. 34 .P AÆ O . 34 8 . 19 Buscate S.P Æ S Pogliano MilaneseÆÇ AÆ o .P z . -

1.2.1 Inquadramento
MOZZATE LENTATE SUL SEVESO CARATE BRIANZA LOMAGNA CASORATE SEMPIONE FAGNANO OLONA MISINTO MEDA TRIUGGIO VERDERIO INFERIORE BONATE SOTTO ALBIATE CAMPARADA SUISIO CASSANO MAGNAGO TURATEROVELLO PORRO BARLASSINA MADONE SOLBIATE OLONA CISLAGO USMATE VELATE BERNAREGGIO CHIGNOLO D`ISOLA SOMMA LOMBARDO GALLARATE GORLA MINORE SEREGNO SOVICO LESMO DALMINE CARDANO AL CAMPO COGLIATE SEVESO CARNATE AICURZIO CORNATE D`ADDA MACHERIO BOTTANUCO GERENZANO SULBIATE FILAGO OSIO SOPRA OLGIATE OLONA MARNATE CERIANO LAGHETTO BIASSONO ARCORE MEZZAGO VIZZOLA TICINO SARONNO CESANO MADERNO SAMARATE RESCALDINA FERNO DESIO LISSONE OSIO SOTTO COMUNE DI SOLARO VIMERCATE BELLUSCO BUSNAGO CAPRIATE SAN GERVASO MORIMONDO CASTELLANZA BOVISIO MASCIAGO VEDANO AL LAMBRO UBOLDO TREZZO SULL`ADDA BREMBATE BUSTO ARSIZIO VILLASANTA LIMBIATE RONCELLO BOLTIERE PROVINCIA DI MILANO CESATE VAREDO ORNAGO LEGNANO ORIGGIOCARONNO PERTUSELLA MUGGIO` CONCOREZZO BURAGO DI MOLGORA GREZZAGO CERRO MAGGIORE NOVA MILANESE LONATE POZZOLO MONZA CAVENAGO DI BRIANZA TREZZANO ROSA CISERANO VANZAGHELLO SAN VITTORE OLONA BASIANO AGRATE BRIANZA MAGNAGO CANONICA D`ADDA GARBAGNATE MILANESESENAGO VAPRIO D`ADDAPONTIROLO NUOVO SAN GIORGIO SU LEGNANO PADERNO DUGNANO CAMBIAGO POZZO D`ADDA VILLA CORTESE CANEGRATE LAINATE CAPONAGO DAIRAGO MASATE CINISELLO BALSAMO GESSATE NOSATE BRUGHERIO NERVIANO CUSANO MILANINO CARUGATE CASTEL ROZZONE CASTANO PRIMO PARABIAGO ARESE BOLLATE PESSANO CON BORNAGO BUSCATE CORMANO FARA GERA D`ADDA BUSTO GAROLFO INZAGO ARCONATE POGLIANO MILANESE BRESSO BUSSERO SESTO SAN GIOVANNICOLOGNO MONZESE BELLINZAGO LOMBARDO TREVIGLIO RHO NOVATE MILANESE CERNUSCO SUL NAVIGLIO GORGONZOLA TURBIGO CASOREZZO BARANZATE CASSANO D`ADDA INVERUNO VANZAGO ROBECCHETTO CON INDUNO CASSINA DE PECCHI PREGNANA MILANESE VIMODRONE POZZUOLO MARTESANA ARLUNO PERO CUGGIONO OSSONA VIGNATE MELZO CASIRATE D`ADDA MESERO SEDRIANO CORNAREDO PIOLTELLO CALVENZANO MARCALLO CON CASONESANTO STEFANO TICINO SEGRATE ARZAGO D`ADDA SETTIMO MILANESE TRUCCAZZANO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO BERNATE TICINO VITTUONE BAREGGIO RODANO LISCATE MILANO L.R. -

Poderi Di Proprietà Della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Poderi di proprietà della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Milano Lotto Podere Comune Bertonico Brusata di Sopra Bertonico Bertonico Brusata di Sotto Bertonico Bertonico Campolungo Bertonico Bertonico Cascina del Ponte Bertonico Bertonico Cascina di Sotto Bertonico Bertonico Case e Orti in Bertonico Bertonico Bertonico Casenove Bertonico Bertonico Ceradello Bertonico Bertonico Chioso Bertonico Bertonico Gallinera Bertonico Bertonico Gora Bertonico Bertonico Guastimone Bertonico Bertonico Mezzano Bertonico Bertonico Monticelli Maggiore Bertonico Bertonico Monticelli Minore e Pila Bertonico Bertonico Pista Bertonico Bertonico Piva Bertonico Bertonico Riserva di Caccia Bertonico Bertonico Bertonico San Carlo Bertonico Bertonico Taccagna Bertonico Bertonico Valmollo Bertonico Bertonico Vigneto di Monticelli Bertonico Brianza Bariana Garbagnate Milanese Brianza Bariola Caronno Pertusella Brianza Bresso Bresso Brianza Calco Airuno Brianza Cascina De Bracchi Casatenovo Brianza Cascina del Sole Bollate Brianza Cassinette Bianche Castello Di Brianza Brianza Cimnago Carimate Brianza Cormano Cormano Brianza La Tombona Peschiera Borromeo Brianza Lomazzo Bregnano Brianza Naresso Besana In Brianza Brianza Nerviano Nerviano Brianza Poglianasca Nerviano Brianza Rovagnate Santa Maria Hoè Brianza Seregno Seregno Brianza Terreni in Peschiera e Segrate Peschiera Borromeo Brianza Vedano Vedano al Lambro Brianza Villanova Bernareggio 1 di 4 Poderi di proprietà della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Milano Esterni Biola Mandello Vitta -

Cologno Monzese Alla Ricerca Del Territorio Perduto
Storia locale - Studi storici Elisabetta Ferrario Mezzadri Cologno Monzese alla ricerca del territorio perduto Biblioteca Civica Presentazione Il venti dicembre del 1990, con delibera dirigenziale n° 1736, l’Amministrazione comunale di Cologno Monzese conferì all’Arch. Elisabetta Ferrario Mezzadri il compito di condurre una ricognizione del patrimonio architettonico storico presente sul territorio comunale e di darne conto in un elaborato che descrivesse i siti censiti, ricostruendone per quanto possibile la genesi e la storia delle modifiche intervenute nel corso del tempo. Rese eloquenti nelle loro stratificazioni storiche e nella ricchezza delle relazioni sistemiche che le legano al territorio, incontriamo ville, cioè residenze di campagna del ceto nobile, cascine, centri di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli provenienti dai terreni collegati, borghi rurali, fontanili, boschi e luoghi di sosta per carrettieri; tutti elementi che hanno segnato per secoli, il territorio colognese, disegnandolo sia dal lato paesaggistico sia come nuclei originari di un ininterotto processo di antropizzazione e urbanizzazione. Frutto di una ampia e accurata ricerca documentale condotta sul campo come tra gli archivi storici, il lavoro è arricchito da un imprescindibile corredo iconografico, quasi sempre originale. La qualità scientifica di questo lavoro, che nulla ha perduto del suo interesse a vent’anni dalla sua redazione, mette dunque in luce i profondi legami urbanistici, come sociali ed economici, impliciti nella cartografia dei luoghi storici; noi sappiamo che sono questi legami che vanno a formare quel nucleo di specificità e identità che chiamiamo contesto culturale locale. Per questo la biblioteca civica ha ritenuto utile pubblicare l’opera nella speranza che possa nutrire, con la sua passione per il nostro passato, un maggior rispetto per le vestigia di un mondo sì scomparso ma non morto, un passato capace di potenti suggestioni che attendono solo di essere evocate. -

The Ticino River and the Natural the Waters 17 Environments of Its Valley, Carved by the River Wildlife 18 While Going from Lago Maggiore to the Po River
TICINO PARK A guide to this nature preserve in Lombardy: the river, the wildlife, flora, projects and events, useful addresses and itineraries (& ##%& CONTENTS PREMISE A FUTURE ORIENTED PARK Lengthy articles could be written about the Ticino Valle del Ticino 4 Valley Park in Lombardy, recounting its history, Objective: Sustainability 6 features, all the activities it carries out and the Biosphere One Park, Two Souls 9 projects it is trying to implement amid a thousand The Importance of Planning 10 obstacles. In the following pages, we have tried Waterways for Biodiversity 11 to highlight the main facets of an area rich in Reserve Projects for the Future 12 nature and beautiful landscapes, but also human Natura 2000 Network 13 histories and historical and art testimonies. We would like to take you on a journey in A PARK discovery of the Park. Every section is a stage in FULL OF LIFE 14 our itinerary and our objective is that, by the end, you can share the idea underlying this preserve: A Green Corridor 16 the protection of the Ticino river and the natural The Waters 17 environments of its valley, carved by the river Wildlife 18 while going from Lago Maggiore to the Po River. Park Rangers and Volunteers 20 This are is an immeasurable treasury, also from a The World of Plants 21 social viewpoint, of which we are owners and The Agricultural Landscape 22 Since 2002 the Ticino Valley is included among the global biosphere reserves guardians and that, all together, we are called to love and protect. network, that Unesco recognized under the MAB Programme (Man and A PARK FOR EVERYONE 24 Biosphere). -

Sommario • Apre Il Centro Diurno Della Casa Famiglia Per Anziani a Pagina 3
Qui Cologno Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale di Cologno Monzese - Anno XVII - numero 2 - febbraio 2004 Sommario • Apre il Centro Diurno della Casa Famiglia per Anziani a pagina 3 • I prossimi lavori di sistemazione stradale lungo Corso Roma a pagina 7 • Nuovo servizio di raccolta a domicilio per i riuti pericolosi a pagina 8 • Gli appuntamenti e la cronaca della vita cittadina a pagina 13 • Gli interventi dei Gruppi Consigliari a pagina 16 pagina 2 Vita amministrativa Qui Cologno Qui Cologno on-line Periodico mensile a cura dell’Amministrazione Comunale di Cologno Monzese - Aut. Trib. di Monza n. 667 del 12/10/1988 Direttore responsabile: Giuseppe Milan Direttore: Agnese Losi Redazione e impaginazione: Stefano Zanelli Segreteria di redazione: Servizio Comunicazione e Stampa Villa Casati, via Mazzini 9 - Cologno Monzese Tel. 02.25308357/204 - Fax. 02.25308217 [email protected] http://www.comune.colognomonzese.mi.it Comitato di garanzia: Attilio Antonini, Giovanni Cocciro, Franco Esposito, Michele Famiglietti, “Qui Cologno” è anche in rete. Ricordiamo che è possi- Francesco Messano, Massimo Verdino bile scaricare una copia completa del periodico comu- Stampa e pubblicità: Il Guado, via P. Picasso - Corbetta (MI) nale (in formato Acrobat Reader - PDF) collegandosi al Tel. 02-972111 - Fax 0297211280 Tiratura 20.000 copie. sito internet www.comune.colognomonzese.mi.it Vita amministrativa pagina 3 Il nuovo servizio completa la struttura e accoglierà 40 anziani Casa Famiglia: apre il Centro Diurno ncora novità in vista alla Casa vani si propone di raggiungere attra- - Servizio di animazione AFamiglia “Monsignor Carlo Testa” verso la gestione del C.D.I. -
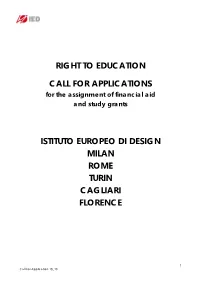
Right to Education Call for Applications Istituto
RIGHT TO EDUCATION CALL FOR APPLICATIONS for the assignment of financial aid and study grants ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN MILAN ROME TURIN CAGLIARI FLORENCE 1 Call For Application 18_19 Contents 1. ELIGIBLE APPLICANTS 2. SUM SET ASIDE FOR STUDY GRANTS 3. REQUIREMENTS 3.1 Merit requirements 3.2 Economic requirements 4. VALUE OF STUDY GRANTS 5. INTEGRATION TO THE STUDY GRANTS 6. PROCEDURES FOR PREPARING THE RANKING LISTS 7. DEADLINES 8. HOW TO APPLY 9. TRANSFER 9.1 Presentation of the application in the event of transfer to another university 9.2 Presentation of the application in the event of transfer from another university 10. NON-ADMISSION TO THE CALL FOR APPLICATIONS 11. PUBLICATION OF THE RANKING LISTS AND APPEALS 12. ASSIGNMENT OF STUDY GRANTS AND PAYMENT TERMS 13. INADMISSIBILITY, FORFEITURE, REVOCATION OF THE RIGHT 14. CHECKS ON THE TRUTHFUL NATURE OF ECONOMIC DECLARATION PROVIDED 15. INFORMATION ON THE USE OF PERSONAL DATA AND THE RIGHTS OF THE DECLARANT (Art. 13 of the Europian regulation on data protection no.2016/679 GDPR) 16. REMINDER DEADLINES APPENDIX A, B, C, D and E 2 Call For Application 18_19 1. ELIGIBLE APPLICANTS The call for applications is open to everybody: - Italian citizens, - Citizens of European Union Member States, - Citizens of States not belonging to the European Union (Italian Presidential Decree no. 394 dated 31st August 1999, implementing Italian Legislative Decree no. 286 dated 25th July 1998). Applicants must meet all the following requirements: - be a IED student admitted or enrolled in an Academic Diploma First Level course at Istituto Europeo di Design, in the seats of Milan, Rome, Turin, Cagliari or Florence, for the Academic Year 2018/2019; - Have the economic and merit requirements listed in point 3. -
![[ ] Lo Stato Dell'arte](https://docslib.b-cdn.net/cover/9981/lo-stato-dellarte-3029981.webp)
[ ] Lo Stato Dell'arte
[Lo stato dell’arte] [4] Tra le 147 amministrazioni che hanno risposto al censimento, 81 sono i Comuni che hanno dichiarato di aver attivato un processo di Agenda 21 locale a livello comunale e/o sovracomunale, per un totale di 92 processi di Agenda 21 locale attualmente avviati e in corso (Figure 11 e 12). Fig. 11 Comuni che hanno Tra questi 33 (pari al 22 %) sono le Agende 21 avviato un processo locali a livello comunale e 59 (pari al 40%) i di Agenda 21 Comuni che hanno riferito di aver promosso (valori in%; tra parentesi processi di Agenda 21 locale sovracomunale valori assoluti) (Figure 12 e 13). Fig. 12 Tipologia di Agenda 21 locale avviata (valori assoluti sul totale dei processi avviati) Fig. 13 Tipologia di Agenda 21 locale avviata (valori in % e assoluti sul totale del campione) 17 Tra i Comuni che hanno avviato un processo Tabella 4 Comuni appartenenti Comuni con processi di Agenda 21 locale, il 14 % è impegnato sul Denominazione Comune capofila doppio fronte del livello comunale e di al processo di Agenda 21 quello sovracomunale (Figura 14). sovracomunale avviati Nelle tabelle successive (tabelle 3 e 4) sono A21 Abbiatense Abbiategrasso Abbiategrasso riportati i Comuni impegnati in processi di Cusago Agenda 21 locale e sovracomunale, mentre Magenta Fig. 14 nella tabella 5 si evidenziano i Comuni che Morimondo Tipologia di Agenda 21 durante le interviste telefoniche hanno Vittuone (con delibera di avviata dichiarato di essere interessati ad intenti) (valori in % e assoluti intraprendere un percorso di Agenda 21 sul totale dei processi avviati) locale.