Scarica Il Documento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

AMELIO PEZZETTA Via Monteperalba 34 – 34149 Trieste; E-Mail: [email protected]
Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste 58 2016 57/83 XII 2016 ISSN: 0335-1576 LE ORCHIDACEAE DELLA PROVINCIA DI CHIETI (ABRUZZO) AMELIO PEZZETTA Via Monteperalba 34 – 34149 Trieste; e-mail: [email protected] Riassunto – Il territorio della provincia di Chieti (regione Abruzzo) misura 2.592 km² e occupa da nord a sud l'area com- presa tra le valli dei fiumi Pescara e Trigno, mentre da sud-ovest a nord-ovest lo spartiacque di vari massicci montuosi lo separa da altre province. Nel complesso è caratterizzato da una grande eterogeneità ambientale che consente l'attec- chimento di molte specie vegetali. Nel presente lavoro è riportato l’elenco floristico di tutte le Orchidacee comprendenti 88 taxa e 21 ibridi. A sua volta l'analisi corologica evidenzia la prevalenza degli elementi mediterranei seguita da quelli eurasiatici. Parole chiave: Chieti, Orchidaceae, check-list provinciale, elementi floristici. Abstract – The province of Chieti (Abruzzo Region) measuring 2,592 square kilometers and from north to south occupies the area between the valleys of the rivers Trigno and Pescara while from the south-west to north-west the watershed of several mountain ranges separating it from other provinces. In the complex it is characterized by a great diversity envi- ronment that allows the engraftment of many plant species. In this paper it contains a list of all the Orchids flora including 88 taxa and 21 hybrids. In turn chorological analysis highlights the prevalence of Mediterranean elements followed by those Eurasian. Keywords: Chieti, Orchidaceae, provincial check-list, floristic contingents. 1. - Inquadramento dell'area d'indagine Il territorio della provincia di Chieti copre la superficie di 2.592 km², com- prende 104 comuni e la sua popolazione attuale e di circa 397000 abitanti. -

Bacino Del Sangro
o o r Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino) n i o a r l Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara r l F e c r gio o f e F.so S. Bia i . o n u R Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito s I c F l' o o T s l n . o e i F o o o o i o i d t d l r n s d l g R e . o a le a f Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino) F s g o i il l . l A V a o e . F s ni o s R F ne . n or a a l T F e l v c . d F o R M F.so R l Gi c L T S. e o T o Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito a a s o . v F t v . n a R i o A o n r n . ovaro o l .so B N a b F e S t a V a o o o o . n a n s i . s s o T r g n . t F i z F s l F i n n e . P.T.A. Sorgenti Solfuree del Lavino P f e s i F r e . o c o o lo a V L l i T e l XW s o l F . g l M .s r n e o C S a F l e an A r a i a i le C . -

Le Abitazioni Non Occupate in Provincia Di Chieti* Testo Della
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE Le abitazioni non occupate in provincia di Chieti* Testo della relazione * Testo della relazione ed elaborazione statistica e cartografica, a partire da dati di fonte ISTAT, di Gerardo MASSIMI. 2 Sommario Il contesto nazionale 3 Il contesto regionale e le specificità della provincia per grandi aggregati 5 Il campo informativo dell'indagine per comune al censimento 1991 10 Osservazioni sull’attività edilizia posteriore al censimento 1991 13 Principali risultati 14 I riferimenti cartografici e statistici 14 Distribuzione territoriale delle abitazioni non occupate 17 Superficie e implicazioni ambientali delle abitazioni non occupate 19 Utilizzo delle abitazioni non occupate 20 Abitazioni non occupate e mercato 23 Età di costruzione dei fabbricati delle abitazioni occupate 24 Figure nel testo Figura 1 Quote percentuali delle abitazioni non occupate nelle province italiane alla data del censimento 1991. 4 Figura 2 Confronto delle tendenze evolutive, nel periodo 1961-1991, tra le province abruzzesi delle abitazioni non occupate. 5 Figura 3 Frequenze relative, percentuali e percentuali cumulate, delle abitazioni non occupate per numero delle stanze (intervallo da 1 stanza a 9 stanze e oltre) al censimento 1991. 7 Figura 4 Consistenza della collaborazione delle amministrazioni comunali con l'ISTAT nel rilevamento dell'attività edilizia in riferimento all'anno 1997. 13 Figura 5 Aggregazione in regioni agrarie dei comuni della provincia di Chieti. 15 Figura 6 Stima (fonte CRESA, 1997) della variazione della popolazione residente nel periodo 1996-2005 a confronto con le percentuali di abitazioni occupate in edifici costruiti prima del 1945. 24 Tabelle nel testo Tabella 1 Elementi caratteristici per grandi aggregati delle abitazioni in provincia di Chieti ai censimenti dal 1961 al 1991. -

Rankings Municipality of Colledimacine
10/2/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Abruzzo / Province of Chieti / Colledimacine Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Altino Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Fresagrandinaria AdminstatArchi logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Frisa Ari ITALIA Furci Arielli Gamberale Atessa Gessopalena Bomba Gissi Borrello Giuliano Bucchianico Teatino Canosa Sannita Guardiagrele Carpineto Guilmi Sinello Lama dei Carunchio Peligni Casacanditella Lanciano Casalanguida Lentella Casalbordino Lettopalena Casalincontrada Liscia Casoli Miglianico Castel Frentano Montazzoli Castelguidone Montebello sul Castiglione Sangro Messer Marino Monteferrante Celenza sul Montelapiano Trigno Montenerodomo Chieti Monteodorisio Civitaluparella Mozzagrogna Civitella Messer Raimondo Orsogna Colledimacine Ortona Colledimezzo Paglieta Crecchio Palena Cupello Palmoli Dogliola Palombaro Fallo Pennadomo Fara Filiorum Pennapiedimonte Petri Perano Fara San Pietraferrazzana Martino Pizzoferrato Powered by Page 3 Filetto Poggiofiorito L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Fossacesia Pollutri Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Fraine PretoroITALIA Francavilla al Quadri Mare Rapino Ripa Teatina Rocca San Giovanni Roccamontepiano Roccascalegna -

Ambito Aventino Colledimacine, Gessopalena, Lama Dei Peligni, Lettopalena, Palena, Taranta Peligna, Torricella Peligna Ambito Sa
AAPPPPEENNDDIIICCEE AA AA))) EELLEENNCCOO CCOOMMUUNNIII DDEELLLL’’’AARREEAA BBAASSSSOO SSAANNGGRROO TTRRIIIGGNNOO EESSCCLLUUSSIII DDAALL PPRREESSEENNTTEE AAVVVVIIISSOO PPUUBBBBLLIIICCOO))) Ambito Aventino Colledimacine, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Palena, Taranta Peligna, Torricella Peligna Ambito Sangro Borrello, Civitaluparella, Colledimezzo, Fallo, Gamberale, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Pennadomo, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, Villa Santa Maria Ambito Alto Vastese Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Fraine, Roccaspinalveti, San Giovanni Lipioni, Schiavi d’Abruzzo, Torrebruna BB))) EELLEENNCCOO DDEEIII CCOOMMUUNNIII CCOOMMPPRREESSIII NNEELL DDIIISSTTRREETTTTOO TTUURRIIISSTTIIICCOO MMAAJJEELLLLAA MMAADDRREE ((( DD...GG...RR... NN... 882211///22001177))) CCOONN EESSCCLLUUSSIIIOONNEE DDIII QQUUEELLLLIII DDEELLLL’’’AARREEAA BBAASSSSOO SSAANNGGRROO TTRRIIIGGNNOO DDIII CCUUIII AALLLLAA LLEETTTTEERRAA ““AA”” Provincia de L’Aquila Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Sangro, Cocullo, Introdacqua, Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Rivisondoli, Roccacasale, Roccapia, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Sulmona, Villalago. Provincia di Pescara Abbateggio, Bolognano, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Manoppello, Roccamorice, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant’Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Tocco da Casauria Provincia -

Actes Dont La Publication Est Une Condition De Leur Applicabilité)
30 . 9 . 88 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 270/ 1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) N° 2984/88 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1988 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1987/1988 en Italie, en Espagne et au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, compte tenu des donnees reçues, il y a lieu de fixer les rendements en Italie, en Espagne et au vu le traité instituant la Communauté économique euro Portugal comme indiqué en annexe I ; péenne, considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22 grasses, septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT : n0 2210/88 (2), vu le règlement (CEE) n0 2261 /84 du Conseil , du 17 Article premier juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive , et aux organisa 1 . En Italie, en Espagne et au Portugal, pour la tions de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le campagne 1987/ 1988 , les rendements en olives et en règlement (CEE) n° 892/88 (4), et notamment son article huile ainsi que les zones de production y afférentes sont 19 , fixés à l'annexe I. 2 . La délimitation des zones de production fait l'objet considérant que, aux fins de l'octroi de l'aide à la produc de l'annexe II . -

Ministero Della Salute, Risultati Dell'analisi Condotta Sui Dati Dati
Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA Ufficio di Statistica Oggetto: Regione Abruzzo – Analisi della rete assistenza ambulatoriale nelle aree interne. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili dal Servizio sanitario nazionale costituiscono il livello essenziale di assistenza garantito dal sistema di sanità pubblica in questo regime di erogazione. Si forniscono di seguito i risultati dell’analisi condotta sui dati sui dati relativi alla rete di assistenza ambulatoriale delle aree interne selezionate dalla Regione Abruzzo, rilevati per l’anno 2012 attraverso le seguenti fonti informative: - Modelli di rilevazione Decreto Ministro della salute 5 dicembre 2006 STS.11 - Dati anagrafici delle strutture sanitarie; STS.21 - Assistenza specialistica territoriale: attività clinica, di laboratorio, di diagnostica per immagini e di diagnostica strumentale. Le informazioni tratte dalle suddette fonti informative consentono di caratterizzare la rete di offerta di assistenza ambulatoriale dei Comuni oggetto di analisi, con riferimento alle strutture sanitarie presenti nelle aree interne (Fonte STS.11) e ai relativi dati di attività (Fonte STS.21 – quadro F). L’analisi è stata condotta sulla base dei dati trasmessi dalla Regione Abruzzo al Ministero della salute, relativamente ai Comuni ricompresi nelle seguenti aree del territorio regionale: BASSO SANGRO – TRIGNO: Borrello, Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, -

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO Via Duca Degli Abruzzi N
COMUNE DI PAGLIETA (Prov. Chieti) - arrivo - Prot. 0012340 del 24-12-2020 - Cat. 13 Cl. 1 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO Via Duca degli Abruzzi n. 104 - Villa Santa Maria (CH) Partita IVA/Codice Fiscale 02466720691 Telefax 0872.944201 sito istituzionale: www.unionemontanadeicomunidelsangro.it pec: [email protected] e-mail: [email protected] Prot. n. 3415 Addì, 22/12/2020 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ORIDNARIO 2020 DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 115 VOLONTARI L’Unione Montana dei Comuni del Sangro Ente Capofila e i Comuni di: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casoli, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Lettopalena, Montazzoli, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Paglieta, Palena, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Roio Del Sangro, Rosello, Tornareccio, Torricella Peligna, Villa Santa Maria, aderenti all’iniziativa, INFORMANO che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ha indetto il Bando per la selezione dei Volontari da avviare al servizio civile entro e non oltre il 30 settembre 2021. Questo Ente unitamente ai Comuni in elenco, è tra i soggetti deputati ad ospitare i volontari di Servizio Civile con n. 4 interventi progettuali e per l’impiego di n. 115 volontari. I settori di intervento, le sedi di attuazione, il numero di volontari da avviare in ogni sede e i relativi progetti sono i seguenti: 1. Cittadinanza Attiva per l’inclusione delle persone fragili: Settore di intervento Assistenza per l’impiego di 26 volontari nelle seguenti sedi di accoglienza: 2 su Archi, 4 su Atessa, 1 su Bomba, 1 su Casoli, 2 su Colledimacine, 2 su Colledimezzo, 2 su Fallo, 1 su Lettopalena, 1 su Montenerodomo, 2 su Palena, 1 su Pennadomo, 2 su Perano, 4 su Villa Santa Maria, 1 Unione Montana dei Comuni del Sangro; 2. -

Spa Orario Automobilistico
E E N N IO IO Z Z A O A I T T T L S A S U R I O O I R O I O O D I I R I L O R I I A N N E A L L N N P A A O T I E L O A A E S S T O C N I E T S S T U U O S I C O T T O U U I T I N E E S R E P S E E O . IV A O R A O A IV . F S S B P T B S C C B S S E L A A D D E I E L U P IA G S O N R T A 'O T E L P L S A C A E L U L E L E D O R E S E A IO R E N A P O D IN U U C D R A H T O A E T E O A V C T Q C O N P N S N N L S A N R I O S E A IA O E E R IA O IV Z O C C P Z S P T P F B E R R A B E E O T C N M IN N A C O E T E IN O I E T E A R Z S T I C R T A A E H Y A T A T S C L M O L S C O L X I O O R A E X O I P G E L I IT H N IT N D T S A A I I E E O S E Z V C M C V F L E L N L Z N N L E A L N A E N N C T IA IT O IA A I H A A A A O A P P C P S B T M S S V F I A O H R C C . -

Espletamento Procedure Di Gara Risultanze
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sulle reti idriche e fognarie nei Comuni dell’A.T.O n° 6 Chietino. GARE D'APPALTO Anno 2015 - ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA RISULTANZE PROVVISORIE n° Importo area Comuni I° classificata provvisoria II° classificata provvisoria ord complessivo Crecchio COLANTUONO GROUP srl di ADEZIO COSTRUZIONI di Ari 1 "A1" Ortona € 130.000,00 Tollo Tollo (CH) (Ch) Ari Arielli Canosa Sannita MOVIMENTO TERRA di Filetto COGEMA SRL Via Aterno, 397 2 "A2" Giuliano Teatino € 100.000,00 Giuseppe GallucciC.da S. Basile, Fraz. Brecciarola -Chieti Orsogna 45 Orsogna (Ch) Poggiofiorito Vacri Villamagna Casacanditella Casoli Civitella M Raimondo S.A.CE.B. srl di San Martino EDILIZIA CANDELORO di 3 "A3" Fara San Martino € 200.000,00 Guardiagrele sulla Marruccina (Ch) Torrevecchia Teatina (CH) San Martino sulla Maruccina Palombaro Pennapiedimonte Fossacesia Mozzagrogna Rocca San Giovanni SORMAN SRL di Fossacesia 4 "B1" € 100.000,00 Nasuti Nicola di Lanciano (CH) S. Eusanio del Sangro (CH) San Vito Chietino Santa Maria Imbaro Frisa CITI snc di Bellisario G&C di POINT Costruzioni di Di Antonio 5 "B2" Lanciano € 200.000,00 Treglio Lanciano Filippo Teramo Casalbordino Castelfrentano DI FLORIO geom C Lorenzo di VITULLI COSTRUZIONI di 6 "B3" Paglieta € 100.000,00 S. Eusanio del Sangro Paglieta (CH) Paglieta (CH) Torino di Sangro Altino Archi VERRATTI VINCENZO di Casoli 7 "B4" Atessa € 100.000,00 SAGAS srl di Offida (AP) Perano (CH) Villalfonsina Cupello ASFALTI TRIGNO srl di Vasto IPRESA MOLINO SRL DI -
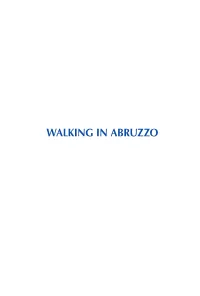
Walking in Abruzzo Walking in Abruzzo
WALKING IN ABRUZZO WALKING IN ABRUZZO About the Author GRAN SASSO, MAIELLA AND ABRUZZO NATIONAL Stuart Haines is a walker, mountain lover, guidebook writer, project man- PARKS, AND SIRENTE-VELINO REGIONAL PARK ager and occasional viticulturalist. His explorations of the remoter cor- ners of central Italy began in 2004, following many years of climbing and by Stuart Haines adventuring in the Alps, North America and his native UK. Since 2007 he has been based between Bristol, England, and Casa La Rocca, the country house in the heart of Abruzzo that he renovated with his partner, Hil. The house offers self-catered accommodation for visitors to the region and is the base for Stuart’s support service for walkers, cyclists and everyone who comes to discover the grandeur of Abruzzo for themselves – route advice, drop-offs and pick-ups, pack transport, overnight booking and the organic Montepulciano d’Abruzzo house wine all available under one roof – www.casalarocca.it. JUNIPER HOUSE, MURLEY MOSS, OXENHOLME ROAD, KENDAL, CUMBRIA LA9 7RL www.cicerone.co.uk © Stuart Haines 2019 Second edition 2019 CONTENTS ISBN: 978 1 85284 978 8 First edition 2011 Map key ...................................................... 9 Overview map ................................................ 10 Location of walks .............................................. 11 Printed in China on behalf of Latitude Press Ltd A catalogue record for this book is available from the British Library. INTRODUCTION ............................................. 13 All photographs are by the author unless otherwise stated. Abruzzo ..................................................... 15 Geological history ............................................. 16 Route mapping by Lovell Johns www.lovelljohns.com Human history ................................................ 17 Contains OpenStreetMap.org data © OpenStreetMap Animals and birds .............................................. 19 contributors, CC-BY-SA. NASA relief data courtesy of ESRI Plants and flowers ............................................ -

Itinerari Di Sacro E Natura Nella Provincia Di Chieti Picciano Cappelle Sul Tavo
Itinerari di Sacro e Natura nella Provincia di Chieti Picciano Cappelle sul Tavo Collecorvino Spoltore Pescara Pretaro 0 10 km Loreto Aprutino Moscufo Sambuceto Francavilla al Mare San Giovanni Teatino Torremontanara N A14 PESCARA SUD Pianella Cerratina FRANCAVILLA AL MARE Stazione di Tollo PESCARA OVEST Torrevecchia Teatina CHIETI Villanova Lido Riccio Chieti Scalo Savini Castelferrato S. Salvatore O E Cepagatti Miglianico 11 Ortona Villa 1 Ripa Teatina San Tommaso ro Villa Badessa o o Tollo Villa t F Villareia n e San Nicola le ChietiA m CHIETI u e i ORTONA SS 16 m F A25 iu Villamagna Punta di Acquabella S F a ar Collesecco Carpineto sc Civitaquana Nocciano Pe Brecciarola Villa della Nora e E 90 m SS 5 Grande Villa u Casino Rosciano Fi San Rocco S. Leonardo Vezzani San Vito Chietino Bucchianico Villa La percezione che da sempre l’uomo ha avuto della realtà è quella di un nesso inscin- Marina di San Vito Cugnoli Casalincontrada Giuliano Villa Tucci Torre Teatino Villa Alanno Vacri Rogatti 2 Ari dibile tra “sacro e natura”, quel che di misterioso che solo oggi sta perdendo quella Villa Caldari S. Apollinare SS 81 Colle Spaccato 10 Canosa Sannita Mancini Villa San Giovanni o n Corvara i r t l LANCIANO San Pietro Fe Punta del Cavalluccio suggestione e quel valore che ha distinto per millenni il cammino dell’umanità. Reginaldo e Semivicoli Crecchiot o en Puncichitti r rr La Penna o To Treglio M Terranova e Pescosansonesco t Frisa Rocca San Giovanni Viano n Fara Filiorum Petri Arielli e Il territorio della provincia di Chieti vanta tra le