Il Territorio Adriatico
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gfk Italia CERTIFICAZIONI ALBUM Fisici E Digitali Relative Alla Settimana 47 Del 2019 LEGENDA New Award
GfK Italia CERTIFICAZIONI ALBUM fisici e digitali relative alla settimana 47 del 2019 LEGENDA New Award Settimana di Titolo Artista Etichetta Distributore Release Date Certificazione premiazione ZERONOVETOUR PRESENTE RENATO ZERO TATTICA RECORD SERVICE 2009/03/20 DIAMANTE 19/2010 TRACKS 2 VASCO ROSSI CAPITOL UNIVERSAL MUSIC 2009/11/27 DIAMANTE 40/2010 ARRIVEDERCI, MOSTRO! LIGABUE WARNER BROS WMI 2010/05/11 DIAMANTE 42/2010 VIVERE O NIENTE VASCO ROSSI CAPITOL UNIVERSAL MUSIC 2011/03/29 DIAMANTE 19/2011 VIVA I ROMANTICI MODA' ULTRASUONI ARTIST FIRST 2011/02/16 DIAMANTE 32/2011 ORA JOVANOTTI UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC 2011/01/24 DIAMANTE 46/2011 21 ADELE BB (XL REC.) SELF 2011/01/25 8 PLATINO 52/2013 L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE TIZIANO FERRO CAPITOL UNIVERSAL MUSIC 2011/11/28 8 PLATINO 52/2013 TZN-THE BEST OF TIZIANO FERRO TIZIANO FERRO CAPITOL UNIVERSAL MUSIC 2014/11/25 8 PLATINO 15/2017 MONDOVISIONE LIGABUE ZOO APERTO WMI 2013/11/26 7 PLATINO 18/2015 LE MIGLIORI MINACELENTANO CLAN CELENTANO SRL - PDU MUSIC SONY MUSIC ENTERTAINMENT 2016/11/11 7 PLATINO 12/2018 INEDITO LAURA PAUSINI ATLANTIC WMI 2011/11/11 6 PLATINO 52/2013 BACKUP 1987-2012 IL BEST JOVANOTTI UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC 2012/11/27 6 PLATINO 18/2015 SONO INNOCENTE VASCO ROSSI CAPITOL UNIVERSAL MUSIC 2014/11/04 6 PLATINO 39/2015 CHRISTMAS MICHAEL BUBLE' WARNER BROS WMI 2011/10/25 6 PLATINO 51/2016 ÷ ED SHEERAN ATLANTIC WMI 2017/03/03 6 PLATINO 44/2019 CHOCABECK ZUCCHERO UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC 2010/10/28 5 PLATINO 52/2013 ALI E RADICI EROS RAMAZZOTTI RCA ITALIANA SONY MUSIC ENTERTAINMENT 2009/05/22 5 PLATINO 52/2013 NOI EROS RAMAZZOTTI UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC 2012/11/13 5 PLATINO 12/2015 LORENZO 2015 CC. -
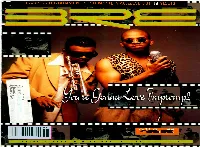
Ls 5 2 7 4 8/1 1 / 9 5 MI K E OSB O R N E WB R U 88 BE
Ls5274 8/11/95 MIKE OSBORNE WBRU 88 BENEVOLENT SI PROVIDENCE RI 02906 CLUB NOUVEAU RIp-It Records A Deleon Of Bar-Be' Jet Enterteinfnent Group. Inc. vc_rythins I black flaturing tfl.(_ hit ins,1 as 1.«IL It QIP-IT QE:20112D6 • 715 N. Ferncreck Ave. • Olando. FL 5280_ • (407) 898-2009 AUGUST II, 1995 VOLUME XIX NUMBER 23 Cover Story Impromp2 24 s e clt Publisher's Page 5 News 6 Music Report I 0 Music Reviews 16 Yesteryear/Starview 46 csalluLarirwase Jazz Notes I 5 BRE Flix 18 Video Visions 20 Hip Hop Era 21 In Other Media 22 Gospel 23 last Word 46 cilkvarties 19r. iress ea• miii Singles Chart 12 Album Chart 14 The Sweetest Sixteen New Music 9 Jan Chart 15 Not even a full year has passed since Brandy's self-titled debut album on Atlantic hit the market, ne./3 icsrua w eipmsa rt s and this sixteen-year-old is at the top of the R&B heap. She beat out such multi-platinum artists as Carolinas 27 Mid Atlantic 29 Janet Jackson, Mary J. Blige, and Anita Baker at the Lady Of Soup Awards. She strolled away with four Ohio Valley 30 of the coveted statuettes, winning in every category she was nominated. On top of all of this, Brandy North East 31 Mid South 33 was named spokeswoman for the 1995 Sears/Seventeen Peak Performance Scholarship Program and Mid West 35 Tour. The program's aim is to empower and help young women achieve their personal goals. South East 39 West 41 Here's to the little lady of soul. -

Artisti Italiani Sun, 29
Artisti Italiani www.redmoonrecords.com Artista Titolo ID Formato Etichetta Stampa N°Cat. / Barcode Condition Price Note 24 GRANA Underpop 32842 1xCD La canzonetta Self IT 80124323000292 USED 8,00 € Digipack 360 GRADI Farenight 16088 1xCD Universal EU 731454280723 USED 7,00 € 6 SUOI EX Paola non è un uomo 10701 1x12" Emergency music IT 74321-10125-1 EX+/EX 6,00 € BMG 883 1 in + 3370 1xCD Warner GER USED 7,00 € 883 Grazie mille 19068 1xCD Marton corp. RTI IT 5099749617421 USED 7,00 € Without OBI & 3D glasses 883 / MAX PEZZALI Hanno ucciso l'uomo ragno 2012 33892 1xCD Atlantic Warner EU 5053105299829 USED 7,00 € 883 / MAX PEZZALI Le canzoni alla radio di Max Pezzali & 883 21516 2xCD Atlantic Warner EU 5054197920622 USED 10,00 € Best of + 8 new tracks 99 POSSE Cattivi guagliuni 27940 1xCD Musica Posse / IT 8033954531483 USED 8,00 € Novenove / Artist first 99 POSSE Cerco tiempo 26275 2xCD BMG Ricordi IT 0743215707226 USED 10,00 € 99 POSSE Comincia adesso remix (9 tracks+1 video track) 25305 1xCDs Tutto IT none USED 3,00 € Free CD with magazine "Tutto" - Enhanced CD 99 POSSE Corto circuito 13061 1xCD RCA BMG EUEU 0743215804222 USED 7,00 € Enhanced CD 99 POSSE La vida que vendrà 27980 1xCD Novenove BMG IT 0743217370022 USED 8,00 € Ricordi 99 POSSE NA 90 10° 29768 2xCD Novenove RCA BMG IT 0743218952128 USED 10,00 € A.L.I.A.S. Se io se lei (2 tracks) 14059 1xCDs Clacsonic Universal IT 9810438 USED 3,00 € ABIOGENESI Le notti di Salem 5931 1xCD Black widow IT BWRCD046-2 12,90 € ACCADEMIA Accademia in classics part one & two 17119 1x7" Ariston Ricordi -

SAN GIUSEPPE to R N a La Fiera in Via D'azeglio
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENERDÌ 16 MARZO 2018 23 GAZZETTA WEEKEND PARMA E PROVINCIA PA R M A A L BA R E TO A SPASSO IN CENTRO PRIMA LEZIONE E POI A COLORNO DEL NONO CORSO CON MARIA LUIGIA POTATURA E INNESTO Si intitola “A spasso con Maria Si svolgerà domani sera e do- Luigia d’Au st r i a ”, ed è la prima menica la prima lezione del 9° iniziativa del nuovo itinerario corso di potatura ed innesto. tematico “I castelli delle don- Domani dalle 20 nei locali del n e”. Questa domenica ci sarà centro ricreativo parrocchiale una passeggiata nel Centro si terrà la lezione teorica e Storico di Parma in compagnia dalle 9 di domenica (18) prova della Gran Duchessa che ini- pratica in un frutteto di Al- zierà con la visita al museo bareto. Le lezioni del corso Glauco Lombardi per prose- saranno tenute dal professor guire nelle vie della città, se- Giovanni Rigo tecnico del guendo le passioni di Maria consorzio provinciale or- Luigia, la musica e, durante la to-frutticultura di Verona. Per pausa pranzo, i sapori della informazioni Paola: buona tavola con particolare 0525-999785-oppure Rita riferimento ai dolci. Poi al po- 10525 999344 g.c. meriggio il gran finale con la visita alla reggia di Colorno. Prenotazione -

Accademia Musicale
Nuova ONORANZE FUNEBRI Rosate Albini & Beretta Luigi Stefano FUNERALI • TRASPORTI • CREMAZIONI Rosate (MI) ABBIATEGRASSO via De Gasperi, 8 viale Papa Giovanni XXIII, 19 tel. 02 9084 8757 Tel. 02 8421 1998 [email protected] (24 ORE SU 24) all’interno L’AccademiaL’Accademia ABBIATENSE ABBIATEGRASSO Aspettando la ZTL, le auto tornano in piazza Castello. >… PAG. 5 sisi fafa inin duedue ABBIATEGRASSO Per due mesi e solo il venerdì: riecco lo shopping bus >… PAG. 5 ABBIATEGRASSO Teatro, la Foto archivio Comune di Abbiategrasso rassegna per i più piccoli “raddoppia” >… PAG. 7 ABBIATEGRASSO Ambasciata del Gusto, è tempo di un bilancio >… PAG. 8 Mentre per l’ensemble aumentano gli impegni “fuori porta”, ALBAIRATE In Biblioteca una e con questi i riconoscimenti, ad Abbiategrasso sta per prendere serata dedicata alla vita e al il via una nuova stagione di concerti nel segno del dialogo tra musica genio di Einstein >… PAG. 9 e poesia. Intanto l’Accademia tenta il non semplice compito di seguire allo stesso tempo ”vecchi” e “nuovi” studenti della scuola. Un obiettivo per cui servono risorse, a partire da un locale a disposizione. >… PAG. 2-3 OZZERO Sull’impianto di Cascina Sega l’opposizione attacca la giunta>… PAG. 13 ABBIATEGRASSO ABBIATEGRASSO OZZERO Accampamenti abusivi, Ozzero spera siano La scuola sempre tra le priorità del Comune Quattro idee per far vivere il “vecchio Golgi” solo un ricordo >… PAG. 14 Un investimento di 1,4 milioni di Un’infrastruttura di coesione so- euro e nessun taglio ai servizi ciale, un polo tecnologico per GAGGIANO Appaltati i lavori scolastici. Questo il “biglietto da l’innovazione, una cittadella del- per la nuova piazza Daccò visita” del nuovo Piano per il di- la moda, un polo esterno di ricer- ritto allo studio >… PAG. -
2016-5 Io Sono Una Missione
in questo numero Editoriale io sono una missione di Nico Dal Molin Il viaggio ha sempre affascinato l’uomo; è una metafora semplice e incisiva che vede la persona umana come essere dinamico, alla ricerca di orizzonti avvincenti e nuovi, anche se ciò comporta rischi e pericoli di frontiere nuove da varcare. Magnificat, la grammatica della misericordia di Giuseppe De Virgilio Il cantico di Maria (Lc 1,46-55) si distingue per la sua ricchezza letteraria e la sua rilevanza teologica. La Vergine esalta l’opera di Dio nella storia della salvezza, che ha come centro dinamico l’amo- re misericordioso e fedele. Attraverso il Magnificat Maria illumina il cammino vocazionale di ogni credente. La gioia che riempie la vita di Emilio Rocchi «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di colo- ro che si incontrano con Gesù»: con queste parole Papa Francesco propone il programma del suo pontificato in Evangelii gaudium. Di questo documento approfondiamo alcune prospettive evidenzian- do la necessità di una cultura della vocazione e la forza propositiva della gioia evangelica. Accompagnare da persona... a persona di Michele Gianola Nella pastorale vocazionale il termine “accompagnare” viene de- clinato nella prospettiva che la Tradizione della Chiesa ci consegna nella direzione spirituale, nel dialogo di coscienza, negli stili del di- scernimento vocazionale. I passaggi di Evangelii gaudium qui propo- sti ci provocano a considerazioni ulteriori e forse inusuali. Verso le periferie con misericordia di Mario Aversano Quale immagine di Chiesa e di ministero ispira chi desidera con- sacrare la propria vita a Dio? L’invito della misericordia provoca a muoversi verso le periferie per annunciare all’uomo l’incontro li- berante con Gesù Cristo; sollecita ad esplorare le proprie periferie esistenziali, lasciandoci abbracciare dalla tenerezza di Dio. -
Francesca Michielin
VENERDì 2 OTTOBRE 2015 E' online da oggi su Vevo il video di 'Lontano', il nuovo singolo di Francesca Michielin, che arriva dopo il successo radiofonico, di pubblico e di critica dei precedenti 'L'Amore esiste' (platino) e 'Battito di Francesca Michielin: è online il ciglia'. Il brano anticipa 'di20', l'atteso album in uscita il 23 ottobre ma in video del nuovo singolo preorder già dal 9 ottobre. elettro-pop 'Lontano' Ad inaugurare il progetto discografico un appuntamento esclusivo: la cantauatrice sarà infatti protagonista di un concerto unico che si Il 21 ottobre concerto per il lancio di 'di20' svolgerà il 21 ottobre presso Unicredit Pavilion (piazza Gae Aulenti 10). Un l'atteso album della cantautrice in uscita il 23 live imperdibile durante il quale l'artista presenterà ufficialmente e per la ottobre prima volta al pubblico il suo disco, frutto di un lungo lavoro di ricerca, scrittura e produzione, che mette in luce una "nuova" Francesca, la sua maturità artistica, le sue spiccate doti cantautorali e di musicista. LA REDAZIONE Una Francesca Michelin inedita si ritrova anche nel videoclip di "Lontano": più femminile, con un look e uno stile nuovi che la rappresentano molto, divertente e divertita davanti alla telecamera, la [email protected] giovane cantautrice non perde però la freschezza, la naturalezza e la SPETTACOLINEWS.IT spontaneità che da sempre la contraddistinguono. E' questa e molto altro la "nuova" Francesca. Diretto da Giacomo Triglia, il videoclip è stato girato utilizzando in anteprima italiana un nuovissimo modello di camera cinematografica presentato al NAB 2015, che permette di ottenere immagini straordinarie e di grande qualità. -
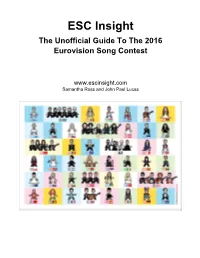
ESC Insight the Unofficial Guide to the 2016 Eurovision Song Contest
ESC Insight The Unofficial Guide To The 2016 Eurovision Song Contest www.escinsight.com Samantha Ross and John Paul Lucas Table of Contents Editors’ Introduction....................................................................................................................... 5 Albania........................................................................................................................................... 6 Armenia......................................................................................................................................... 8 Australia....................................................................................................................................... 10 Austria......................................................................................................................................... 12 Azerbaijan.................................................................................................................................... 14 Belarus........................................................................................................................................ 16 Belgium........................................................................................................................................ 18 Bosnia & Herzegovina................................................................................................................. 20 Bulgaria...................................................................................................................................... -

Rassegna Stampa
Rassegna de Il Giornale della Protezione Civile 24-08-2018 NAZIONALE Due anni dopo, macerie e sfollati Il sisma infinito nel cuore dell`Italia QUOTIDIANO NAZIONALE 24/08/2018 12 9 Rita Bartolomei Notte nel paese fantasma: Restiamo qui QUOTIDIANO NAZIONALE 24/08/2018 13 11 Gigi Mancini Incendiata la roulotte dei giostrai QUOTIDIANO NAZIONALE 24/08/2018 21 13 Redazione Genova, adesso monta la rabbia Fateci riprendere le nostre vite AVVENIRE 24/08/2018 12 14 Paolo Ferrario Sisma , 2.000 cantieri Ma la strada è lunga = Sisma , 2mila cantieri avviati Ma la 24/08/2018 13 strada è ancora lunga 16 AVVENIRE Alessia Guerrieri Foto choc sul Rosa, allarme sicurezza CORRIERE DELLA SERA 24/08/2018 25 18 P.virt. A due anni dal sisma ancora nessuna risposta FATTO QUOTIDIANO 24/08/2018 10 19 Mauro Chiostri Amatrice due anni dopo: manca il 15% delle casette = A due anni dal sisma di 24/08/2018 13 Amatrice manca ancora il 15% delle "\casette " 20 FATTO QUOTIDIANO Marco Palombi Sono quasi 1500 i colpiti dal sisma che si trovano ancora negli alberghi LIBERO 24/08/2018 10 22 Redazione Due anni dopo il terremoto Amatrice resta sotto le macerie LIBERO 24/08/2018 10 23 Salvatore Dama In tilt per le piogge la Sardegna chiede lo stato d`emergenza LIBERO 24/08/2018 10 25 Redazione Facciamo come con le auto: un sistema di revisioni e banca dati degli immobili LIBERO 24/08/2018 11 26 Nicola Apollonio Dopo 2 anni Amatrice ancora sotto le macerie = Il nulla a due anni dal terremoto 24/08/2018 7 Amatrice è una distesa di macerie 27 NOTIZIA GIORNALE Carmine Gazzani E -

Posata La Passerella Che Collega Cusano Milanino Con Il Parco Nord
MusicaOltre 2008 Quattro serate di musica folk in piazza del Comune dal 4 al 12 luglio Segue a pag. 12 Numero 3 - Anno XXII NOTIZIARIO COMUNALE DI CUSANO MILANINO Luglio 2008 Posata la passerella che collega Cusano Milanino con il Parco Nord La struttura, scavalcando l’A4 all’altezza di via Petrarca a Cinisello, consentirà di raggiungere facilmente in bicicletta il Parco Nord e da qui Milano Torre dell’ACQuedotto ripartono i laVori Sono ripresi i lavori per la ri- strutturazione della Torre del- l’Acquedotto di viale Buffoli, dopo un’interru- zione di circa un anno dovuta a difficoltà proget- tuali e tecniche Lunedì 16 giugno 2008, la passerella il giorno dopo la posa sull’A4 Autunno 2008, la passerella una volta conclusi i lavori di rifinitura indipedenti dalla re 1,30 della notte tra il 14 e il 15 giugno. Autostrada A4, tra perfettamente sui supporti in cemento armato e acciaio, realizzati nei volontà dell’Am- via Petrarca a Cinisello e il Parco Nord a Bresso. Dalle finestre delle mesi precedenti. Mezz’ora dopo, alle 2,30 circa, la passerella è posa- ministrazione. A O inizio luglio il Co- ta e hanno inizio i lavori di fissaggio, che dureranno fino all’alba. Alle case e sulle strade curiosi insonni seguono le operazioni con il fiato mune ha consegnato il cantiere all’azienda sospeso. Due gru, una enorme di oltre 30 metri, sono ferme in auto- 6 del mattino di domenica 15 giugno l’autostrada viene riaperta. Gli vincitrice dell’appalto, per la realizzazione strada: stanno agganciando la passerella. -

Cantina La Tavernetta: Mangiare Pesce Nella B Nuovaisson Location Immersa Senza Svenarsi (Pag
Vuoi imparare a usare COMPUTER, TABLET E TELEFONINO? La testata più diffusa del Levante Anno XXII n.206 giugno 2019 20.000CorFoLe copie gratuite | In tutte le famiglie da 22 anni | Indipendente | No finanziamenti pubblici | Carta riciclata 100% Chiamaci: 0185.938009 Buon compleanno CURIOSITÀ elettorali Tunnel di Ferriere Il Sindaco “immigrato”, chi non ha preso Inaugurato il 15 giugno 1971, era un collegamento autostradale e il pedaggio nemmeno un voto, chi si trova allo era di 300 lire per l’andata e 350 lire per andata e ritorno. (Pag. 10) spareggio e chi ha vinto con l’aratro - Pag. 3 IL RIStorante DEL MESE Cantina La Tavernetta: mangiare pesce Nella B nuovaisson location immersa senza svenarsi (Pag. 17) nei vitigni che ospita anche eventi e degustazioni (Pag. 6) la Storia È un medico di Camogli Sei ex deejay si il miglior sommelier di Liguria (Pag. 7) ritrovano dopo 20 anni per fare Liguri più magri radio “come grazie alla una volta” FOCACCIA (Pag. 7) (Pag. 10) È quasi radio Sulle colline di da SEGNARE Lavagna per una bella Casarza capitale ESCURSIONE (Pag. 16) del fumetto (Pag. 11) BUONMESE di Giansandro Rosasco Essere fedeli non conviene! Quando ero alto un soldo di cacio la mia famiglia raccoglieva i punti della Miralanza e il mio lasciare mail, telefono, gruppo sanguigno e numero delle scarpe per profilarci e venderci compito era cercare il cartoncino e ripulirlo dal detersivo. Probabilmente sniffavo un po’ di qualcosa più avanti. E il “bello” è che non si vince mai niente! “Eh, mi dispiace, non hai vinto. polvere cancerogena ma ero, come tanti coetanei, profumato e contento. -

La Cantautrice Multiplatino Francesca Michielin Torna Con Un Nuovo
GIOVEDì 22 OTTOBRE 2015 Ha collezionato dischi di platino ed è stata l'unica artista italiana tra star internazionali a prendere parte alla colonna sonora del colossal 'Spider-Man 2 - Il Potere di Electro'. Dopo il successo radiofonico, di La cantautrice multiplatino pubblico e di critica dei singoli 'L'Amore esiste' (platino), 'Battito di ciglia' Francesca Michielin torna con un (una delle hit dell'estate 2015), i cui video contano oltre 22 milioni di nuovo, attesissimo album di visualizzazioni e del nuovo singolo 'Lontano', Francesca Michielin torna inediti dalle sonorità internazionali con un nuovo, attesissimo album di inediti, 'di20', nei negozi e in digitale da domani, 23 ottobre. 'di20' Un disco dalle sonorità elettro-pop e dal respiro internazionale, frutto di Da domani, 23 ottobre, nei negozi e in digitale un lungo lavoro di ricerca, di scrittura e di produzione, che mette in luce una "nuova" Francesca, la sua nuova maturità artistica e le sue spiccate doti cantautorali e di musicista. LA REDAZIONE La giovane cantautrice presenta un album che la rappresenta al 100%. Come indicato dal titolo, "di20" racchiude molto di sé: venti come la sua età, ma anche "diventare", ovvero il suo percorso di crescita in musica, la [email protected] sua visione della vita e del mondo che la circonda. "di20" sono tutte le SPETTACOLINEWS.IT sfaccettature di Francesca Michielin tradotte in 11 straordinarie canzoni: le hit "L'amore esiste", che ha inaugurato il progetto, "Battito di ciglia" e "Lontano", due brani in inglese "Amazing" e Sons and Brothers, pezzi più autobiografici come "Divento" e "25 febbraio", cui si affiancano gli altri inediti coinvolgenti inediti, "Almeno tu", "Tutto questo vento", "Un cuore in due" e "Io e te".