Estratto Sulpasso-In Limine.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Elenco Di Consistenza Del
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA ELENCO DI CONSISTENZA DEL FONDO MICHELE CANTARELLA Censimento delle carte al maggio 2010 a cura di Eleonora Giaquinto Nota preliminare La documentazione, divisa in ventuno buste, si presenta tuttora priva di ordinamento organico e numerazione delle carte. Le buste indicate nell’elenco con i numeri provvisori 1-16 contengono carteggio, fotografie e stralci di periodici, manoscritti e inviti, in prevalenza attinenti all’archivio di Michele Cantarella. Parte della documentazione, in alcuni casi non facilmente separabile dal complesso principale, è stata prodotta invece dalla moglie Helene Paquin Cantarella, traduttrice, e si configura come un archivio aggregato. Molto materiale riguarda Gaetano Salvemini, del quale Michele Cantarella curò la bibliografia. Di questa opera si conserva nelle carte di Cantarella grandissima parte del lavoro preparatorio. Sempre di Gaetano Salvemini si conservano qui manoscritti autografi e dattiloscritti delle traduzioni in lingua inglese realizzate per lui da H. Cantarella. Nelle buste provvisoriamente indicate coi numeri 17-21 si conservano invece alcuni periodici e opuscoli a stampa, donati dal produttore all’Istituto e in parte usati per la bibliografia. A causa del poco tempo a disposizione per il presente intervento, non si è potuto procedere al riordino, ma solo alla realizzazione di un censimento del contenuto del fondo. In conseguenza di ciò non è stato possibile naturalmente né spostare alcuna carta, né procedere alla numerazione delle stesse. Quindi i numeri indicati nella descrizione, sia quelli delle buste che quelli dei fascicoli provvisori, già esistenti o formati nel corso dell’intervento, hanno il solo scopo di dare un’idea sommaria della consistenza del fondo nel suo complesso. -

Renata Calabresi
Intellectuals Displaced from Fascist Italy Firenze University Press 2019- Renata Calabresi Go to personal file Among the thousands of displaced scholars assisted by the Emergency Link alle connesse Vite in movimento: Committee of New York, she is the only Italian woman for whom a grant was arranged. Even before the anti-Jewish laws, she had encountered difficulties Enzo Bonaventura Cecilia Calabresi in her university career, as a scholar of experimental psychology, a woman Massimo Calabresi Paul Calabresi and an anti-fascist, connected to Professor Salvemini and the Rosselli family. Marion Cave Rosselli She sailed to the United States on her own, on the Conte di Savoia, two Carla Coen Pekelis Guglielmo Ferrero months after her cardiologist brother. After countless obstacles and jobs, Leo Ferrero without having yet settled down, she came to Italy in 1947 and left again on a Bianca Maria Finzi Contini Calabresi TWA flight. In New York, she became an established clinical psychologist. Alessandro Levi Nino Levi Gina Lombroso A bright girl Ferrero Sarina Nathan Levi She was the eldest of the three children of the industrialist Ettore Calabresi Alexander Pekelis Amelia Pincherle (1870-1937) and Olga Minerbi (1876-1964), born on 2 November 1899 in Moravia Rosselli Ferrara to a well-to-do family well known in the city. She attended the Ariosto Carlo Rosselli Nello Rosselli classical high school, where girls could be counted on the fingers of one Gaetano Salvemini Maria Todesco Rosselli hand. Then, instead of enrolling at the University of Ferrara, which did have an ancient tradition, she enrolled at the Alma Mater in Bologna; and in her third year, in 1919, she decided to move to Florence, to the highly recommended Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, in the Philosophy Department. -

Renato Poggioli. Between History and Literature
Pagine di storia della slavistica Studi Slavistici x (2013): 301-310 Roberto Ludovico Renato Poggioli. Between History and Literature Until the year 2007 only two critical articles had been written on Renato Poggioli: one by his colleague at Harvard University Dante Della Terza in 1971 (Della Terza 1971), and two much more recent ones: by Giuseppe Ghini (2005), and by the Belgian scholar Laurent Béghin (2005). In addition to these two articles, Ghini had circulated a short but informative bio-bibliographical document dated 2005 on the internet. These three scholars, with over a dozen others, including historians, slavicists, italianists, and comparativists, ani- mated a three-day symposium dedicated to Renato Poggioli’s centennial by three American Universities in 2007: the University of Massachusetts Amherst, Brown University and Har- vard University. The intent of the symposium was to reignite interest in Poggioli and to re- evaluate the role he had in the twentieth century’s international literary debate. Since then a number of new publications (see for instance Pavese, Poggioli 2010), newspaper articles (Pirani 2008; Canali 2008), conferences1, reprints of Poggioli’s work (Poggioli 2012), and even television broadcasts2 have contributed to rediscovering Renato Poggioli and his legacy as a scholar and as an intellectual. The collection of essaysRenato Poggioli. An Intellectual Biography, edited by the three organizers of the 2007 symposium – Lino Pertile, Massimo Riva and myself – is the first book-length publication entirely dedicated to Poggioli. Far from wanting to provide an annotated bibliography of critical literature on Pog- gioli, these few introductory notes are meant to suggest that the scarce presence of his name in literary criticism after his death in 1963 is strictly connected with his cultural profile and the unusual trajectory of the biographical events that led him to leave Florence and Italy to pursue a career as Professor of Slavic Studies and Comparative Literature at Harvard Uni- versity. -
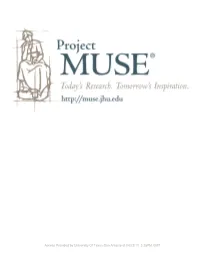
Access Provided by University of Texas-San Antonio at 04/22/11 3:28PM GMT Introduction
Access Provided by University Of Texas-San Antonio at 04/22/11 3:28PM GMT Introduction Jonathan P. Eburne and Rita Felski hat is an avant-garde? In posing such a question, this is- sue of New Literary History seeks to reexamine a category that Woften seems all too self-evident. Our aim is not to draw up a fresh list of definitions, specifications, and prescriptions but to explore the conditions and repercussions of the question itself. In the spirit of analogously titled queries—from Kant’s “What is Enlightenment?” to Foucault’s “What is an Author?”—we hope to spur reflection not only on a particular object of study but also on the frameworks and critical faculties that we bring to bear on it. As Paul Mann notes, every critical text on the avant-garde, whether tacitly or overtly, “has a stake in the avant-garde, in its force or destruction, in its survival or death (or both).”1 A reassessment of these stakes is one of the priorities of this special issue. Narratives of the avant-garde abound. Whether they come to bury the avant-garde or to praise it, these narratives are typically organized around moments of shock, rupture, and youthful revolt that speak to certain beliefs about the functions of experimental art and the nature of historical change. In his 1968 Theory of the Avant-Garde, for instance, Renato Poggioli describes two major phases in the development of the avant-garde. The first stage is anchored in the leftist politics of the 1840s and the 1870s, where the notion of an advanced guard serves to authorize the political agitations and underground activities that helped trigger the revolutionary events of 1848 and the Paris Commune. -

Primitivism in Modernist Literature: a Study of Eliot, Woolf and Lawrence
PRIMITIVISM IN MODERNIST LITERATURE: A STUDY OF ELIOT, WOOLF AND LAWRENCE A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by William Christopher Van Esveld May 2012 © 2012 William Christopher Van Esveld PRIMITIVISM IN MODERNIST LITERATURE: A STUDY OF ELIOT, WOOLF AND LAWRENCE William Christopher Van Esveld, Ph.D. Cornell University 2012 The subjects of “civilization” are trapped in an alienating, inauthentic culture, but can escape by cultivating the “primitive” hidden within themselves: grotesque, even terrifying, but authentic in its drives, desires and relationship to the world. Known as primitivism, this diagnosis of cultural failure and its purported cure profoundly influenced modernist artists. Beyond the succès de scandale they enjoyed by inverting the hierarchy of savage and civilized, primitivists claimed to speak from a position that was, as Eliot put it, “deeper” and “older” than – and uncontaminated by – their culture. They plumbed an unchanging, inner essence, of which they saw glimpses everywhere from ancient artifacts and African masks to drawings by children and mental patients. The rediscovery of primitive mentality thus promised to overcome modernity’s characteristic epistemological anxiety – what James Clifford called “off-centeredness in a world of distinct meaning systems.” Yet while primitivism revalued the stereotype of the savage and prized the primitive as mysterious and unknowable, it never overcame the objectifying view that “primitives” were fundamentally all the same, and important primarily as a window onto suppressed aspects of the civilized personality. Primitivism informed (and in some cases deformed) Eliot’s, Woolf’s and Lawrence’s critical social theories, their justifications for writing and publishing, and their understanding of their own aesthetic projects. -

The Other Side of the Story by the Same Author
THE OTHER SIDE OF THE STORY BY THE SAME AUTHOR Ideas of Order in the Novels of Thomas Pynchon Class Porn ( ( ( (( ( $ %$% "(( $ $"( ($! '( #$( $&( 8C5%22O 5.L%CD.JNO C%DDO }pupÓ pwÓ wÓ Open access edition funded by the National Endowment for the Humanities/ Andrew W. Mellon Foundation Humanities Open Book Program. Copyright © 1989 by Cornell University All rights reserved. Except for brief quotations in a review, this book, or parts thereof, must not be reproduced in any form without permission in writing from the publisher. For information, address Cornell University Press, Sage House, 512 East State Street, Ithaca, New York 14850, or visit our website at cornellpress.cornell.edu. First published 1989 by Cornell University Press First printing, Cornell Paperbacks, 1992 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Hite, Molly, 1947– The other side of the story : structures and strategies of contemporary feminist narrative / Molly Hite. p. cm. Includes index. ISBN-13: 978-0-8014-2164-8 (cloth) — ISBN-13: 978-0-8014-8017-1 (pbk.) 1. English fiction—Women authors—History and criticism. 2. English fiction—20th century—History and criticism. 3. Feminism and literature— History—20th century. 4. Narration (Rhetoric) 5. Rhys, Jean—Technique. 6. Lessing, Doris May, 1919– Golden notebooks. 7. Walker, Alice, 1944– Color purple. 8. Atwood, Margaret Eleanor, 1939– Lady Oracle. I. Title. PR888.F45H58 1989 823'.914'099287—dc19 89-776 The text of this book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ For Patricia G. Hite and F. -

Curriculum Vitae 1. Name, Position Massimo Riva, Professor
Massimo Riva -- Curriculum Vitae 1. Name, position Massimo Riva, Professor, Department of Italian Studies 2. Education Laurea in Filosofia, University of Florence, Italy (1981) Ph.D. in Italian Literature, Rutgers University, New Brunswick, N.J. (1986) Dissertation topic: Melancholy in Neoclassical Italian Literature 3. Professional appointments (tenure-track) 1983-85 Lecturer of Italian, University of Sydney, NSW, Australia 1987-89 Assistant Professor of French and Italian (tenure track), University of Massachusetts at Amherst 1990-93 Assistant Professor of Italian Studies, Brown U. (tenure track) 1993-2002 Associate Professor of Italian Studies, Brown U. (with tenure) 2002- Professor of Italian Studies, Brown U. 2002- Courtesy appointment (affiliated faculty), Dept. of Modern Culture and Media 2015-18 Royce Family Professor of Teaching Excellence, Brown University Visiting appointments Visiting Lecturer, University of Colorado at Boulder, Co., Spring 1986 Visiting Assistant Professor of French and Italian, Northwestern University, Evanston, Ill., 1986-87 Visiting Exchange Professor, University for Foreigners, Siena, Italy, 1989-90 Visiting Associate Professor of Italian, University of Connecticut at Storrs, Ct. Spring, 1996-98 Visiting Professor, Free University IULM, Milan, Italy, Fall 2002 and 2008 Visiting Professor, Facultad de Filosofia Y Letras, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2007 Directeur de Recherche, Ecole Pratiques des Hautes Études, Paris, Spring, 2010 Dorothy Ford Wiley Visiting Professor, University of North Carolina -

The Influence of James Joyce on Bohumil Hrabal: Stylistic Experimentation and Epiphanies of the Everyday
UNIVERZITA KARLOVA Filozofická Fakulta Ústav anglofonních literatur a kultur The Influence of James Joyce on Bohumil Hrabal: Stylistic Experimentation and Epiphanies of the Everyday Master’s Thesis Zpracoval (author): Zachariah Mullen Studijní obor (field of study): Critical and Cultural Theory Vedoucí diplomové práce (supervisor): Mgr. David Vichnar, Ph.D. Rok (Year of defense): 2018 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatn, že jsem ádn citoval všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia i k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze dne I declare that the following MA thesis is my own work for which I used only the sources and literature mentioned, and that this thesis has not been used in the course of other university studies or in order to acquire the same or another type of diploma. In Prague, Acknowledgements: It is only fair and proper to begin this section with a thanks to Bohumil Hrabal for finding his way into my life via a box of books in translation discovered in a charity book store by professor Vic Bobb from Whitworth University. Talk about streams of cultural consciousness. Vic started a course in literature from central Europe based on this find, and my life was changed incredibly as a result. Thanks to Vic and my other professors at Whitworth, including Dr. Leonard Oakland, who at about the same time properly acquainted me with the power of James Joyce. My good friend Marek Hejny helped me get on my feet here in Prague and also pointed me towards features of Hrabal’s Prague and engaged me in further discussions of Czech literature. -

Chapter Ii Comparative Literature
CHAPTER II COMPARATIVE LITERATURE: A PERSPECTIVE 2.1 Preliminaries Comparative literature is the theoretical as well as methodological approach to help the researcher to understand varieties of cultures, languages, literatures and other different aspects. The present chapter deals with the definition of 'Comparative Literature' by various scholars and critics. It is not only important for critics to understand the literary views but also to help to analyze the universal relation among the literatures. The chapter contains a journey of Comparative Literature in details. The chapter also postulates important roles of Comparative Literature in studying various aspects of a novel. Since the present study deals with class, caste and race issues in the selected novels, it is an attempt of the researcher to highlight the contribution of the writers to Jewish literature in America as well as emergence of Dalit literature in India. It considers a variety of perspectives adopted by scholars from significant fields. Another important aspect is the historical one which concerns the role of various scholars and critics who contributed to Comparative Literature. Many critics from the beginning of Comparative Literature before the nineteenth century until the present day are thoroughly examined. The present study focuses mainly on texts expressly conceived as contributions to the development of comparative literature. 26 2.2 What is Comparative Literature? The term 'Comparative Literature' is a very broad concept, which involves comparative study among different Hteratures and brings out the similar and dissimilar qualities of the writers. It contains dimensions of comparative literature; first is the linguistic, thematic, and social dimensions. The second is cultures, morals and ethics of the characters in the novels. -

Transatlantica, 1 | 2014 the Exile Experience Reconsidered: a Comparative Perspective in European Cult
Transatlantica Revue d’études américaines. American Studies Journal 1 | 2014 Exile and Expatriation The Exile Experience Reconsidered: a Comparative Perspective in European Cultural Migration during the Interwar Period Renato Camurri Electronic version URL: http://journals.openedition.org/transatlantica/6920 DOI: 10.4000/transatlantica.6920 ISSN: 1765-2766 Publisher AFEA Electronic reference Renato Camurri, “The Exile Experience Reconsidered: a Comparative Perspective in European Cultural Migration during the Interwar Period”, Transatlantica [Online], 1 | 2014, Online since 02 October 2014, connection on 29 April 2021. URL: http://journals.openedition.org/transatlantica/6920 ; DOI: https:// doi.org/10.4000/transatlantica.6920 This text was automatically generated on 29 April 2021. Transatlantica – Revue d'études américaines est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. The Exile Experience Reconsidered: a Comparative Perspective in European Cult... 1 The Exile Experience Reconsidered: a Comparative Perspective in European Cultural Migration during the Interwar Period Renato Camurri AUTHOR'S NOTE This article is based on the paper “The Question of Exile,” presented at the conference “Perspectives on Exile, Homeland and The New World. The Italian Case,” organized by the Primo Levi Center of New York, April 29th 2010 as part of the Americordo project. The Century of Exiles 1 Exile is a phenomenon which has concerned all civilizations, ancient and modern. Starting from the Roman civilization, in which exsilium coincided with the voluntary departure from the city (Bettini, 2009, 1-2), one can also mention the experience of the political exile typical of the Renaissance (Shaw, 2000; Ricciardelli, 2007), or the exile of French aristocrats during the Revolution (Degl’Innocenti, 1992, 7-8). -

Gaetano Salvemini: a Lesson in Thought and Action Michael Christopher Diclemente University of Massachusetts Boston
University of Massachusetts Boston ScholarWorks at UMass Boston Graduate Masters Theses Doctoral Dissertations and Masters Theses 6-1-2012 Gaetano Salvemini: A Lesson in Thought and Action Michael Christopher DiClemente University of Massachusetts Boston Follow this and additional works at: http://scholarworks.umb.edu/masters_theses Part of the Political History Commons, and the Political Science Commons Recommended Citation DiClemente, Michael Christopher, "Gaetano Salvemini: A Lesson in Thought and Action" (2012). Graduate Masters Theses. Paper 90. This Open Access Thesis is brought to you for free and open access by the Doctoral Dissertations and Masters Theses at ScholarWorks at UMass Boston. It has been accepted for inclusion in Graduate Masters Theses by an authorized administrator of ScholarWorks at UMass Boston. For more information, please contact [email protected]. GAETANO SALVEMINI: A LESSON IN THOUGHT AND ACTION A Thesis Presented by MICHAEL C. DICLEMENTE Submitted to the Office of Graduate Studies, University of Massachusetts Boston, in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS June 2012 History Program © 2012 by Michael C. DiClemente All rights reserved GAETANO SALVEMINI: A LESSON IN THOUGHT AND ACTION A Thesis Presented by MICHAEL C. DICLEMENTE Approved as to style and content by: _____________________________________________ Spencer DiScala, Professor Chairperson of Committee _____________________________________________ Vincent J. Cannato, Associate Professor Member _____________________________________________ -

The Modern Satiric Grotesque and Its Traditions
University of Kentucky UKnowledge Literature in General English Language and Literature 2014 The Modern Satiric Grotesque and Its Traditions John R. Clark University of South Florida Click here to let us know how access to this document benefits ou.y Thanks to the University of Kentucky Libraries and the University Press of Kentucky, this book is freely available to current faculty, students, and staff at the University of Kentucky. Find other University of Kentucky Books at uknowledge.uky.edu/upk. For more information, please contact UKnowledge at [email protected]. Recommended Citation Clark, John R., "The Modern Satiric Grotesque and Its Traditions" (2014). Literature in General. 2. https://uknowledge.uky.edu/upk_literature_in_general/2 The Modern Satiric Grotesque And Its Traditions This page intentionally left blank The Modern Satiric Grotesque And Its Traditions JOHN R. CLARK THE UNIVERSITY PRESS OF KENTUCKY Copyright © 1991 by The University Press of Kentucky Scholarly publisher for the Commonwealth, serving Bellarmine College, Berea College, Centre College of Kentucky, Eastern Kentucky University, The Filson Club, Georgetown College, Kentucky Historical Society, Kentucky State University, Morehead State University, Murray State University, Northern Kentucky University, Transylvania University, University of Kentucky, University of Louisville, and· Western Kentucky University. Editorial and Sales Offices: Lexington, Kentucky 40508-4008 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Clark, John R., 1930- The modern satiric grotesque and its traditions / John R. Clark. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN: 978-0-8131-5619-4 1. Grotesque in literature. 2~ Satire-History and criticism. I. Title. PN56.G7C57 1991 809.7-dc20 90-27474 This book is printed on acid-free paper meeting the requirements of the American National Standard for Permanence of Paper for Printed Library Materials.@ Contents Preface vii Introduction 1Index Part I.