Regolamento Di Polizia Rurale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

I Primi 3 Servizi Selezionati Come Prioritari Sono
PROVINCIA DI PESARO E URBINO SERVIZI PROVINCIALI PER IL TERRITORIO Indagine conoscitiva sulla domanda di servizi provinciali per il territorio (Funzioni di supporto tecnico – amministrativo agli Enti Locali) - Analisi dei primi risultati – A tutti i 59 comuni del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino è stato sottoposto un questionario on-line contenente l’elenco di tutti i servizi offerti, raggruppati in aree e gruppi tematici. I comuni hanno espresso la propria domanda selezionando i servizi di interesse, con la possibilità di segnalare, per ogni gruppo, un servizio di valenza prioritaria. Nel territorio sono presenti 10 Comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti e 7 di questi Comuni hanno espresso le loro necessità, il 70% di loro ha compilato il questionario. Per quanto riguarda i Comuni più grandi, al di sopra dei 10.000 abitanti, 3 su 5 hanno segnalato i servizi utili alla loro realtà comunale. 3 su 5 corrisponde al 60% dei Comuni medio-grandi. DATI COPERTURA INDAGINE hanno risposto 43 comuni su 59 pari al 73% I comuni rispondenti suddivisi per fascia demografica (numero residenti) 7% 16% 77% <=5000 >5000 e <=10000 >=10000 Fascia di Comuni Comuni totali % rispondenti popolazione rispondenti per fascia (n° residenti) <=5000 33 44 75% >5000 e <=10000 7 10 70% >=10000 3 5 60% Totale 43 69 73% Fonte: Sistema Informativo e Statistico Elaborazione: Ufficio 5.0.1 - Gestione banche dati, statistica, sistemi informativi territoriali e supporto amministrativo 1 PROVINCIA DI PESARO E URBINO SERVIZI PROVINCIALI PER IL TERRITORIO QUADRO GENERALE 8 aree funzionali 20 gruppi di servizi Per un totale di 119 singoli servizi offerti Domanda di servizi espressa dai comuni del territorio In ordine decrescente su 119 servizi presenti nell'elenco dei servizi presentati in sede di assemblea dei Sindaci, il massimo numero di servizi richiesti per Comune è 91 con una media di 31 servizi complessivi per ogni Comune che possono essere confermati o implementati come nuovi. -

Corpo Elettorale Passivo Consiglio Allegato C
ALLEGATO C CORPO ELETTORALE PASSIVO PER ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE Fascia A) Comuni con popolazione fino a 3.000 (azzurra) Fascia B) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti (arancione) Fascia C) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti (grigia) Fascia D) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti (rossa) Fascia E) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti (verde) N. COMUNE COGNOME NOME CARICA FASCIA 1 A APECCHIO NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO SINDACO 2 A APECCHIO BAGIACCHI GABRIO CONSIGLIERE 3 A APECCHIO BRICCA EUCHERIO CONSIGLIERE 4 A APECCHIO CARDELLINI MASSIMO CONSIGLIERE 5 A APECCHIO GRANCI NICOLETTA CONSIGLIERE 6 A APECCHIO MARTINELLI GIACOMO CONSIGLIERE 7 A APECCHIO MORGANTI LORENZA CONSIGLIERE 8 A APECCHIO PERFETTI ANDREA CONSIGLIERE 9A APECCHIO PERFETTI FABIO CONSIGLIERE 10 A APECCHIO PISCIOLINI GIORGIO CONSIGLIERE 11 A APECCHIO ROSSI GIACOMO CONSIGLIERE 12 A AUDITORE ZITO GIUSEPPE SINDACO 13 A AUDITORE CANCELLIERI GIANCARLO CONSIGLIERE 14 A AUDITORE DE MARCHI SILVIA CONSIGLIERE 15 A AUDITORE GUERRA ORIANO CONSIGLIERE 16 A AUDITORE MERCANTINI MICHELA CONSIGLIERE 17 A AUDITORE PALAZZI MARTINA CONSIGLIERE 18 A AUDITORE VENERUCCI LUCIO CONSIGLIERE 19 A BARCHI MARCUCCI SAURO SINDACO 20 A BARCHI BARALDI ENRICO CONSIGLIERE 21 A BARCHI BARATTINI PATRIZIA CONSIGLIERE 22 A BARCHI BRANCHINI TIZIANA CONSIGLIERE 23 A BARCHI FISCALETTI PIERGIORGIO CONSIGLIERE 24 A BARCHI GASPERINI OSCAR CONSIGLIERE 25 A BARCHI MONTANARI ENRICA CONSIGLIERE 26 -

Qualità Delle Acque Della Provincia Di Pesaro E Urbino
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE Qualità delle acque della Provincia di Pesaro e Urbino Dott. Ferdinando De Rosa, Direttore Tecnico Scientifico ARPAM e dott. Piero Salvadori, Responsabile U.O. Acque potabili e minerali Dip. ARPAM di Pesaro AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE Compiti istituzionali dell’ARPAM nel controllo delle acque potabili • Gli Enti Locali e le AUSL si avvalgono dell’ARPAM per l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale, di vigilanza e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza • L’ARPAM assicura agli EELL e ai dipartimenti di Prevenzione delle AUSL attività di consulenza e supporto tecnico scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni (Art 17 legge regionale 60/1997 - Istituzione ARPAM) 2 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE Compiti di ricerca, raccolta e diffusione dei dati ambientali È in corso di pubblicazione il Libro bianco sulle acque potabili 3 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE Contenuti Libro Bianco sulle acque potabili Schede per Comune -fonti di approvvigionamento (pozzi, sorgenti, prese d’acqua superficiali) -reti idriche -classificazione delle acque ai sensi della 152/99 -trattamenti di potabilizzazione e disinfezione -numero di controlli e non conformità -caratteristiche dell’acqua all’utenza un punto di controllo per acquedotto >250 abitanti, con valori massimi, medi e minimi registrati nell’anno solare per 5 parametri: durezza, conducibilità, nitrati, solfati e cloruri Sintesi a scala provinciale 4 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE Situazione delle reti acquedottistiche 5 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE Acquedotto di Pesaro Alimentato per l’80% da acqua superficiale e per il 20% da acque sotterranee. -

Map of Truffle and Craft Beer
NATIONAL WHITE CRAFT BEER DOP ORGANISATIONS TRUFFLE FAIRS BOOSTS TOURISM IN THE PROVINCE OF PESARO AND URBINO OCTOBER/NOVEMBER apecchio CARPEGNA ACQUALAGNA amarcord consorzio di tutela NATIONAL WHITE località Pian di Molino del prosciutto dop TRUFFLE FAIR www.birraamarcord.it via Petricci, 2 www.acqualagna.com tel. +39 0722 989860 www.carpegna.com tel. +39 0722 77521 OCTOBER apecchio pergola tenute collesi CARTOCETO NATIONAL FAIR località Pian della Serra consorzio di tutela OF WHITE TRUFFLES www.collesi.com e valorizzazione AND OF TYPICAL PRODUCTS tel. +39 075 933118 dell’olio extravergine di OF PERGOLA oliva cartoceto www.comune.pergola.pu.it apecchio piazza Garibaldi, 1 microbirrificio venere tel. +39 0721 898437 OCTOBER/NOVEMBER strada comunale per pesaro sant’ANGELO in VADO Scalocchio (presso azienda NATIONAL FAIR OF agrituristica Cà Cirigiolo) urbino consorzio di tutela WHITE TRUFFLES FROM www.birravenere.com casciotta d’urbino THE MARCHE REGION tel +39 348 0058169 www.mostratartufo.it via Manzoni, 25, Urbania CANTIANO www.casciottadiurbino.it birrificio del CATRIA tel. +39 0721.87981 via Fossato, 5 www.birradelcatria.com tel. +39 348 3968565 TRUFFLES fermignano ALL YEAR ROUND il mulino vecchio monte grimano località Verziere, Cà l’Agostina terme www.verziere.it tel. +39 0722 330059 februarY monte porzio ACQUALAGNA birrificio angeloni REGIONAL BLACK via Pozziloco, 20 TRUFFLE FAIR www.birrangeloni.it www.acqualagna.com tel. +39 0721 955206 march pergola FOSSOMBRONE birrificio pergolese BIANCHETTO TRUFFLE via del Lavoro FAIR & MARKET www.birrificiopergolese.it www.comune.fossombrone.ps.it tel. +39 349 4272622 JulY SASSOCORVARO monte grimano terme la COTTA sassocorvaro VALLE DEL CONCA località Cà Corsuccio, BLACK TRUFFLE FESTIVAL via Vecellio, Mercatale www.prolocomontegrimano.it www.lacotta.it tel. -
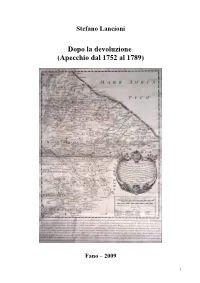
Apecchio Dopo La Devoluzione
Stefano Lancioni Dopo la devoluzione (Apecchio dal 1752 al 1789) Fano – 2009 1 2 A Maria Chiara e a Matteo 3 4 INTRODUZIONE Nel presente lavoro ho provato a ricostruire la storia di Apecchio nei primi decenni dopo la Devoluzione (periodo trattato in modo sintetico da Angelo Ascani1 e, con maggiori particolari, da monsignor Camillo Berliocchi)2. Si potranno leggere molte informazioni inedite, alcune delle quali spero interessanti. Quasi assenti, invece, le notizie riguardanti il terribile terremoto del 3 giugno 1781, a cui ho dedicato un apposito articolo (che sarà prossimamente pubblicato nella rivista dell’Istituto in cui insegno). Concludo con un doveroso ringraziamento al personale dell’Archivio di Stato e a quanti in Apecchio (in particolare il signor Bei) mi incoraggiano a continuare in queste mie ricerche, a cui solo per passione mi dedico. Stefano Lancioni P.S. Per rendere maggiormente comprensibili i documenti dell’epoca, ho sciolto tutte le abbreviazioni e normalizzato, secondo gli usi moderni, punteggiatura, maiuscole, accenti. Sono anche intervenuto, dove lo richiedono le attuali regole ortografiche, su: doppie (aggiunte o tolte secondo quanto stabilisce l’odierna pronuncia); uso di scie/sce; uso dell’ “h”; congiuntivo presente (es: succedino > succedano; vadino > vadano). 1A. ASCANI, Apecchio contea degli Ubaldini, Città di Castello 1977, p. 181 (“…la mancanza assoluta di documenti del tempo ci costringe a dare notizie d’indole generale, salvo sporadici fatti che non mancheremo d’illustrare”). 2C. BERLIOCCHI, Apecchio tra conti, duchi e prelati, s.l., 1992. 5 6 Capitolo I Lo Podesteria di Apecchio Con l’occupazione di Apecchio effettuata, da truppe della Legazione di Urbino, alla morte dell’ultimo conte, Federico Ubaldini (1752), si creò una nuova unità amministrativa, la “podesteria di Apecchio”, che si affiancò alle altre ripartizioni territoriali della Legazione e che ebbe la propria figura di riferimento nel “podestà”, inviato da Pesaro in sostituzione del commissario nominato dai conti. -

Le Marche Piobbico
Le Marche Piobbico Ref. 965: mooi appartement met torenkamer in klein project met zwembad Vraagprijs: € 125.000 www.italiacasa.net 1 Ref. 965 Piobbico Beschrijving NU EXTRA AANTREKKELIJKE PRIJS ! Ook ideaal voor actieve buitenporters en wandelaars Op prachtige locatie aan de rand van het dorpje Piobbico in de regio Le Marche ligt het rustieke, ruime appartement Casa Granaio met een prachtig uitzicht op de Monte Nerone. Het appartement is onderdeel van het mooie kleinschalige complex Il Podere, bestaande uit 34 appartementen verspreid over 5 Casali. Il Podere is voorzien van een gemeenschappelijk zwembad en parkeergarage, omringd door groenzones en voldoende parkeerplaatsen. Het appartement beschikt over een ruime woonkamer, een keuken, twee grote slaapkamers en tevens een torenkamer. De woning wordt verkocht inclusief de vrijwel nieuwe inventaris! Het historische dorpje Piobbico, met zijn circa 2.000 inwoners, is een gemeente in de Italiaanse provincie Pesaro-Urbino in de regio De Marken en ligt op 339 m boven zeeniveau. Piobbico grenst aan de gemeenten Apecchio, Cagli en Urbania. Het centrum van Piobbico ligt op 700 meter afstand van het appartement. Piobbico heeft twee supermarkten, diverse restaurants, terrasjes, banken met pinautomaten en medische voorzieningen. In de nabije omgeving liggen natuurparken en vele sportfaciliteiten zoals uitgestippeldewandelroutes, paardrijden, kanoën, mountainbiken, bergbeklimmen, deltavliegen en vissen. De Monte Nerone (1526 m) beschikt zelfs over een klein skigebied met een paar sleepliften. Bij helder weer kun je vanaf de Monte Nerone de zee zien. De fraaie stranden zijn binnen 45 minuten bereikbaar via de Superstrada Via Flaminia. De universiteitsstad Urbino met zijn prachtige straten, pleinen, winkels en terrassen ligt op ongeveer 35 km afstand. -

Mappa Dei Birrifici – Come Arrivare
Comune di Apecchio Assessorato al turismo Birrici ad Apecchio < Ur bania Breweries to Apecchio Valguerriera Ca’ Pieri UMBRIA > Acqualagna 1. Birricio Amarcod Baronea di > Fano | Pesaro Monte Ruperto www.birraamarcord.it > Ancona | Bologna San Martino del Piano Ca’ Pierpaoli Z.A. La Casella Loc. Pian di Molino SP 257 Piobbico 61042 - Apecchio PU Ca’ Quattrocchi Piandimolino Tel. (+39) 0722989860 SP 90 Pian di Molino 2. Birricio Collesi Rossara Colombara www.collesi.com Valpezzola La Rocca Valdarecchia Loc. Pian della Serra, SP 28 Monte Nerone 61042 - Apecchio PU La Spina Ca’ Cirigiolo Le Ciocche Osteria Nuova Apecchio Tel. (+39) 075933118 SP 101 SP 15 Mobile (+39) 3358352138 Taverna Serravalle di Carda Caselle 3. Microbirricio Venere La Chiusura Fontesomma Lucaraia San Paolo Casellina www.birravenere.com Val del Lago Chignoni Valcerosa Loc. Ca’ Cirigiolo, Colalpi SP 153 Chiciabocca Valdara 61042 - Apecchio PU > Pietralunga > Cagli Col di Fiore Mobile (+39) 3480058169 SP 257 < Città di Castello | Arezzo | Perugia COME ARRIVARE AI BIRRIFICI HOW TO REACH THE CRAFT BEER BREWERIES 1. Birricio Amarcod - www.birraamarcord.it 1. Birricio Amarcod - www.birraamarcord.it Z.A. La Casella Loc. Pian di Molino, 61042 - 0722.989860 Z.A. La Casella Loc. Pian di Molino, 61042 - (+39) 0722989860 Da Apecchio o arrivando da Città di Castello oltrepassare il paese e proseguire per altri 5 km From Apecchio or arriving from Città di Castello , drive right through Apecchio and continue for 5kms in direzione Acqualagna. towards Acqualagna. At the junction for Monte Nerone turn right and here you will nd the brewery. Al bivio per Monte Nerone girare a dx e subito dopo 100 mt a sx. -

APE1 Pubblicazione Con Avviso 11 08 11
REGIONE MARCHE P.F. RETE ELETTRICA REGIONALE, AUTORIZZAZIONI ENERGETICHE GAS ED IDROCARBURI OGGETTO: D.P.R. n. 327/2001 e succ. mod. ed integr. - Avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento dei terreni nei Comuni di Apecchio Mercatello sul Metauro (PU) Città di Castello (PG) interessati dalla realizzazione dell’impianto Eolico della Società Marche Energie Rinnovabili srl. AVVISO La Regione Marche – Servizio Territorio Ambiente Energia - P.F. Rete elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche Gas ed Idrocarburi, rende noto che la Società Marche Energie Rinnovabili srl di con sede in Lucera (FG) SS17 Km 327 Loc. Perazzo, Telefono 0881 531611 Fax 0881 531627 e- mail [email protected] con istanza presentata in data 19/10/2010, assunta al protocollo n. 660605, ha chiesto l’avvio della procedura per l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento sulle aree necessarie alla costruzione dell’impianto eolico ed opere connesse; successivamente in sede di conferenza dei servizi sono state acquisite agli atti le relative planimetrie. La presente pubblicazione ha pertanto valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. da 11 a 16 e degli articoli 52 bis. e 52 ter. del DPR 327/2001 come introdotti dal D.Lgs 330/2004, nonché ai sensi dell’art. 7 e seguenti della legge 241/90, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dal progetto, e sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale agli interessati poiché nella fattispecie è superiore a 50 il numero dei destinatari della procedura. -

Documenti Riguardanti Il Terremoto Del 3 Giugno 1781
Il terremoto del 3 giugno 1781. Documenti riguardanti Cagli ed Apecchio di Stefano Lancioni L’articolo è diviso in due parti: nella prima si ricordano danni e vittime provocati in varie zone della nostra provincia dal terremoto del 3 giugno 1781; nella seconda si presentano diversi documenti riguardanti Apecchio, uno dei centri più colpiti dalla scossa tellurica. Nel tardo pomeriggio del 3 giugno 1781 giunsero a Pesaro allarmanti notizie riguardanti una forte scossa di terremoto che, nella mattinata dello stesso giorno, aveva colpito la città di Cagli. La mattina successiva Sua Eminenza, monsignor Carlo Livizzani, presidente della Legazione di Urbino, inviò alla volta di quella città il dottor Giuseppi Celi con alcuni uomini non solo per riconoscere e rilevare i danni medesimi ma per prendere altresì tutti que’ provvedimenti che il Celi avesse giudicato necessari ed opportuni in sì luttuose circostanze a sollievo di quella disgraziata popolazione. Costui inoltre riceveva l’ordine di fermarsi a Fossombrone per aver soldati e tutto quell’ajuto che occorresse in tal contingenza1. I danni subiti dalla città di Cagli erano in effetti enormi. Buona parte degli edifici pubblici e privati era stata atterrata o danneggiata dalle scosse telluriche; decine erano le vittime ed i dispersi, buona parte dei quali ancora sotto le macerie della Cattedrale dove, al momento del terremoto (poco dopo le 11 del mattino) era radunata parte della popolazione per partecipare alla funzione religiosa del giorno di Pentecoste (ed era presente anche il vescovo cagliese, monsignor Ludovico Agostino Bertozzi di Fano)2. La prima lettera giunta a Sua Eminenza dal podestà di Cagli, il dottor Giuseppe Giusto Marforj, è del 5 giugno 1781: Eccomi, Eccellenza Reverendissima, a funestarla con un avviso che deve certamente muovere a compassione le viscere amorose della somma bontà dell’Eminenza Vostra. -

Capitolo 2.Cdr
database del Ministero dell'Ambiente e della Per quanto riguarda il PPAR della Regione Marche sono state considerate le seguenti Tutela del Territorio e del mare. tavole: TAV 2 – Emergenze geologiche; Cap. 2 TAV 6 - Aree per rilevanza di valori paesaggistici; 2.2 - Le mappe riassuntive. TAV 7 - Aree di alta percezione visiva; TAV 8 - Centri e nuclei storici e paesaggio agrario storico; Per offrire una migliore lettura degli strumenti di TAV 9 - Edifici e manufatti extraurbani; Analisi dei livelli pianificazione sono state riprodotte le tavole dei TAV 10 - Luoghi archeologici e di memoria storica; di tutela piani esaminati, appositamente modificate e TAV 15 – Centri e nuclei storici ed ambiti di tutela cartograficamente delimitati; ritagliate rispetto all'area di studio. TAV 16 – Manufatti storici extraurbani ed ambiti di tutela cartograficamente delimitati; Successivamente, individuate le peculiarità e le emergenze indicate dai quattro piani urbanistici, sono state elaborate, su base IGM scala 1:100.000, tre mappe riassuntive. Difatti, la Per quanto riguarda il PTC della Provincia di Pesaro-Urbino sono state considerate le 2. Analisi dei livelli di tutela. a seguenti tavole: l particolare collocazione delle installazioni di Tav. 1b – Aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale (L. 1497/39); e Monte Macinara in prossimità dei confini t Tav. 2d – Emergenze geologiche e geomorfologiche individuate dal PPAR; 2.1 - Gli strumenti di pianificazione vigenti. regionali, ha determinato la necessità di fornire u Tav. 3b – Demanio forestale e aree floristiche; t un quadro omogeneo dei livelli di tutela. Queste Tav. 3d – Oasi faunistiche e aree Bioitaly; i Lo studio territoriale relativo ai livelli di tutela è rappresentazioni forniscono un'immagine Tav. -

Il Terremoto Del 1781 Nell'appennino Pesarese
Castelli V., Camassi R. e Monachesi G. Il terremoto del 1781 nell’Appennino Aprile 2020 pesarese LA SEQUENZA Secondo il catalogo sismico nazionale è l’evento più energetico con localizzazione nel territorio marchigiano (MWmacro 6.5±0.1; Io=X MCS). Sicuramente è l’evento più rappresentativo del rischio sismico che caratterizza l’entroterra della provincia di Pesaro e Urbino. La sequenza sismica cominciò con una o due lievi scosse avvertite prima dell’alba del 3 giugno 1781 e continuò almeno fino ai primi giorni di aprile del 1782 danneggiando con effetti da moderati a distruttivi un’ampia area estesa da Pennabilli-Sestino a nord, a Fabriano a sud. Le segnalazioni dei due foreshock provengono da Cagli (piccola scossa), da Urbino e Pesaro (piccola ma generalmente avvertita). Relativamente agli eventi principali del 3 giugno le fonti concordano generalmente nella segnalazione dell’avvertimento il 3 giugno di due scosse violente in una finestra temporale compresa tra le 7 ¼ e le 7 ¾ ore locali (11-11:30 ore all’italiana). La prima scossa è descritta come più forte e più lunga, la seconda come di poco inferiore alla prima; oppure di uguale forza ma più breve. Solo a Urbino e ad Urbania si ricordano tre scosse iniziali ben descritte da uno dei due osservatóri urbaniesi. Nei giorni seguenti gli scuotimenti furono continui. Alcune repliche più energetiche, capaci di far nuovo danno, avvennero nei giorni 8, 10, 13, 15, 21, 29 giugno e 27 luglio 1781. L’evento del 13 giugno peggiorò i danni non ingenti che Cantiano aveva subito per le scosse del 3 giugno e aggravò ulteriormente quelli già molto gravi e diffusi subiti nella stessa occasione nelle vicine frazioni/ville di Chiaserna e Palcano. -

Pesaro and Urbino
Pesaro e Urbino la provincia bella the beautiful province die schöne Provinz ACQUALAGNA • APECCHIO • AUDITORE • BARCHI • BELFORTE ALL’ISAURO BORGO PACE • CAGLI • CANTIANO • CARPEGNA • CARTOCETO COLBORDOLO • FANO • FERMIGNANO • FOSSOMBRONE • FRATTEROSA • FRONTINO FRONTONE • GABICCE MARE • GRADARA • ISOLA DEL PIANO • LUNANO MACERATA FELTRIA • MERCATELLO SUL METAURO • MERCATINO CONCA • MOMBAROCCIO MONDAVIO • MONDOLFO • MONTECALVO IN FOGLIA MONTE CERIGNONE • MONTECICCARDO • MONTECOPIOLO • MONTEFELCINO MONTEGRIMANO TERME • MONTELABBATE • MONTEMAGGIORE AL METAURO MONTE PORZIO • ORCIANO DI PESARO • PEGLIO PERGOLA • PESARO • PETRIANO • PIAGGE • PIANDIMELETO • PIETRARUBBIA PIOBBICO • SALTARA • SAN COSTANZO • SAN GIORGIO DI PESARO SAN LORENZO IN CAMPO • SANT’ANGELO IN LIZZOLA SANT’ANGELO IN VADO • SANT’IPPOLITO • SASSOCORVARO • SASSOFELTRIO SERRA SANT’ABBONDIO • SERRUNGARINA • TAVOLETO TAVULLIA • URBANIA • URBINO Provincia di Pesaro e Urbino Assessorato al Turismo Gabicce Mare provincia di Rimini Provincia Gradara San Marino di rimini pesaro Tavullia Mercatino Conca Sasso Feltrio Monte Grimano Terme Monte Copiolo Tavoleto Montelabbate fano Monte Cerignone Auditore Colbordolo S.Angelo (in Lizzola) Monteciccardo Macerata Montecalvo Feltria in Foglia Mombaroccio Pietrarubbia Marotta Marotta Petriano Sassocorvaro S. Costanzo Carpegnaarpegna Frontino Cartoceto Saltara Montemaggiore MondolfMondolfo Serrungarina ancoancona PiandimeletoPi di l t Isola del Piano Montefelcino Piagge Lunano urbinoino S.Giorgio di Pesaro Provincia Monte Porzio di Arezzo Belforte