Associazione Arte E Scienza
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Cubesat Mission to Study Solar Particles (Cusp) Walt Downing IEEE Life Senior Member Aerospace and Electronic Systems Society President (2020-2021)
The CubeSat Mission to Study Solar Particles (CuSP) Walt Downing IEEE Life Senior Member Aerospace and Electronic Systems Society President (2020-2021) Acknowledgements – National Aeronautics and Space Administration (NASA) and CuSP Principal Investigator, Dr. Mihir Desai, Southwest Research Institute (SwRI) Feature Articles in SYSTEMS Magazine Three-part special series on Artemis I CubeSats - April 2019 (CuSP, IceCube, ArgoMoon, EQUULEUS/OMOTENASHI, & DSN) ▸ - September 2019 (CisLunar Explorers, OMOTENASHI & Iris Transponder) - March 2020 (BioSentinnel, Near-Earth Asteroid Scout, EQUULEUS, Lunar Flashlight, Lunar Polar Hydrogen Mapper, & Δ-Differential One-Way Range) Available in the AESS Resource Center https://resourcecenter.aess.ieee.org/ ▸Free for AESS members ▸ What are CubeSats? A class of small research spacecraft Built to standard dimensions (Units or “U”) ▸ - 1U = 10 cm x 10 cm x 11 cm (Roughly “cube-shaped”) ▸ - Modular: 1U, 2U, 3U, 6U or 12U in size - Weigh less than 1.33 kg per U NASA's CubeSats are dispensed from a deployer such as a Poly-Picosatellite Orbital Deployer (P-POD) ▸NASA’s CubeSat Launch initiative (CSLI) provides opportunities for small satellite payloads to fly on rockets ▸planned for upcoming launches. These CubeSats are flown as secondary payloads on previously planned missions. https://www.nasa.gov/directorates/heo/home/CubeSats_initiative What is CuSP? NASA Science Mission Directorate sponsored Heliospheric Science Mission selected in June 2015 to be launched on Artemis I. ▸ https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/heliophys ics-cubesat-to-launch-on-nasa-s-sls Support space weather research by determining proton radiation levels during solar energetic particle events and identifying suprathermal properties that could help ▸ predict geomagnetic storms. -

Revista Feminista Cubana
revista feminista cubana alastensas alas tensas | no. 4 | pág. 1 Alas Tensas revista feminista cubana No. 4 junio 2017 Directora: Ileana Álvarez VOZ-OTRAS DIÁLOGOS contenido Editor: Francis Sánchez ¿Cuándo vas a parir? • Irela Casañas /3 La palabra en el corazón de Maricruz Patiño • Diseñador: Yaudel Estenoz Representación social y espacio privado desde los imagi- Francis Sánchez / 63 narios femeninos en tres documentales de la TV Serrana • Consejo de redacción: Juventina Soler, Juventina Soler Palomino /6 AFILADEROS /73 Agnes Koleman, Silvia Padrón, Martha Núñez, Mercedes del Llano. El Día de la Mujer ¿festivo? | Machismo a la VIDAS cubana | Astronauta afroamericana | Lo que Imagen de cubierta: Ángeles Santos Magín, sencillamente • Ileana Álvarez /15 oculta una valla | Lente feminista | Opiniones Magín: “Nunca dejes de sentirte estrella” • Dossier /25 recibidas Dirección: Calle Martí, 352, e/ Estrada y Chicho ESCRITURAS Torres, Ciego de Ávila, Cuba, AUTORES /85 La poesía cubana actual escrita por mujer: rebeldía a través CP. 65200 del etnos y la orientación sexual (Primera parte) • Silvia Pa- [email protected] drón Jomet /43 www.alastensas.wordpress.com Sobre “País de pólvora” • Maya Islas /49 Facebook: @AlasTensasCuba País de pólvora • Maya Islas /51 Twitter: @AlasTensas Eva • Georgina Herrera /56 MATRIAS “Las mujeres de la clase ínfima” • José Abreu Cardet /58 ¿Cuándo vas voz-otras a parir? Por: Irela Casañas A veces la curiosidad de los otros sobre la vida ajena no tiene límites. Con razón existe el oficio de paparazzi y las revistas del corazón tienen tantos consumidores. Pero yo no soy famosa, soy una mujer que trata de llegar al día siguiente sin que tal cosa afecte las ganas de crear. -

Launch Availability Analysis for the Artemis Program
Launch Availability Analysis for the Artemis Program Grant Cates and Doug Coley Kandyce Goodliff and William Cirillo The Aerospace Corporation NASA Langley Research Center 4851 Stonecroft Boulevard 1 North Dryden Blvd., MS462 Chantilly, VA 20151 Hampton, VA 23681 571-304-3915 / 571-304-3057 757-864-1938 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Chel Stromgren Binera, Inc. 77 S. Washington St., Suite 206 Rockville, MD 20910 301-686-8571 [email protected] Abstract—On March 26, 2019, Vice President Pence stated that will be on achieving all of the launches in a timely fashion. the policy of the Trump administration and the United States of NASA and the commercial partners need quantitative America is to return American astronauts to the Moon within estimates for launch delay risks as they develop the lunar the next five years i.e., by 2024. Since that time, NASA has begun lander design and refine the concept of operations. Of the process of developing concepts of operations and launch particular importance will be understanding how long each campaign options to achieve that goal as well as to provide a sustainable human presence on the Moon. Whereas the Apollo lunar lander element will be in space and how long the program utilized one Saturn V rocket to carry out a single lunar integrated lander will have to wait in lunar orbit prior to the landing mission of short duration, NASA’s preliminary plans arrival of Orion and the crew. for the Artemis Program call for a combination of medium lift class rockets along with the heavy lift Space Launch System 2. -

Space Girls Katrien Van Der Heyden
Dia 1 Space girls Katrien Van der Heyden Dia 2 • Geslacht: biologische verschillen tussen mannen en vrouwen Het belangrijkste is te beseffen dat geslacht en gender GEEN synoniemen zijn, want vaak worden ze wel zo gebruikt in de media en in onderzoek. Terwijl geslacht verwijst naar de biologische verschillen zoals borsten, geslachtsdelen, verwijst gender naar de verschillen die cultureel werden opgebouwd. Zo dragen mannen in onze cultuur nooit een rok, maar in Schotland vormt dit geen probleem. Dat wil zeggen dat er naast de biologische verschillen ook een maatschappelijke invulling is van wat mannelijkheid en vrouwelijkheid op een bepaald moment in een bepaalde cultuur betekent. Dit kan gaan over uiterlijke kenmerken zoals rok en broek, maar ook over karaktereigenschappen zoals competitiviteit, assertiviteit, leiderschap (worden als mannelijk gezien) en emotionaliteit, zorgzaamheid, zachtaardigheid (worden als vrouwelijk gezien). Zowel mannen als vrouwen worden (in)direct in de richting geduwd die overeenstemt met het stereotype beeld van hun geslacht. Zo wordt een man die zich emotioneel gedraagt een ‘watje’ genoemd en afgekeurd en een vrouw die assertief is, wordt al snel een ‘bitch’ genoemd. Toch zijn al deze eigenschappen niet mannelijk of vrouwelijk, ze zijn menselijk. (En voor diegenen die nog twijfelen of mannen emotioneel kunnen zijn: Ga eens naar een voetbalmatch kijken). Dat wil dus zeggen dat bij jongens bepaalde eigenschappen worden gestimuleerd en bij meisjes andere. Indien ze zich dan zo gaan gedragen, vergeten we dat dit aangeleerd gedrag is en gaan we snel denken dat het een biologische oorsprong heeft. Dia 3 • Gender: culturele geconstrueerde verschillen tussen mannen en vrouwen Dia 4 Mannen hebben Does size matter? gemiddeld een groter hoofd dan vrouwen: dus, ze zijn intelligenter? Wetenschappelijk onderzoek in de 19e eeuw toonde aan dat mannen gemiddeld een groter hoofd hebben dan vrouwen. -

Annali Di Storia Delle Università Italiane 07Pepe.Qxp:Layout 1 18-10-2011 8:50 Pagina 67
01Pagine.qxp:Layout 1 18-10-2011 8:32 Pagina 3 Annali di storia delle università italiane 07Pepe.qxp:Layout 1 18-10-2011 8:50 Pagina 67 Luigi Pepe MATEMATICA E MATEMATICI NELLA SCUOLA NORMALE DI PISA 1862-1918 l decreto 17 agosto 1862 del ministro Carlo Matteucci istituiva a Pisa la Scuola Normale dell’Italia unita approvandone il regolamento. La IScuola aveva come oggetto “proporre ed abilitare all’ufficio di pro - fessore e maestro nelle scuole secondarie” ed era divisa in due sezioni: Lettere e filosofia, Scienze fisiche e matematiche. Matteucci, in conside - razione della scarsa attrattività economica del mestiere di professore e della bassa estrazione sociale degli aspiranti a questa professione, si bat - tè con successo perché la Scuola prevedesse un convitto, ma volle che l’accesso avvenisse per sole considerazioni di merito: così nel 1879 en - trarono in Normale Carlo Somigliana di famiglia agiata, discendente per parte materna da Alessandro Volta, e Vito Volterra, che per concorrere in Normale, si era dovuto adattare ad un piccolo impiego presso l’Istitu - to tecnico di Firenze 1. Primo direttore della Scuola Normale della nuova Italia fu lo storico Pasquale Villari (1862-1865), allievo di Francesco De Sanctis ed esule a Torino dopo il 1848. In seguito al suo trasferimento a Firenze per oltre mezzo secolo la Scuola ebbe come direttore un matematico: Enrico Bet - 1 TINA TOMASI -N ELLA SISTOLI PAOLI , La Scuola ti diresse la Scuola dal 1865 al 1892 (nel biennio 1874-1876 fu supplito da Normale di Pisa dal 1813 al 1945. Cronache di un’istituzione , Pisa, Scuola Normale Supe - Ulisse Dini). -

Human Spaceflight in Social Media: Promoting Space Exploration Through Twitter
Human Spaceflight in Social Media: Promoting Space Exploration Through Twitter Pierre J. Bertrand,1 Savannah L. Niles,2 and Dava J. Newman1,3 turn back now would be to deny our history, our capabilities,’’ said James Michener.1 The aerospace industry has successfully 1 Man-Vehicle Laboratory, Department of Aeronautics and Astro- commercialized Earth applications for space technologies, but nautics; 2Media Lab, Department of Media Arts and Sciences; and 3 human space exploration seems to lack support from both fi- Department of Engineering Systems, Massachusetts Institute of nancial and human public interest perspectives. Space agencies Technology, Cambridge, Massachusetts. no longer enjoy the political support and public enthusiasm that historically drove the human spaceflight programs. If one uses ABSTRACT constant year dollars, the $16B National Aeronautics and While space-based technologies for Earth applications are flourish- Space Administration (NASA) budget dedicated for human ing, space exploration activities suffer from a lack of public aware- spaceflight in the Apollo era has fallen to $7.9B in 2014, of ness as well as decreasing budgets. However, space exploration which 41% is dedicated to operations covering the Internati- benefits are numerous and include significant science, technological onal Space Station (ISS), the Space Launch System (SLS) and development, socioeconomic benefits, education, and leadership Orion, and commercial crew programs.2 The European Space contributions. Recent robotic exploration missions have -
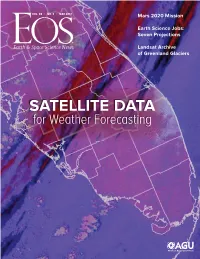
SATELLITE DATA for Weather Forecasting
VOL. 98 NO. 3 MAR 2017 Mars 2020 Mission Earth Science Jobs: Seven Projections Earth & Space Science News Landsat Archive of Greenland Glaciers SATELLITE DATA for Weather Forecasting Earth & Space Science News Contents MARCH 2017 VOLUME 98, ISSUE 3 PROJECT UPDATE 20 Using LANDSAT to Take the Long View on Greenland Glaciers A new web-based data portal gives scientists access to more than 40 years of satellite imagery, providing seasonal to long-term insights into outflows from Greenland’s ice sheet. PROJECT UPDATE 32 Seeking Signs of Life and More: NASA’s Mars 2020 Mission The next Mars rover will be able to land near rugged terrain, giving scientists access to diverse landscapes. It will also cache core samples, a first step in the quest 26 to return samples to Earth. COVER OPINION Transforming Satellite Data Seven Projections 14 for Earth and Space into Weather Forecasts Science Jobs What do recent political changes mean A NASA project spans the gap between research and operations, for the job market? In the short term, not introducing new composites of satellite imagery to weather much. But long term, expect privatization, forecasters. contract employment, and more. Earth & Space Science News Eos.org // 1 Contents DEPARTMENTS Editor in Chief Barbara T. Richman: AGU, Washington, D. C., USA; eos_ [email protected] Editors Christina M. S. Cohen Wendy S. Gordon Carol A. Stein California Institute Ecologia Consulting, Department of Earth and of Technology, Pasadena, Austin, Texas, USA; Environmental Sciences, Calif., USA; wendy@ecologiaconsulting University of Illinois at cohen@srl .caltech.edu .com Chicago, Chicago, Ill., José D. -

Analysis and Testing of an X-Band Deep-Space Radio System for Nanosatellites
POLITECNICO DI TORINO Faculty of Engineering Master Degree in Communications and Computer Networks Engineering Master Thesis Analysis and Testing of an X-Band Deep-Space Radio System for Nanosatellites Mentor Candidate Prof. Roberto Garello Pasquale Tricarico October 2019 To my family and to those who have been there for me Alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino Abstract This thesis provides a description of analysis, performance and tests of an X-Band radio system for nanosatellites. The thesis work has been carried out in collaboration with the Italian aerospace company Argotec in Turin supported by Politecnico di Torino. The scope of the thesis is the ArgoMoon mission which will start on June 2020. ArgoMoon is a nanosatellite developed by Argotec in coordination with the Italian Space Agency (ASI). After an introduction to the mission, follows a description of the entire communication system including NASA Deep Space Network (DSN), spacecraft telecommunication subsystem and a set of involved Consultative Committee for Space Data System (CCSDS) Standards. The main guideline has been the Telecommunication Link Design Handbook written by NASA JPL, which gives essential information for the subsequent communication link analysis, supported by CCSDS Standards and further publications. A set of communication link performance analysis methods and results are provided for two relevant communication scenarios. Concurrently, compatibility tests have been carried out to assess ArgoMoon satellite to DSN interface performance and compatibility. The documents ends with the description of a system which will acts as Ground Support Equipment during the satellite validation tests. Acknowledgements I would like to thank prof. -

NASA Bumps Astronaut Off Space Station Flight in Rare Move 19 January 2018, by Marcia Dunn
NASA bumps astronaut off space station flight in rare move 19 January 2018, by Marcia Dunn Epps is returning to Houston from Russia, where she'd been training to fly to the space station with a German and Russian. NASA spokeswoman Brandi Dean said Friday it was a decision by NASA, not the Russian Space Agency. African-American astronauts have visited the space station, but Epps would have been the first to live there. Space station crews typically stay for five to six months. NASA assigned her to the flight a year ago. In this Sept. 16, 2014 photo provided by NASA, astronaut Jeanette Epps participates in a spacewalk training session at the Johnson Space Center in Houston. In June 2018, Epps was supposed to be the first African-American to live on the International Space Station, but on Thursday, Jan. 18, 2018, NASA announced it was pulling her off the mission for undisclosed reasons. (Robert Markowitz/NASA via AP) NASA has bumped an astronaut off an upcoming spaceflight, a rare move for the space agency so close to launch. Astronaut Jeanette Epps was supposed to rocket away in early June, and would have been the first African-American to live on the International Space Station. Late Thursday, NASA announced it was pulling Epps off the mission but didn't disclose why. Astronauts have been removed from missions in the past, mostly for health reasons. Epps, an engineer, will be considered for future space missions, according to NASA. She's been replaced by her backup, Serena Aunon- Chancellor, a doctor. -

Argomoon Flies to Nasa
ARGOMOON FLIES TO NASA Turin/Rome, 26th of May 2021, ArgoMoon is ready to take off to the Moon. The microsatellite designed and developed by Argotec, financed and managed by the Italian Space Agency (ASI), is about to be shipped to the United States to NASA's integration site in preparation for launch activities scheduled for the end of the year. ArgoMoon will be part of the precious cargo of Artemis 1, the first mission of the new American rocket - Space Launch System (SLS) - for NASA's extensive Artemis programme that will mark the return of man, and first-ever woman, to the Moon. On the inaugural flight of NASA’s SLS rocket, thirteen microsatellites will be on board, as well as the Orion capsule, which will be the heir to the Apollo astronaut modules. Ten of these microsatellites will be American, two Japanese and ArgoMoon, the only European satellite. The Italian microsatellite will be released while the rocket is approaching the Moon and will take important photos of the Space Launch System to support NASA in ensuring the success of their mission. More of ArgoMoon’s and Italy's objectives are to develop and demonstrate new technologies useful for nanosatellites, an orbital and space flight control system, and the resistance of components and units to the radiation typical of the space environment. This Made in Italy mission will be performed by a technological masterpiece measuring just 30x20x10 cm. This small device has the same features as a larger satellite with technologically advanced miniaturised subsystems able to withstand the harsh conditions of deep space. -

JAXA's Lunar Exploration Activities
June 17th 2019, 62nd Session of COPUOS, Vienna JAXA’s Lunar Exploration Activities Hiroshi Sasaki Director, JAXA Space Exploration Center (JSEC) Japan Aerospace Exploration Agency 1 JAXA’s Space Exploration Scenario Mars, others Activities on/beyond Mars ©JAXA MMX JFY2024 Kaguya ©JAXA ©JAXA ©JAXA ©JAXA Moon SLIM Lunar Polar Exploration Robotic Sample Return Pinpoint Landing Water Prospecting Sustainable JFY2021 (HERACLES) prox.2023- Technology Demo Exploration/Utilization Approx.2026- HTV-X derivatives Gateway Approx. 2026- Operation OMOTENASHI EQUULEUS CubeSat Innovative launched by small mission Gateway (construction phase) SLS/EM1 2022- Earth Promote Commercialization International Space Station 2 ©NASA International Space Exploration Coordination Group (ISECG): • ISECG is a non-political agency coordination forum of space organization from 18 countries and regions. • JAXA is currently the chair of ISECG. • ISECG agencies work collectively in a non-binding, consensus-driven manner towards advancing the Global Exploration Strategy. The Global Exploration Roadmap (GER3) recognizes the importance of increasing synergies with robotic missions while demonstrating the role humans play in realizing societal benefits. GER3, released in January 2018 3 Significance of Lunar Exploration Expand Human Activities Gain Knowledge International Cooperation ©NASA Promote Industry Inspire Young Generation 4 JAXA’s Lunar Exploration Roadmap (Long-Team) Lunar Base (International Space Agency, Private Sector) 2060- Sustainable Exploration (Private Utilization) -

Trump and the Black Caucus Plan to Meet for the First Time
PRESORTED STANDARD .S. POSTAGE PAID WILMINGTON, N.C. PERMIT - NO. 675 50 CENTS Established 1987 - C elebrating 30 Years of E xcellence! VOLUME 30, NO. 5 March 2017 INSIDE 2 Opinions & Editorials 3 6 7 ‘Real Men Charities’ 3 Health & Wellness Combatting First Black Crew Ushers in New 4 Business News & Research Stereotypes: How Member to Join Leadership With New 5 Career & Education to Talk to Your International Executive Director and 6 Events & Announcements Expanded Board of 7 Spirit & Life Children Space Station Directors 8 Classifieds The Black Press Played Trump and the Black Caucus Vital Role in “Hidden Figures” Plan to Meet for the First Time By Lauren Victoria Burke (N NPA) Following a bizarre exchange with American Urban Radio Networks White House Correspondent April Ryan, the Congressional Black Caucus is in talks with President Donald Trump to “Hidden Figures” author Margot Lee Shetterly set up a meeting. Trump asked, Ryan, a (left) poses for a photo with New Journal and veteran Black journalist, if Guide publisher Brenda Andrews. she could set up a meeting Photo by Ernest Lowery/New Journal and Guide with him and the CBC, as if Ryan was an employee of By Stacy M. Brown headline blared. the White House or a special The CBC, which is now at its largest membership in history, traditionally requests a meeting with the new president after the inauguration. Photo of CBC mem- An accompanying pho- assistant to the CBC. Ryan (NNPA) In her book, to revealed 11 immaculate- responded by saying, “I’m a bers taken during a press conference outside of the Department of Justice in “Hidden Figures,” author ly dressed Black women in journalist.” Washington, D.C.