La Campagna D'italia Del 1859
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR N
AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR n. X/4469 del 10.12.2015) Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187 DECRETO N. 388/DGi DEL 06/08/2020 IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI OGGETTO: Conferimento di incarico a tempo indeterminato nell'ambito territoriale carente di Pediatria di libera scelta di Albonese, Nicorvo, Parona, Candia, Castello D'Agogna, Ceretto, Cergnago, Zeme, Cozzo, Langosco, Mortara, Olevano, Castelnovetto, Rosasco, Sant'Angelo Lomellina, Confienza, Palestro, Robbio Codifica n. 1.1.02 Acquisiti i pareri di competenza del: DIRETTORE SANITARIO Dr. Santino SILVA (Firmato digitalmente) DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Adriano VAINI (Firmato digitalmente) DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Ilaria MARZI (Firmato digitalmente) Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile F.F UOC Rete Assistenza Primaria e continuità delle Cure Dr.ssa Raffaella Brigada (La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso) Il Funzionario istruttore: Collaboratore amministrativo professionale - UOC Gestione del personale dipentente e conv. Franco Brasca Assistente amministrativo - UOC Gestione del personale dipendente e conv. Sig.ra Cinzia Secchi L'anno 2020 addì 06 del mese di Agosto IL DIRETTORE GENERALE Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni; Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. -

Marco Giuliano Architetto Esperienza
marco giuliano architetto residenza Piazza Libertà, 17 - Robbio (PV) p.iva 01950180180 data di nascita 26 agosto 1975 cod. fiscale GLNMRC75M26F952F luogo di nascita Novara e-mail [email protected] mobile 3384884634 studio Via XXVI aprile, 63 - Palestro (PV) stato civile coniugato patente A-B esperienza professionale conoscenze 1993-2012 Falegnameria Giuliano Palestro (PV) informatiche Disegnatore Progettazione e sviluppo esecutivo di serramenti e arredi Autocad 2D Autocad 3D 2001-2012 BBPSTUDIO srl Vigevano (PV) Revit Architetto collaboratore Pacchetto Office Progettazione e sviluppo esecutivo nell'ambito dell'edilizia pubblica Paint Shop Pro (fotoritocco) (scuole, auditorium), dell'edilizia privata, dell'interior design, Arc View (pianificazione territoriale) dell'acustica architettonica, del restauro e della pianificazione territoriale Aspan (disegno per macchine a controllo) 2012-in corso Falegnameria Giuliano Palestro (PV) Disegnatore - Titolare Progettazione e sviluppo esecutivo di serramenti e arredi istruzione e formazione competenze 1991-1995 Diploma di Geometra presso l'ITCG "Cavour" Vercelli linguistiche 1994-1995 Corso di disegno a computer presso l'ITCG "Cavour" Vercelli Italiano Madrelingua Corso Autocad 2D e 3D Inglese Lettura livello scolastico 1995-2000 Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino Inglese Scrittura livello scolastico Tesi: "La chiesa di S.Marco a Vercelli. Studi acustici e di allestimento" Relatore: Prof. Marco Filippi 2000 Corso per tecnici competenti in acustica ambientale ed architettonica -

Fermate Noctibus - Servizio a Chiamata Notturno Di Pavia
FERMATE NOCTIBUS - SERVIZIO A CHIAMATA NOTTURNO DI PAVIA Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione PAV035 CA’ DELLA TERRA PAV194 MUNICIPIO PAV279 SAN PAOLO Ferrini PAV367 LIBERTA' Minerva PAV101 MONTEMAINO ex dazio PAV195 VOLTA Franchi Maggi PAV280 CAMPARI San Paolo PAV368 BRICCHETTI Sottopassaggio FS PAV102 MONTEMAINO Boggioni PAV196 GARIBALDI S. Giovanni in Borgo PAV281 CAMPARI Ferrini PAV369 ASELLI Golgi PAV103 MONTEMAINO PAV197 MONTEBOLONE/Amendola PAV282 BLIGNY Tasso PAV370 ASELLI Flarer PAV104 SAN BERNARDO PAV198 CREMONA Amati PAV283 REPUBBLICA P.ta Milano PAV371 ASELLI Cazzamali PAV105 MIRABELLO Scuole PAV199 CREMONA P. Tibaldi PAV284 PORTA MILANO PAV372 ASELLI Cagnoni PAV106 MIRABELLO Rampoldi PAV200 CREMONA Scarenzio PAV285 Viale Matteotti PAV375 ABBIATEGRASSO/Ist. Volta PAV107 MIRABELLO Rizza PAV201 CREMONA Salimbeni PAV286 MATTEOTTI Dante PAV377 IST. VOLTA/ABBIATEGRASSO PAV108 MIRABELLO civ. 22 PAV202 CREMONA Pollaioli PAV287 MANZONI Guidi PAV109 SCALA PAV203 SAN PIETRO IN VERZOLO PAV288 MANZONI Eredi Farina PAV378 ASELLI Cagnoni PAV110 RIONE SCALA Salvo D'Acquisto PAV204 MONTEGRAPPA Donegani PAV289 RIVIERA Folla di Sopra PAV379 MORUZZI PAV111 SCALA Olevano PAV205 PARTIGIANI Dossi PAV290 RIVIERA Arsenale PAV380 ASELLI Cazzamali PAV112 OLEVANO Briosco PAV206 PARTIGIANI San Giovannino PAV291 RIVIERA Vivai PAV381 ASELLI Bargiggia PAV113 OLEVANO Cerise PAV207 PARTIGIANI Sardegna PAV292 SAN LANFRANCO Cimitero PAV382 Via Aselli, 56 PAV114 OLEVANO Case Nuove Canonici PAV208 GORIZIA Garibaldi PAV293 -
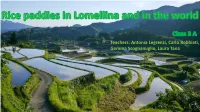
Presentazione Standard Di Powerpoint
Teachers: Antonia Legrenzi, Carlo Robbiati, Gemma Scognamiglio, Laura Tana land of water Lomellina is situated in the north-west of Italy. It is famous for • its rivers • its castles • the Via Francigena • its rice paddies There are three rivers: •Vigevano the Ticino (in the east), the Po (in the south) and the Sesia (in the west). • Vigevano • Sartirana • Scaldasole • Lomello • Olevano • Cozzo Palestro It is a very ancient route. The • Robbio • Mortara Medieval pilgrims walked along • Tromello • Pavia the route to go to Rome. They • • Corteolona Gropello • passed through Palestro, Piacenza Robbio, Mortara, Tromello, • Gropello towards Pavia and then Piacenza. There are rivers, streams, canals and springs. Natural water Artificial ways water ways Rivers Streams The spring line Canals Fountain stouts The Sesia Argogna Naviglio d’Ivrea Springs near the natural The Ticino Cavour Canal Terdoppio springs Wet meadows Diramatore Vigevano The Po Erbognone Springs and fountain stouts. Along the ‘spring line’ the underground water meets permeable layers of soil (sand and clay) and comes to Fountain stout the surface forming natural springs and, consequently, Spring fountain stouts which are artificial because they are built Permeable soil by man to distribute water. Groundwater store Impermeable soil Water is used in Lomellina for agricultural purposes POPLARS TEMPORARY BUND CANAL PERMANENT BUND This is a flooded rice paddy. It is in spring. The rice paddies look like small lakes. This is a rice paddy in summer. The rice plants are growing, they are green. This is a rice paddy in autumn. It is harvest time. The rice plants are mature, they are golden. -
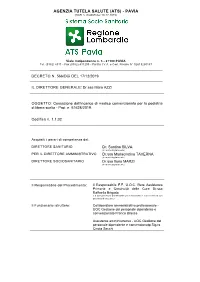
ATS) - PAVIA (DGR N
AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR n. X/4469 del 10.12.2015) Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187 DECRETO N. 566/DGi DEL 17/12/2019 IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI OGGETTO: Cessazione dall'incarico di medico convenzionato per la pediatria di libera scelta - Prot. n. 51628/2019. Codifica n. 1.1.02 Acquisiti i pareri di competenza del: DIRETTORE SANITARIO Dr. Santino SILVA (Firmato digitalmente) PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr.ssa Mariacristina TAVERNA (Firmato digitalmente) DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Ilaria MARZI (Firmato digitalmente) Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile F.F. U.O.C. Rete Assistenza Primaria e Continuità delle Cure Dr.ssa Raffaella Brigada (La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso) Il Funzionario istruttore: Collaboratore amministrativo professionale - UOC Gestione del personale dipendente e convenzionato Franco Brasca Assistente amministrativo - UOC Gestione del personale dipendente e convenzionatp Sig.ra Cinzia Secchi L'anno 2019 addì 17 del mese di Dicembre IL DIRETTORE GENERALE Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni; Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"; Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. -

Lomellina DA SCOPRIRE Introduzione Lomellina, La Piccola Loira
Lomellina DA SCOPRIRE Introduzione Lomellina, la piccola Loira Castelli, abbazie, basiliche, palazzi nobiliari. E poi garzaie, fontanili, L’Ecomuseo ha “trasformato” la Lomellina in una “piccola Loira” sfruttando l’e- dossi, cascine, antiche strade di epoca romana. Con un comun denomina- levato numero di castelli, torri e rocche risalenti al Medio Evo. Il progetto tore: il riso, che non può vivere senza acqua. Sono autentici tesori che chie- coinvolge Alagna, Castello d’Agogna, Cozzo, Frascarolo, Galliavola, Gambara- dono di essere scoperti con la prospettiva di trasformare una giornata nella na, Lomello, Mede, Olevano, Palestro, Pieve del Cairo, Robbio, Rosasco, Sar- “mesopotamia lombarda” in una sorta di viaggio sentimentale alla ricerca di tirana, Scaldasole, Torre Beretti, Tortorolo, Valeggio e Valle. Previste anche le una zona ricca di storia, di tradizioni e di buona cucina. aperture delle abbazie di Breme (San Pietro), Cergnago (Erbamara) e Mortara Dal 2008 l’Ecomuseo del paesaggio lomellino opera come un articolato pro- (Sant’Albino). In programma pause pranzo con piatti tipici lomellini. getto di tutela, valorizzazione e promozione della Lomellina, territorio dal patrimonio culturale millenario stretto fra i fiumi Po a sud, Sesia a ovest e Ti- cino a est, nella parte occidentale della provincia di Pavia. La sede è a Ferrera Erbognone, nell’ottocentesco palazzo Strada. CASTELLI RISAIE E GARZAIE Le risaie, che solo in Lomellina occupano una superficie media di 63.000 et- ABBAZIE tari, “vivono” grazie all’acqua: per produrre un chilogrammo di riso il terreno beve fino a 10.000 litri d’acqua. Il riso è il prodotto d’eccellenza della no- stra zona, in cui operano centinaia di imprese agricole e numerose industrie agroalimentari, da colossi come la Riso Gallo di Robbio e la Curtiriso di Valle Lomellina, fino alle più dinamiche realtà di trasformazione locali. -

DISTRETTO GRANDE DI PALESTRO Ufficio Elettorale Di Palestro L I S T a E L E T T O R a L E
ELEZIONI CONSORZIALI QUINQUENNIO 1/3/2015 ‐ 29/2/2020 ZONA ROGGIA BUSCA A ROBBIO DISTRETTO GRANDE DI PALESTRO Ufficio Elettorale di Palestro L I S T A E L E T T O R A L E Visto IL PRESIDENTE (Giuseppe Caresana) L’elettorato attivo e le iscrizioni nelle liste elettorali (art. II,2 del Regolamento elettorale) Hanno diritto di voto tutti i Consorziati iscritti nelle liste elettorali e sono iscritti nelle liste elettorali tutti i Consorziati che alla data del 30 settembre 2014 abbiano compiuto i diciotto anni di età e godano dei diritti civili. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti. Per le proprietà in comunione e per le società semplici o di fatto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza dei cointestatari calcolata secondo il valore delle quote; in mancanza di accordo o designazione, è iscritto il primo cointestatario della proprietà nella corrispondente partita del catasto consorziale (art. 16 dello Statuto). A tale scopo i condomini devono designare mediante procura o delega, con firma autenticata da un Notaio o - dietro presentazione di fotocopia della carta d’identità del delegante - da un Funzionario (*) dell’Associazione che conserverà per gli atti copia delle suddette delega e carta d’identità, quello fra essi che li deve rappresentare nelle elezioni. Nel caso di coniugi comproprietari non legalmente separati, è sufficiente una dichiarazione, sottoscritta da entrambi, che attesti chi dei due coniugi debba essere iscritto nelle liste elettorali. In mancanza di designazione ovvero nel caso di opposizione da parte di altri comproprietari, la proprietà comune è rappresentata di diritto dal primo intestatario della corrispondente partita del catasto consorziale. -
![LOMELLINA Orari in Vigore Dal 3 Al 23 Agosto 2015 Frequenza [3AGO] [3AGO] [3AGO] [3AGO] Numero Corsa 4 14 22 34](https://docslib.b-cdn.net/cover/3506/lomellina-orari-in-vigore-dal-3-al-23-agosto-2015-frequenza-3ago-3ago-3ago-3ago-numero-corsa-4-14-22-34-1353506.webp)
LOMELLINA Orari in Vigore Dal 3 Al 23 Agosto 2015 Frequenza [3AGO] [3AGO] [3AGO] [3AGO] Numero Corsa 4 14 22 34
linea 87 VIGEVANO - NOVARA - SOTTORETE LOMELLINA orari in vigore dal 3 al 23 agosto 2015 frequenza [3AGO] [3AGO] [3AGO] [3AGO] Numero corsa 4 14 22 34 VIGEVANO - via sacchetti 6.35 18.35 VIGEVANO - Stazione FS 18.40 VIGEVANO - via sacchetti 7.55 13.20 VIGEVANO - c.so Novara 69 6.38 7.58 13.23 18.48 VIGEVANO - c.so Novara 123 6.39 7.59 13.24 18.49 CASSOLNOVO-Molino del Conte-via Gorizia 8.02 13.27 18.52 CASSOLNOVO - molino del conte - via Trento 8.05 13.30 18.54 CASSOLNOVO - via roma 42 8.08 13.33 18.57 CASSOLNOVO - c.so C.Alberto 31 8.11 13.36 19.00 CASSOLNOVO-c.so C.Alberto 129 8.12 13.37 19.01 CERANO - via IV novembre 6.50 8.15 13.40 19.05 CERANO-via Novara 44 8.17 13.42 19.06 TRECATE - c.so roma a 87/89 8.25 13.50 19.15 TRECATE - c.so roma a 31 8.26 13.51 19.16 TRECATE - via clerici 8.27 13.52 19.17 TRECATE - via novara 38 8.28 13.53 19.18 NOVARA-via Milano 53 8.40 14.05 19.30 NOVARA-via Curtatone 8.44 14.09 19.34 NOVARA - autostazione 8.45 14.10 19.35 frequenza [3AGO] [3AGO] [3AGO] [3AGO] Numero corsa 9 61 25 47 NOVARA - autostazione 9.30 14.30 19.35 NOVARA - via Curtatone - istituti scol- 9.31 14.31 19.36 NOVARA-via XXV aprile 9.35 14.35 19.40 TRECATE - via novara 51 9.42 14.42 19.47 TRECATE - via clerici 9.43 14.43 19.48 TRECATE - c.so roma 26 9.44 14.44 19.49 TRECATE - c.so roma a 122 9.45 14.45 19.50 CERANO-via Novara 9.53 14.53 19.58 CERANO - via IV novembre 6.50 9.55 14.55 20.00 CASSOLNOVO-c.so C.Alberto 168 6.54 10.02 15.02 20.07 CASSOLNOVO-via Roma 59 6.57 10.05 15.05 20.10 CASSOLNOVO - via roma 121 6.58 10.06 15.06 20.11 CASSOLNOVO -

Pavia Acque Programma Degli Interventi 2016-2019
Pavia Acque S.c.a r.l. - Programma degli interventi 2016-2019 Popolazione Intervento Intervento nel Livello di Entrata in Importi Ipotesi di sviluppo temporale per IMPORTO TOTALE dell'investimento Stato attuale Comune interessata PdI 2014-2017 priorità esercizio RESIDUO 1 2 3 4 ID Area / Zona / Località Servizio (di ubicazione principale titolo descrizione dell'infrastruttura) ab. residenti avanz. autor. si/no da 1 a 5 anno Euro 2016 2017 2018 2019 Comune di Belgioioso. Interventi di riqualificazione della rete fognaria del Comune di Belgioioso capoluogo. Via Cavallotti, Viale Manzoni e Via ID 1 Belgioioso 250 Adeguamento rete fognaria Rilevazione della rete fognaria e interventi di sistemazione E si FGN si 1 2017 505.151 400.000 105.151 Strambio della rete fognaria Via Cavallotti, Viale Manzoni e Via Strambio. Intervento di collettamento delle acque reflue, ora Dismissione impianto di depurazione e ID 2 Cava Manara Cava Manara - Mezzana Corti 1.500 recapitate al depuratore Cava Manara - Mezzana Corti, al E si FGN si 1 2016 169.500 169.500 collettamento al depuratore depuratore Cava Manara. Comune di Miradolo Terme. Realizzazione opere di Miradolo Terme capoluogo, Terme ID 3 Miradolo Terme 1.600 Collettamento acque reflue collettamento fognario Miradolo Terme capoluogo, Terme E si FGN si 1 2016 519.933 519.933 di Miradolo e Camporinaldo di Miradolo e Camporinaldo. Comune di San Martino Siccomario. Completamento delle Rotta Travacò Siccomario a rete opere di collettamento fognario da impianto di depurazione ID 4 San Martino Siccomario 2.500 Collettamento acque reflue E si FGN si 1 2016 195.643 195.643 fognaria di Pavia intercomunale Rotta Travacò Siccomario a rete fognaria di Pavia. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus BUS BUS Mortara Visualizza In Una Pagina Web La linea bus BUS (Mortara) ha 3 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Mortara: 07:33 (2) Pavia: 04:21 - 12:21 (3) Vercelli: 05:59 - 20:38 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus BUS più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus BUS Direzione: Mortara Orari della linea bus BUS 5 fermate Orari di partenza verso Mortara: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 07:33 martedì 07:33 Vercelli Piazza Roma, Vercelli mercoledì 07:33 Palestro giovedì 07:33 Vicolo Montebello, Palestro venerdì 07:33 Robbio sabato 07:33 Via Santo Sfefano, Robbio domenica 07:33 Nicorvo Mortara Informazioni sulla linea bus BUS Direzione: Mortara Fermate: 5 Durata del tragitto: 58 min La linea in sintesi: Vercelli, Palestro, Robbio, Nicorvo, Mortara Direzione: Pavia Orari della linea bus BUS 12 fermate Orari di partenza verso Pavia: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 04:21 - 12:21 martedì 04:21 - 12:21 Vercelli Piazza Roma, Vercelli mercoledì 04:21 - 12:21 Palestro giovedì 04:21 - 12:21 Vicolo Montebello, Palestro venerdì 04:21 - 12:21 Robbio sabato 04:21 - 12:21 Via Santo Sfefano, Robbio domenica Non in servizio Nicorvo Mortara Gambolò-Remondò Informazioni sulla linea bus BUS Direzione: Pavia Tromello Fermate: 12 Via Roma, Tromello Durata del tragitto: 127 min La linea in sintesi: Vercelli, Palestro, Robbio, Garlasco Nicorvo, Mortara, Gambolò-Remondò, Tromello, Garlasco, Groppello Cairoli, Villanova D'Ardenghi, Groppello Cairoli Cava-Carbonara, -

Proposta Di Partecipazione Ad Evento
VITA MILITARE E CIVILE NEL RISORGIMENTO ITALIANO Progetto di Rievocazione e Ricostruzione Storico-culturale dell'epopea risorgimentale PREMESSA – LE PRIME EDIZIONI Nella primavera del 2014, in concomitanza con le celebrazioni dell'Anniversario della Battaglia di Palestro, l'Associazione Storica Compania de le Quatr'Arme presentò una proposta di ricostruzione storica di taluni aspetti di tale triste, benché importante, vicenda bellica. La Commemorazione della Battaglia di Palestro intese uscire un po' dai soliti schemi delle manifestazioni storiche che individuano unicamente nello scontro armato tra gli opposti schieramenti il fulcro di un'intera storia e rappresentazione. La guerra e la battaglia sono stati sicuramente importanti, ma ciò che venne proposto fu un contesto storico, fatto di uomini, donne, singoli avvenimenti e semplici azioni quotidiane. La presentazione di un campo militare ebbe l'intento, dunque, di portare questo messaggio: i soldati arrivavano in un luogo, lo occupavano, venivano accolti bene o male dagli abitanti e per un certo periodo convivevano con essi. Si poteva instaurare un'amicizia o forse anche un odio, i soldati venivano visti come salvatori ma anche come oppressori, un continuo gioco di amore ed odio, come direbbe qualcuno. L'aspetto prettamente belligerante della rievocazione della battaglia in quella prima edizione di “Vita Militare e Civile nel Risorgimento Italiano” passò in secondo piano a favore della viva (e possibilmente veritiera) rappresentazione della vita in un campo militare allestito nei pressi di un qualunque borgo di metà Ottocento: una giornata didattico-ricostruttiva per la popolazione di Palestro e per il pubblico intervenuto. Le successive due edizioni (2015 e 2016) mantennero la stessa linea, pur innovando con le attività proposte ed incrementando il numero di rievocatori storici ed associazioni coinvolte. -

Studio Geologico a Supporto Del Piano Di Governo Del Territorio
COMUNE DI PALESTRO PROVINCIA DI PAVIA STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ex art. 57 Legge Regionale 12 del 11 marzo 2005 e DGR n.8/1566 del 22 dicembre 2005 (definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica ) Dott. Geol. Antonello Borsani Viale Sforza 7 – VIGEVANO (PV) Collaborazione: Dott.ssa Elena Golfredi DOTT. GEOLOGO A. BORSANI– RELAZIONE GEOLOGICA PGT PALESTRO (PV) 2 SOMMARIO 1.0 PREMESSA ................................................................................................................................... 3 2.0 METODOLOGIA DI INDAGINE ..................................................................................................... 4 3.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ........................................................................................... 5 4.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE .......................................................................... 7 4.1 INQUADRAMENTO GeologiCO – STRUTTURALE DELLA PIANURA PADANA ............................... 7 4.1.1 GEOLOGIA .................................................................................................................... 7 4.1.2 GEOMORFOLOGIA...................................................................................................... 10 5.0 ELEMENTI DI PEDOLOGIA ....................................................................................................... 13 5.1 CAPACITA’ D’USO DEI SUOLI ............................................................................................