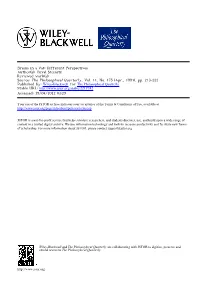PENSARE IL BIOS
B@belonline/print
- Rivista semestrale di Filosofia
- N. 5 – Anno 2008
B@belonline/print è la versione a stampa della rivista elettronica www.babelonline.net
Due modalità di esprimere la filosofia oggi che dialogano nell’identità e nella
differenza dei modi e dei contenuti
Questo numero della rivista è stato realizzato con il contributo del Dipartimento
di Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre.
B@belonline/print Direzione e Redazione
Dipartimento di Filosofia Università degli Studi Roma Tre Via Ostiense 234 00146 Roma
Sito Internet:http://host.uniroma3.it/dipartimenti/filosofia
Tel. + 39.06.57338338/57338425 – fax + 39.06.57338340
Direttore: Francesca Brezzi Comitato direttivo: Patrizia Cipolletta ([email protected]) e Chiara Di Marco
Comitato scientifico: Giuseppe Cantillo, Riccardo Chiaradonna, Claudia Dovolich, Daniella
Iannotta, Giacomo Marramao, Elio Matassi, Paolo Nepi, Maria Teresa Pansera, Stefano Poggi, Beatrice Tortolici, Carmelo Vigna Comitato di redazione: Mattia Artibani, Francesca Gambetti, Carla Guetti, Davide Maggiore, Sabine Meine, Paolo Mulè
Abbonamento annuale: 25 € (Italia), 30 € (Estero), 20 € (Studenti), 35 € (Sostenitori) da versare sul c.c. n. 38372207, intestato a: Associazione Culturale Mimesis. Spedire fotocopia della ricevuta alla Redazione di B@belonline via fax, o via e-mail, o via posta. Numeri arretrati: versare 20 € sul c.c. indicato e inviare la ricevuta alla Redazione.
Libri per recensioni, riviste e manoscritti possono essere inviati alla Segreteria di redazione: Claudia Dovolich presso il Dipartimento.
© 2008 – Mimesis Edizioni (Milano)
Sede operativa e amministrativa:
Via Mario Pichi 3 – 20143 Milano Telefono e fax: +39 02 89403935 Per urgenze: +39 347 4254976
E-mail: [email protected] Catalogo e sito Internet: www.mimesisedizioni.it
In copertina: La T o rre di Babele, Pieter Bruegel il Vecchio, 1563
Elaborazione Grafica di Marco De Meis
B
Voci e percorsi della differenza
Rivista di Filosofia
Mimesis
- @belonline
- ndice
- B
- I
Editoriale
di Francesca Brezzi
Il Tema di B@bel
a cura di Maria T e resa Pansera
Pensare il bios
Presentazione di Maria T e resa Pansera
Il contributo della biologia all’antropologia filosofica del ‘900
Helmuth Plessner
L’uomo come essere vivente
Peter Sloterdijk
L’animale abortito e la “autogenesi” del soggetto
Rossella Bonito Oliva
Immaginazione e sperimentazione. Due casi emblematici: Bolk e Simondon
Franco Bosio,
Natura e vita nel pensiero di Max Scheler
Anna Calligaris
Sloterdijk e l’umanismo, tra antropologia e filosofia
Joachim Fischer
Zur Kompatibilität von Biologie und Menschenwürde. Theorie strategien der Philosophischen Antropologie
Micaela Latini
L’antropologia eretica di G. Anders. Contingenza dell’umano ed eclissi del senso
Paolo Nepi
Jonas e il fenomeno della vita
Maria Teresa Pansera
Natura e cultura nell’antropologia di Arnold Gehlen
Vallori Rasini
Ambiente e organismo. Plessne r , G ehlen e il pensiero biologico di von Uexküll
Giacomo Scarpelli
L’eredità della scimmia
- ndice
- @belonline
- I
- B
Il bios e la peculiarità dell’umano. Nuove aperture e possibili confronti
Guido Cimino
La specificità dell’umano nella storia delle neuroscienze
Chiara Di Marco
“Corpo io sono e anima”. L’ambiguità della biopolitica
Mauro Dorato
Ha senso parlare delle basi biologiche della morale?
Mauro Fornaro
Aggressività tra natura e cultura
Federica Giardini
I neuroni specchio: alcuni antecedenti
Elio Matassi
Il cervello musicale di Mozart. Musica e neuroscienze
Spazio Aperto
a cura di Paolo Nepi
Jean-Marie Schaeffer
Théorie des signaux coûteux, esthétique et art
Ventaglio delle donne
a cura di Maria T e resa Pansera
Francesca Borruso
Scrittura e vita. L’autobiografia di Janet Frame
Laura Percoco
Scrittura di passaggi. Mireille Calle-Gruber lettrice di Assia Djebar
Filosofia e... psicologia
a cura di Beatrice T o rtolici
Silvia Brunelli, Isabella Poggi, Sissy Violini
Il pettegolezzo. Curiosità, immagine e coesione sociale
Immagini e filosofia
a cura di Daniella Iannotta
Fabrizia Abbate
Ortega y Gasset e Pierre Bourdieu. Immagini letterarie e condizione umana
- @belonline
- ndice
- B
- I
Giardino di B@bel
a cura di Claudia Dovolich
Tommaso Ariemma
Persone e cloni. A partire dalla bio-logica di Derrida
Mario Lucio Genghini
La dimensione bio-estetica in Herbert Marcuse
Ai margini del giorno
a cura di Patrizia Cipolletta
Giuseppe D’Acunto
Elogio di Babele. La parola dell’incontro in Gadame r , R icoeu r , P anikkar
Libri ed eventi
a cura di Chiara Di Marco
Libri...
S. Ciurlia, Ermeneutica e politica. L’interpretazione come modello di razionalità
(Antonio Quarta)
G. Costanzo, Ágnes Heller: costruire il bene. Una teoria etico-politica della giustizia
(Chiara Panetta)
G. Marini, La filosofia cosmopolitica di Kant
(Davide Maggiore)
G. Marramao, La passione del presente. Breve lessico della modernità-mondo
(Dario Gentili)
V. Rasini, L’essere umano.
Percorsi dell’antropologia filosofica contemporanea
(Simonetta Madussi)
…ed eventi
Paul Ricœur. L’eredità di un maestro
(Vanna Gessa Kurotschka/Gabriella Baptist/Anna Maria Nieddu)
I generi della scrittura filosofica
(Anna Stoppa)
- ditoriale
- @bel
- E
- B
di Francesca Brezzi
Il titolo di questo numero di Babelonline/print disegna immediatamente un ambito di ricerca, ma insieme propone alcuni interrogativi e indica un’esigenza: in un tempo di crisi, quale è il nostro, in cui talvolta si nega l’umanità nel profondo e con frequenza si annulla la dignità personale, in un momento di grave alienazione e spaesamento, è significativo per la riflessione mettere a tema l’essere umano, passando attraverso le discipline che lo pongono al centro della loro indagine, e talvolta come loro telos, – nel nostro caso – le scienze biologiche, l’antropologia filosofica, ma altresì le neuroscienze .
Non possiamo affrontare, nello spazio di questo editoriale, un problema interno ad alcune di questi stessi settori di studio, – e pensiamo in particolare alle scienze fisico-matematiche, alle scienze cognitive, alla stessa biologia – , cioè quanto emerge da una panoramica del loro status, dalla loro ampiezza di orizzonti: per un verso i prorompenti sviluppi, una metodologia “forte e sicura”, che si vuole contrapporre alle astrattezze filosofiche, quindi alla filosofia del Totum (parafrasando Adorno), alla filosofia come metafisica, per rivendicare, mediante una epistemologia aperta, autonomia e indipendenza; per un altro, tuttavia, la presenza di polarità e tensioni, di grandi opposizioni e insanabili contraddizioni, che sono tuttavia un segno di vitalità e non di debolezza teoretica; né va dimenticato che anche la ricerca filosofica stricto sensu, ha preso congedo dal pensiero sistematico, dall’onto-teologia, per dirla con Heidegger, e l’ambito della speculazione contemporanea offre un panorama culturalmente frantumato, manifesta vari fermenti, percorso dai sentieri molteplici di una nuova razionalità.
Editoriale Il tema di B@bel
Spazio aperto Ventaglio delle donne
Filosofia e...
Da qui il plesso teoretico e pratico che oggi ci interessa: ricordiamo le affermazioni di Max Scheler nei lontani anni ’20: ‹‹Debbo constatare con una certa soddisfazione che i problemi dell’antropologia filosofica sono oggi in Germania al centro di tutta la problematica speculativa e che i biologi, i medici, gli
Immagini e Filosofia Giardino di B@bel Ai margini del giorno Libri ed eventi
psicologi e i sociologi anche fuori dai circoli specificamente filosofici, lavorano intorno ad una nuova concezione della struttura essenziale dell’uomo››, (La posizione dell’uomo nel mondo,1970); circa novant’anni dopo – considerando lo sviluppo intercorso –, ci interroghiamo circa i rapporti tra l’antropologia filosofica e le scienze che a questa si collegano e da questa si dipartono? Gli autori considerati in questo volume appartengono a varie scuole o tendenze, le culture di provenienza sono disparate, i percorsi indipendenti, e questo rappresenta un elemento propulsore e fecondo di ulteriori sviluppi, ma tutti sembrano voler rispondere alla domanda che costituisce un titolo significativo della cultura tedesca degli anni di Scheler – che sono anche quelli di Gehlen e Plessner, di Heidegger, Buber, e Löwith –: Was ist der Mensch? di Thomas Haecker.
Leggendo i vari saggi che – come di consueto – manifestano itinerari diversi di pensiero volendo tracciare alcune costanti si può innanzi tutto affermare che l’essere umano – totalità vivente – , non deve essere studiato da una sola scienza o da un unico angolo visuale, sia esso morfologico o fisiologico, psicologico o anche teologico, ma dalla complementarietà di tutte; ne segue l’interrogazione che va al cuore del rapporto natura-cultura, il quesito che gli scienziati della mente – ma altresì i filosofi –si pongono negli inquieti tempi che viviamo: quanto dei nostri comportamenti è di origine innata, inciso nel nostro cervello e quanto invece è determinato dalla nostra interazione con il mondo esterno? La risposta può indicare come il radicarsi del soggetto alla natura non si risolva in un piatto naturalismo, ma anzi si offra una possibilità di superare ogni prospettiva meccanicistica, a favore di una visione organicistica.
In secondo luogo si può sottolineare come emerga una valutazione critica e radicale dell’umano, da intendere sia come accettazione di alcune cifre caratteristiche, sia come rifiuto: non solo opposizione nei confronti di una concezione filosofica astratta, o di un Geist inglobante le differenze, ma anche critica di ogni atteggiamento di scientismo paleopositivista, per schiudere un quadro più ampio di correlazioni e rapporti pluralistici tra differenti metodi di indagine e vari campi del sapere. Da qui, l’assunzione di un umanismo consapevole, un vero antropologismo, che si occupa degli individui e non delle essenze, dal momento che per le scienze umane l’essere che vale è quello delle esistenze, non una sostanza nell’unità, ma una tensione fra le pluralità.
Se Hans Jonas introduce la sua ampia riflessione sul mutato rapporto uomo-natura con le celebri parole del Coro dell’Antigone ‹‹Molte ha la vita forze tremende; eppure più dell’uomo nulla vedi è tremendo›› Antigone (v. 334), il pensare il bíos qui proposto forse delinea l’umanesimo dell’altro uomo di cui ha parlato Lévinas, in altri termini la riflessione filosofica lontana dai naturalismi già criticati dalla scuola fenomenologica, ma altresì ugualmente distante da una ebbra filosofia dell’assoluto vuole concorrere alla riformulazione di un moderno – complesso e fragile – umanesimo e quindi aprirsi all’ambito etico e politico.
Francesca Brezzi
- tema di B@bel
- @bel
- Il
- B
A cura di Maria T e resa Pansera
Pensare il bios
Presentazione di Maria T e resa Pansera
Il contributo della biologia all’antropologia filosofica del ‘900
Helmuth Plessner
L’uomo come essere vivente
Peter Sloterdijk
L’animale abortito e la “autogenesi” del soggetto
Rossella Bonito Oliva
Immaginazione e sperimentazione. Due casi emblematici: Bolk e Simondon
Franco Bosio
Natura e vita nel pensiero di Max Scheler
Anna Calligaris
Sloterdijk e l’umanismo, tra antropologia e filosofia
Joachim Fischer
Zur Kompatibilität von Biologie und Menschenwürde. Theorie strategien der Philosophischen Antropologie
Micaela Latini
L’antropologia eretica di G. Anders. Contingenza dell’umano ed eclissi del senso
Paolo Nepi
Jonas e il fenomeno della vita
Editoriale
Maria Teresa Pansera
Natura e cultura nell’antropologia di Arnold Gehlen
Il tema di B@bel Spazio aperto
Vallori Rasini
Ambiente e organismo. Plessne r , G ehlen e il pensiero biologico di von Uexküll
Ventaglio delle donne Filosofia e...
Giacomo Scarpelli
L’eredità della scimmia
Immagini e Filosofia Giardino di B@bel Ai margini del giorno Libri ed eventi
@bel
B
Il bios e la peculiarità dell’umano. Nuove aperture e possibili confronti
Guido Cimino
La specificità dell’umano nella storia delle neuroscienze
Chiara Di Marco
“Corpo io sono e anima”. L’ambiguità della biopolitica
Mauro Dorato
Ha senso parlare delle basi biologiche della morale?
Mauro Fornaro
Aggressività tra natura e cultura
Federica Giardini
I neuroni specchio: alcuni antecedenti
Elio Matassi
Il cervello musicale di Mozart. Musica e neuroscienze
Editoriale Il tema di B@bel Spazio aperto Ventaglio delle donne Filosofia e... Immagini e Filosofia Giardino di B@bel Ai margini del giorno Libri ed eventi
Pr e s e n t a z i o n e
ALLE RADICI DEL BíOS
L’uomo si è da sempre posto la domanda sulla propria natura, alla ricerca di quella immagine di sé, complessiva e unitaria, che solo attraverso conoscenze filosoficamente strutturate spera di poter raggiungere. «È molto improbabile che noi, che possiamo conoscere, determinare e definire l’essenza naturale di tutte le cose che ci circondano, di tutto ciò che non siamo, possiamo mai essere in grado di fare lo stesso per noi: sarebbe come scavalcare la nostra ombra»1. Così si esprime Hannah Arendt riferendosi agli esseri umani come a coloro che si trovano a loro agio nel conoscere le cose esterne e in grande difficoltà quando cercano di conoscere veramente se stessi, come se non fossero in grado di superare una sorta di inafferrabilità, di insondabilità, di impenetrabilità della natura umana più profonda. È quindi molto difficile per l’uomo individuare quegli aspetti che lo caratterizzano, lo identificano e lo differenziano da tutti gli altri viventi, dando così una risposta alla domanda di fondo: esistono elementi specifici ed essenziali che caratterizzano gli esseri umani e senza i quali la loro umanità verrebbe meno?
Già Kant arrivò a far convergere le sue tre domande, «Che cosa posso sapere? Che cosa devo fare? Che cosa mi è lecito sperare?», nella domanda conclusiva che le comprende tutte: «Che cosa è l’uomo?». Tuttavia Foucault ha sostenuto che solo a partire dal secolo XVIII si è cominciato a porre in occidente questo genere di domande, in particolare con la nascita delle cosiddette scienze umane; ed è giunto ad affermare che «l’uomo è un’invenzione recente»2. Bisogna poi tener conto, in particolare dopo la rivoluzione darwiniana, della prospettiva naturalistica e biologica del tutto nuova con cui si è affrontato il problema antropologico, fino allo straordinario sviluppo attuale delle neuroscienze. In sostanza non esiste più nessun aspetto o elemento umano, sia esterno che interno, visibile o invisibile, che non sia oggetto di minuziose analisi, indagini, osservazioni.
Il riferimento alla biologia diviene quindi un motivo fondamentale per cercare di dare una risposta alla questione del vivente, divenuta essenziale per gli studiosi del XX secolo. Tutto ciò si manifesta nella espressione di Plessner che attribuisce ad ogni epoca la “propria parola redentrice”.
12
H. Arendt, The Human Condition, University Press, Chicago 1958; tr. it. Vita activa. La condizione
umana (1964), Bompiani, Milano 19913, pp. 9-10.
M. Foucault, Les mot set les choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, Paris 1966;
tr. it. Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 1967, p. 13.
13
tema di B@bel
Il
«La terminologia del XVIII secolo culmina nel concetto di Ragione, quella del XIX nel concetto di Evoluzione, l’attuale nel concetto di Vita. Ogni epoca indica in questo modo qualcosa di diverso. La Ragione mette in risalto ciò che è senza tempo e vincola ogni cosa; l’Evoluzione ciò che diviene e si sviluppa senza sosta; la Vita il gioco demoniaco e la creazione inconsapevole. Eppure tutte le epoche vogliono catturare la stessa cosa, e usano il significato delle parole come un mezzo, se non come uno schermo, per rendere visibile quell’ultima profondità delle cose senza la cui consapevolezza ogni impresa umana rimane priva di uno sfondo e di un senso»3.
Il bíos, la vita diviene quindi il concetto rappresentativo del XX secolo, una formula vincente in cui molti intellettuali dell’epoca trovarono il punto di partenza per rendere conto dell’essere umano e della sua complessità. «In questa parola l’epoca sente la sua peculiare forza, il suo dinamismo, la sua giocosità, la sua gioia per il demoniaco nel futuro sconosciuto; e la sua particolare debolezza, la sua carenza di originarietà, di dedizione, di capacità di vivere»4.
Di fronte alla crisi dell’idealismo vi furono due diverse reazioni: o si cercò di ristabilire la ragione in stretto collegamento con le scienze della natura, come nel neokantismo e nell’empirismo logico; o ci si affidò a questa categoria piena di contrasti, la “vita”, presentata come il nuovo e immanente strumento che, opponendosi al rigore del dogmatismo razionalistico e alla rigidità del positivismo meccanicistico, collocava nella pienezza e nelle potenzialità del vitale la dimensione più originaria della filosofia. Già Schelling aveva introdotto la volontà che, in quanto libertà e spontaneità dell’agire, si opponeva al determinismo della natura e alla necessità del diritto. Schopenhauer nei due concetti di volontà e rappresentazione evidenzia la distinzione tra la capacità rappresentativa dell’intelletto e l’immediatezza fenomenica dell’esperienza. Nietzsche poi sottolinea l’irriducibilità del vivente alle leggi fisico-chimiche per permettere alla vita di andare oltre se stessa e incrementare la propria potenza. Diversa è la posizione di Bergson, secondo il quale per comprendere i processi evolutivi occorre riferirsi ad una forza detta “slancio vitale” che è in grado di condurre la materia verso mete superiori continuamente rinnovate.
Questa situazione in cui si venne a trovare il pensiero filosofico rappresentò una sfida per quei pensatori che non accettarono la dicotomia tra filosofia della ragione e filosofia della vita, ma cercarono di tenere insieme entrambi i modi di intendere e descrivere l’uomo. Delusi dal crollo dell’idealismo, ma al tempo stesso affascinati dalle filosofie della vita, essi cercarono di riportare la categoria di spirito all’interno della categoria di vita, riannodando i fili di un discorso che implicava una nuova impostazione della filosofia.
Ponendosi in questa prospettiva, un gruppo di filosofi e di scienziati tedeschi nella prima metà del ’900 hanno tentato di analizzare l’uomo in prospettiva biologica, sia per differenziarlo dall’animale, ricercandone così la specificità, sia per ricomporre in unità