La Newsletter N.16 Di RARE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Social Report 2012
Social Report 2012 www.slowfoodfoundation.org 1 2 Social Report 2012 Slow Food Foundation for Biodiversity The Slow Food Foundation for Biodiversity has published a Social Report since 2006, presenting its activities and their environmental, economic, social and cultural impact. The Social Report recounts a year of work not only in numbers but also through descriptions of activities and testimonials from individuals involved in these projects (producers, technical advisors, cooks, students and others). The 2011 Slow Food Foundation for Biodiversity Social Report can be downloaded in electronic format from the website www.slowfoodfoundation.org. From May 30, 2013, a free print copy can be requested by sending an email to [email protected]. Main Offi ce Regional Headquarters Slow Food Azienda Regionale Agricola di Alberese Via della Mendicità Istruita, 14 – 12042 Bra (Cn), Italy Loc. Spergolaia – 58100 Alberese (Gr), Italy Offi cial Headquarters Contact Us Accademia dei Georgofi li tel. +39 0172 419701 – fax +39 0172 419725 Piazzale degli Uffi zi – 50122 Florence, Italy [email protected] Editors Translation Cristina Battaglino, Silvia Ceriani, Eleonora Giannini, Carla Ranicki Serena Milano Editing Editorial Team Simone Gie, Bess Mucke Cristina Agrillo, Serena Alaimo, Andrea Amato, Elena Aniere, Carlotta Baitone, Francesca Baldereschi, Valentina Bianco, Cover Photo Carlo Bogliotti, Roba Bulga, Maurizio Busca, Elisabetta Cane, Karrayu Herders'Camel Milk Presidium, Ethiopia Salvatore Ciociola, Daniela Conte, Leonardo D’Angelone, ©Paola -

This Is the Pre-Peer Reviewed Version of the Following
"This is the pre-peer reviewed version of the following article: Bovo S, Ribani A, Muñoz M, Alves E, Araujo JP, Bozzi R, Charneca R, Di Palma F, Etherington G, Fernandez AI, García F, García-Casco J, Karolyi D, Gallo M, Gvozdanović K, Martins JM, Mercat MJ, Núñez Y, Quintanilla R, Radović Č, Razmaite V, Riquet J, Savić R, Schiavo G, Škrlep M, Usai G, Utzeri VJ, Zimmer C, Ovilo C, Fontanesi L. Genome-wide detection of copy number variants in European autochthonous and commercial pig breeds by whole-genome sequencing of DNA pools identified breed-characterising copy number states. Anim Genet. 2020 Aug;51(4):541-556. doi: 10.1111/age.12954 which has been published in final form at [https://doi.org/10.1111/age.12954]. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions." Supplementary material Genome-wide detection of copy number variants in European autochthonous and commercial pig breeds by whole genome sequencing of DNA pools Samuele Bovo, Anisa Ribani, Maria Muñoz, Estefania Alves, Jose P. Araujo, Riccardo Bozzi, Rui Charneca, Federica Di Palma, Graham Etherington, Ana I. Fernandez, Fabián García, Juan García- Casco, Danijel Karolyi, Maurizio Gallo, Kristina Gvozdanović, José Manuel Martins, Marie-José Mercat, Yolanda Núñez, Raquel Quintanilla, Čedomir Radović, Violeta Razmaite, Juliette Riquet, Radomir Savić, Giuseppina Schiavo, Martin Škrlep, Graziano Usai, Valerio J. Utzeri, Christoph Zimmer, Cristina Ovilo, Luca Fontanesi Table S1. Details on the analysed -
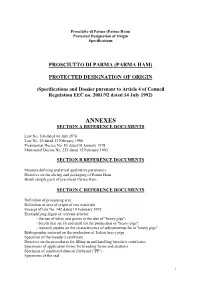
Parma (Parma Ham) Protected Designation of Origin Specifications
Prosciutto di Parma (Parma Ham) Protected Designation of Origin Specifications PROSCIUTTO DI PARMA (PARMA HAM) PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN (Specifications and Dossier pursuant to Article 4 of Council Regulation EEC no. 2081/92 dated 14 July 1992) ANNEXES SECTION A REFERENCE DOCUMENTS Law No. 506 dated 04 July 1970 Law No. 26 dated 13 February 1990 Presidential Decree No. 83 dated 03 January 1978 Ministerial Decree No. 253 dated 15 February 1993 SECTION B REFERENCE DOCUMENTS Measure defining analytical qualitative parameters. Directive on the slicing and packaging of Parma Ham. Blank sample pack of pre-sliced Parma Ham. SECTION C REFERENCE DOCUMENTS Definition of processing area Definition of area of origin of raw materials Excerpt of law No. 142 dated 19 February 1992 Exemplifying digest of relevant articles: - the use of whey and grains in the diet of "heavy pigs"; - breeds that are fit and unfit for the production of "heavy pigs"; - research studies on the characteristics of subcutaneous fat in "heavy pigs" Bibliographic material on the production of Italian heavy pigs Specimen of the breeder's certificate Directive on the procedures for filling in and handling breeder's certificates Specimens of application forms for breeding farms and abattoirs Specimen of numbered abattoir firebrand ("PP") Specimens of the seal 1 Specimen of the seal application report Specimen of the certification brand (fire-branding) report Partial copy of the producer's report Imprint of the Ducal Crown trademark SECTION D REFERENCE DOCUMENTS Bibliography of publications containing historical references to various aspects of Parma Ham, in particular pig breeding in the Po Valley and in Parma, production and marketing of Parma Ham. -
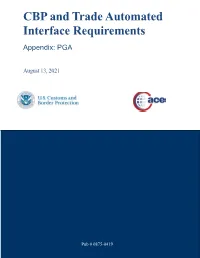
ACE Appendix
CBP and Trade Automated Interface Requirements Appendix: PGA August 13, 2021 Pub # 0875-0419 Contents Table of Changes .................................................................................................................................................... 4 PG01 – Agency Program Codes ........................................................................................................................... 18 PG01 – Government Agency Processing Codes ................................................................................................... 22 PG01 – Electronic Image Submitted Codes .......................................................................................................... 26 PG01 – Globally Unique Product Identification Code Qualifiers ........................................................................ 26 PG01 – Correction Indicators* ............................................................................................................................. 26 PG02 – Product Code Qualifiers ........................................................................................................................... 28 PG04 – Units of Measure ...................................................................................................................................... 30 PG05 – Scientific Species Code ........................................................................................................................... 31 PG05 – FWS Wildlife Description Codes ........................................................................................................... -

Menu-Ristorante-Ingl
FOODS TO REPORT FOR INTOLERANCE AND FOOD ALLERGIES GRAINS WITH GLUTEN SHELLFISH EGGS FISH PEANUTS SOY E TT MILK AND LACTOSE LA NUTS (ALMONDS, HAZELNUTS, WALNUTS, PISTACHIOS) CELERY SENAPE MUSTARD SESAM SEEDS SULFUR DIOXIDE AND SULPHITES IF ABOVE CERTAIN CONCENTRATIONS LUPINS CLAMS PLEASE REPORT ANY FURTHER INTOLERANCE THAN THOSE WRITTEN ABOVE The easier cooking seems, the more it needs to be watched, as the margin of error is bound to increases. Fulvio Pierangelini OUR COCKTAILS MILANO/TORINO “NOSTRA RISERVA” “MI-TO” 12,00 SPRITZ 10,00 AMERICANO 12,00 NEGRONI 12,00 OUR VERMOUTH “REGOLA VII” 10,00 GIN TONIC TRAVEL 12,00 HENDRICK’S fresh and citrus scent, note of black pepper, rose and cucumber scotland CLANDESTINO resinious, not filtered “amber”, dry, slightly spicy and citrusy ITALY (EMILIA ROMAGNA) BLU GIN fragrant, herbaceous notes with coriander and cardamomo perfume ITALY (UMBRIA) MARCONI 46 juniper with balsamic and spicy notes ITALY (VENETO) AQUAMIRABILIS 43° 12° fresh, citrusy test, sea taste, intense, floral ITALY (UMBRIA) SABATINI GIN fresh, prickly, aromatic with lavender and thyme taste ITALY (TUSCANY) OUR SELECTION ACCIUGHE CANTABRIA LA BURRATA PUGLIESE CON ALICI 24,00 “burrata” cheese with anchovies from cantabrian sea E TT LA BOCCONI DI BUFALA E ALICI DEL MAR CANTABRICO 16,00 3 small buffalo dop mozzarellas served with cantabrian sea anchovies, taggiasche olives and evo oil with trombolotto lemon E TT LA ACCIUGHE 23,00 cantabrian sea anchovies selection served with toasted bread, sweet vanilla butter from st.Malò and french -
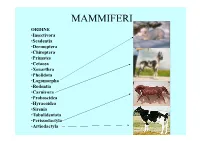
04.07.Suini.Pdf
MAMMIFERI ORDINE •Insectivora •Scadentia •Dermoptera •Chiroptera •Primates •Cetacea •Xenarthra •Pholidota •Lagomorpha •Rodentia •Carnivora •Proboscidea •Hyracoidea •Sirenia •Tubulidentata •Perissodactyla •Artiodactyla ARTIODACTYLA La definizione tradizionale li presenta come ungulati che possiedono un numero pari di dita e la cui zampa è retta ugualmente del terzo e quarto dito contrariamente ai perissodattili, che possiedono un numero dispari di dita e il cui peso è supportato essenzialmente dal terzo dito. ARTIODACTYLA Suiformes Suidae Tayassuidae Hippopotamidae Tylopoda Camelidae Ruminantia Tragulidae Cervidae Bovidae Antilocapridae Giraffidae Maiale o Suino domestico - Classe Mammiferi - Ordine Artiodattili - Sottordine Suiformi - Famiglia Suidi - Genere Sus - Specie scrofa domesticus Classificazione e origini Secondo molti Autori, i maiali domestici deriverebbero dal cinghiale (Sus scrofa o Sus ferus), che già 10 milioni di anni fa era molto diffuso sia in Europa che in Asia e nel Nord Africa. Secondo altri Autori, oltre al cinghiale avrebbero partecipato alla formazione della specie e delle razze attuali: - il Sus vittatus dell'Asia meridionale, a testa corta, tronco tozzo e zampe brevi, (attualmente esistente in Cina, Indonesia ed India), progenitore delle razze inglesi Yorkshire e Berkshire, della Poland China americana e dell'Edelschwein tedesca; - il Sus mediterraneus, derivato da incroci di forme selvatiche europee ed asiatiche Domesticazione La prima domesticazione del suino è avvenuta probabilmente in Cina oltre 7.000 anni fa. In Mesopotamia, nel 3.500 a.C., esistevano maiali già addomesticati da tempo. Egizi, Greci e Romani il "porco" è sempre stato tenuto in gran conto. La letteratura classica è piena di riferimenti al maiale ed al suo allevamento. Nel Medioevo l'allevamento suino brado assunse un ruolo di primo piano. -

La Mora Romagnola Da Loro Registrato Nel 1996: Quello Unico Ed Originale
Mora Romagnola. Una passione che prende alla gola. La curiosità e la passione per le cose buone ed originali mi hanno spinto a casa di Mario Lazzari, alla ricerca della “mora romagnola”. Una denominazione in grado di suscitare nei maschi romagnoli fantasie piccanti, che ben si sposano con la ricerca di piatti appetitosi. Vidi per la prima volta quel tipo di maiale durante la mia gioventù, nella stalla di mio nonno. Ritrovarlo a casa di Lazzari fu come fare un salto nel passato. Fu in quel momento che decisi di fare salumi come una volta, con il sapore antico della tradizione, senza la fretta e i dettami commerciali delle moderne produzioni. Per me il massimo: lavorare con passione ad un progetto di grande fascino. Così è iniziata questa avventura fatta di cene con gli amici e di esperimenti produttivi. Nel 2005 Mario e Bruna Lazzari hanno voluto cedermi il Marchio della Mora Romagnola da loro registrato nel 1996: quello unico ed originale. I prelibati alimenti che produciamo, carne fresca e salumi, sono frutto dell’elaborazione di carni provenienti da suini allevati dai Lazzari. E anche dall' Az. Agr. San Tomaso, il cui proprietario, Raffaele Rizzi, da appassionato qual’ è di gastronomia, si è lasciato coinvolgere dalla passione di mantenere viva una tradizione secolare ed alleva More Romagnole di ottima qualità. Con la produzione di salumi di Mora Romagnola ho la responsabilità di far rivivere una tradizione fatta di bontà quasi perdute. Un sapore d’altri tempi. Un piacere moderno. Gabriele DelVecchio DELVECCHIO è proprietario del marchio registrato. Mario Lazzari nel suo allevamento di Faenza con Gabriele DelVecchio DELVECCHIO è proprietario del marchio registrato. -

Ordinary Supplement to the ''Official Gazette” No
Ordinary supplement to the ‘‘Official Gazette” no. 77 of 2 April 2007 – General series Postal subscription 45% - art. 2, para. 20/b Law 23-12-1996, no. 662 - Rome branch OFFICIAL GAZETTE OF THE ITALIAN REPUBLIC PUBLISHED EVERY DAY FIRST PART Rome - Monday, 2 April 2007 EXCEPT HOLIDAYS DIRECTION AND EDITION BY MINISTRY OF JUSTICE – OFFICE FOR PUBLICATION OF LAWS AND DECREES - VIA ARENULA 70 - 00186 ROME ADMINISTRATION BY THE STATE PRINTING OFFICE AND MINT – STATE LIBRARY - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROME - SWITCHBOARD 06 85081 No. 92 MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND FORESTRY POLICIES PROVISION of 21 March 2007. Production specification for the protected designation of origin “Prosciutto di San Daniele” [San Daniele ham] 2-4-2007 Ordinary supplement to the OFFICIAL GAZETTE General series – no. 77 SUMMARY __________ MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND FORESTRY POLICIES PROVISION of 21 March 2007. – Production specification for the protected designation of origin “Prosciutto di San Daniele” .................................................... P. 5 GENERAL SPECIFICATION .............................................................................................................. P. 7 3 ― ― 2-4-2007 Ordinary supplement to the OFFICIAL GAZETTE General series – no. 77 MINISTERIAL DECREES, RESOLUTIONS AND ORDINANCES MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND FORESTRY POLICIES PROVISION of 21 March 2007. Production specification for the protected designation of origin “Prosciutto di San Daniele” THE GENERAL DIRECTOR FOR THE QUALITY OF AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTS Considering that with (EC) Regulation no. 1107/1996 of the Commission of 12 June 1996, the designation “Prosciutto di San Daniele” with reference to the meat preparation category was registered as Protected Designation of Origin in the register of protected designations of origin (P.D.O.) and protected geographical indications (P.G.I.) specified by art. -

Italian Pigs: Stories of Gone Breeds
SAVE e-News 4/2018 Safeguard for Agricultural Varieties in Europe The quarterly electronic information service of the SAVE Foundation SAVE Project Office Neugasse 30, CH 9000 St. Gallen, Switzerland / www.save-foundation.net / [email protected] Italian Pigs: Stories of gone Breeds Riccardo Fortina, Università di Torino – RARE Nero Siciliano pig family. Source: Bigi ,D., Zanon, A. (2008) Atlante delle Razze Autoctone Black pigs seem to be established in Italy since a Italy uniformly tended towards white pigs (York- long time: Already in 1820 Francesco Toggia stat- Shire and Large-White).". He underlined in par- ed in his essay “Intorno all’educazione, migliora- ticular the situation of the Mora Romagnola breed, mento e conservazione delle razze de’ porci” that almost entirely used to obtain hybrids: "... the Italy hosts many pig populations of mostly black province of Forlì possesses almost all of the colour. Toggia did not speak about pig breeds, but heads of the Large-White breed and of the so- certainly distinguishes between various popula- called Fumata or Brinata breed, which is a cross- tions in different regions of Italy. From Toggia one ing of the local Romagnola or Castagnona breed can infer that already in the beginning 19th centu- with Large-White .” ry some pig populations had become rare or were Today ANAS (Associazione Nazionale Allevatori at risk of being mixed with others. Suini, Italian Association of Pig Breeders) lists the A century later Ettore Mascheroni in “Zootecnica following breeds: Speciale III. Suini 1927” lists 22 pig breeds (31 if - Apulo-Calabrese (synonyms: Calabrese – the “varieties” are counted) and notes that some Nero calabrese - Pugliese - Nero pugliese - of them especially in northern Italy are close to Nero dei Monti Dauni meridionali - Nero di extinction, mainly due to crossbreeding. -

Diapositiva 1
Classificazione tassonomica dei suini allevati regno Animalia phylum Chordata classe Mammalia ordine Artiodactyla famiglia Suidae genere Sus specie Sus scrofa Bayesian (MCMC) consensus tree of 122 Sus mtDNA control region haplotypes rooted by a common warthog (Phacochoerus aethiopicus). A total of 14 clusters (represented by a specific color and corresponding region on the Eurasian map) are contained within four major clades on the tree (1 to 4). Tips associated with the island of Sulawesi represent the native wild boar Sus celebensis. All other tips represent wild Sus scrofa unless indicated by the following two-letter codes: sb, Sus barbatus; sv, Sus verrucosus. D1 to D6 represent suggested centers of domestication. D1 to D3 indicate areas where native wild boar have haplotypes identical to those of domestic pigs from the same region. Larson, et al.Science 307, 1618 (2005); Cinghiale europeo Domesticazione + miglioramento genetico Attuali razze suine cosmopolite Cinghiale europeo Cerdo iberico Landrace Landrace Large white (yorkshire) Andamento del progresso genetico sulle razze suine europee Confronto fra sezioni di suini di differente razza macellati allo stesso peso da: Ensminger & Parker, 1997 Categorie animali dell’allevamento suino Lattonzolo Suinetto maschio o femmina dalla nascita fino allo svezzamento Lattone Suini di entrambi i sessi dallo svezzamento a 25-30 kg di PV Verretto Maschio destinato alla riproduzione, da lattone fino al 1° salto Verro Maschio adulto in riproduzione Scrofetta Femmina destinata alla riproduzione, -

Prosciutto Di Parma (Parma Ham) Protected Designation of Origin
Prosciutto di Parma (Parma Ham) Protected Designation of Origin Specifications and Dossier Pursuant to Article 4 of Council Regulation (EEC) N°2081/92 dated 14th July 1992 1 TITLE: "PARMA HAM" DESIGNATION OF ORIGIN SPECIFICATIONS AND DOSSIER Pursuant to Article 4 of Council Regulation (EEC) n°2081/92 dated 14th July 1992 SECTION A: PRODUCT NAME AND NATIONAL PROTECTION LEGISLATION SECTION B: PRODUCT DESCRIPTION, RAW MATERIALS USED AND THE MAIN PHYSICAL, CHEMICAL, MICROBIOLOGICAL AND ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS B.1: Product Description B.2: Analytical Qualitative parameters B.3: Classification of raw materials (fresh legs) B.4: Procedures for the presentation of Parma Ham and pre-packed Parma Ham. SECTIONC: DEFINITION OF GEOGRAPHICAL AREA AND COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF ARTICLE 2, PARAGRAPH 4 OF (EEC) REGULATION N° 2081/92. C.1: The production area of Parma Ham C.2: Location of processing plants C.3: Defined area of origin of raw material C.4: Applicable legislation C.5: Location of pig breeding farms, slaughter-houses and cutting plants C.6: Number of recognized breeding farms and slaughter-houses C.7: Introduction to the requirements pursuant to article 2 of (EEC) Regulation n° 2081/92. C.7.1: Breeds and the requirements of pigs destined for the production of Parma Ham. C.7.2: Other policies and special conditions C.7.3: Feeding of pigs destined for the production of Parma Ham C.7.4: Breeding policies of pigs destined for the production of Parma Ham. 2 C.8: Introduction to the inspection system pursuant to Article 2, paragraph 4 of (EEC) Regulation n° 2081/92. -

Roscioli-Menu-Ing Ge
The easier cooking seems, the more it needs to be watched, as the margin of error is bound to increases. Fulvio Pierangelini OUR COCKTAILS MILANO/TORINO “NOSTRA RISERVA” “MI-TO” 12,00 SPRITZ 10,00 AMERICANO 12,00 NEGRONI 12,00 OUR VERMOUTH “REGOLA VII” 10,00 GIN TONIC TRAVEL 12,00 HENDRICK’S fresh and citrus scent, note of black pepper, rose and cucumber scotland CLANDESTINO resinious, not filtered “amber”, dry, slightly spicy and citrusy ITALY (EMILIA ROMAGNA) BLU GIN fragrant, herbaceous notes with coriander and cardamomo perfume ITALY (UMBRIA) MARCONI 46 juniper with balsamic and spicy notes ITALY (VENETO) AQUAMIRABILIS 43° 12° fresh, citrusy test, sea taste, intense, floral ITALY (UMBRIA) SABATINI GIN fresh, prickly, aromatic with lavender and thyme taste ITALY (TUSCANY) FOODS TO REPORT FOR INTOLERANCE AND FOOD ALLERGIES GRAINS WITH GLUTEN SHELLFISH EGGS FISH PEANUTS SOY E TT MILK AND LACTOSE LA NUTS (ALMONDS, HAZELNUTS, WALNUTS, PISTACHIOS) CELERY SENAPE MUSTARD SESAM SEEDS SULFUR DIOXIDE AND SULPHITES IF ABOVE CERTAIN CONCENTRATIONS LUPINS CLAMS PLEASE REPORT ANY FURTHER INTOLERANCE THAN THOSE WRITTEN ABOVE HIS MAJESTY THE WHITE TRUFFLE “TUBER MAGNATUM PICO” ORIGIN: ALBA, ACQUALAGNA, SAN GIMIGNANO, SAN MINIATO THE PRICE IS BY THE GRAM AND IT HAS TO BE CALCULATED ON TOP OF THE PRICE OF THE DISH THE WHITE TRUFFLE PRICE AND THE PLACE WHERE IT IS FROM CHANGES EVERY DAY, SO PLEASE ASK TO THE WAIT STUFF ABOUT THE QUOTATION APPETIZERS PLAIN BURRATA CHEESE FROM ANDRIA 16,00 E TT LA BEEF CARPACCIO 16,00 FRIED “PAOLO PARISI” EGG 6,00 FORST