Rg.3 Relazione Storica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

LINEA N. 138 Percorsi Aa E Ar.Pdf
Affidatario: S.C. a r.l. "CONSORZIO AUTOLINEE DUE" Esercente: CONSORZIO AUTOLINEE S.r.L. LINEA N. 138: COSENZA (Autostazione) - RENDE (Roges - Commenda - Quattromiglia - Arcavacata - UNICAL Terminal e Dipartimento Ingegneria) CON DEVIAZIONI. Percorsi "aa" e "ar" CORSE DI ANDATA N°Corsa 20246 20247 20248 20249 20213 20250 20214 20251 20252 20215 20253 20254 20216 20255 20256 20257 20217 2049 20218 20258 20259 20219 20220 20260 20221 20261 20222 2073 Periodo E2 E2 E2 E2 FES2 E2 FES2 E2 E2 FES2 E2 E2 FES2 E2 E2 E2 FES2 UNIV FES2 E2 E2 FES2 FES2 E2 FES2 E2 FES2 UNIV FERMATE Cadenza FER6 FER6 FER6 FER6 FEST FER6 FEST FER6 FER6 FEST FER6 FER6 FEST FER6 FER6 FER6 FEST FER6 FEST FER6 FER6 FEST FEST FER6 FEST FER6 FEST FER6 Percorso aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa Km Tot 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 COSENZA (Autostazione - Corsia n. 7) 07:30 08:00 08:20 09:00 09:00 10:00 10:45 11:00 11:35 12:00 12:05 12:35 13:00 13:05 13:35 14:00 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00 16:05 18:00 18:05 19:00 19:05 20:00 20:00 COSENZA (Viale Mancini -solo itinerario) 07:31 08:01 08:21 09:01 09:01 10:01 10:46 11:01 11:36 12:01 12:06 12:36 13:01 13:06 13:36 14:01 14:01 14:01 15:01 15:01 16:01 16:06 18:01 18:06 19:01 19:06 20:01 20:01 COSENZA (Via Falcone n.c. -
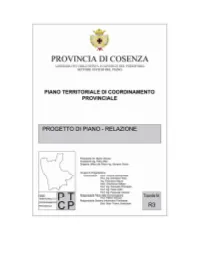
R3prorel.Pdf
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PROGETTO DI PIANO relazione 2 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL P.T.C.P. Il PTCP si conforma alle seguenti normative, comunitarie, nazionali e regionali: • Convenzione europea del paesaggio; • Accordo per l’attuazione della convenzione europea del paesaggio in Calabria (Carta Calabrese del Paesaggio) sottoscritta il 22/6/2006; • D. Lgs. 42/04 e sue successive modifiche e integrazioni; • Legge Urbanistica regionale n°19/2002 e sue successive modifiche e integrazioni; • Linee Guida Regionali approvate con Delibera Consiglio Regionale n.106 del 22/6/2006, e successive modifiche ed integrazioni; • Direttiva 42/2001/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 2. CONTENUTI ED ELABORATI DEL PTCP Il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale è composto dai seguenti elaborati: • Presentazione • Quadro conoscitivo – relazione Allegati al quadro conoscitivo: - studi preliminari sul sistema socio-economico - studi preliminari sul sistema naturalistico - studi preliminari sul sistema agro-forestale - studi preliminari sul sistema infrastrutturale (servizi a rete) • Progetto di piano - relazione • Quadro conoscitivo – cartografie • Progetto di piano – cartografie • Indirizzi per l’attuazione del PTCP e la redazione dei PSC e dei PSA • Rapporto ambientale ai sensi della Direttiva 42/2001/CE 3 3. CRITERI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE Il territorio della Provincia di Cosenza, esteso circa 6.650 Km 2, rappresenta il 44,1% del territorio regionale, ed -

Cosenza-Unical: in Treno in 15 Minuti
COSENZA-UNICAL: IN TRENO IN 15 MINUTI La discussione a proposito del collegamento tra Cosenza ed il suo polo universitario continua ad animare gli animi da ormai diverso tempo. Le proposte sono numerose, come numerose e diverse tra loro le esigenze e le richieste delle diverse utenze. Da un lato vi è il collegamento tramviario, impostato in larga parte lungo lungo Viale Parco, senz’altro utile per il movimento interno all’area metropolitana Cosenza-Rende ma obiettivamente lento e, proprio grazie al suo attraversamento lungo l’importante arteria cittadina, oggetto sia di stravolgimento per un caratteristico spazio urbano che di una…notevole ipocrisia, dato che si andrebbe praticamente a rimettere i binari laddove c’erano già!1. Una forte richiesta di un collegamento veloce con l’Unical proviene invece dai centri dell’entroterra, ed in particolare dell’area del Savuto. E’ ragguardevole il movimento di persone dai comuni serviti dalla ferrovia Cosenza – Marzi verso l’Università, già oggi attestato, prendendo in considerazione il solo vettore ferroviario, a circa 120 persone al giorno2, un dato visibilmente compromesso da numerosi disagi come la mancanza dell’integrazione tariffaria ed il funzionamento “a metà” delle coincidenze dei treni con le navette da/per l’Unical. In questo dato inoltre non sono compresi tutti quegli studenti che percorrono la tratta al lunedì ed al venerdì, vivendo nel resto della settimana in affitto a Cosenza per contrastare i disagi dell’attuale sistema di trasporto, necessità che causa ingenti spese aggiuntive -

Social Work with Families and Children in Europe and in the United States
Program of the seminar Social Work with Families and Children in Europe and in the United States Arcavacata Campus University of Calabria Arcavacata di Rende (CS), Italy. May 9 - 13, 2011 Seminar Description The two previous editions of the Italo-American seminar took place at the headquarters of Loyola Chicago University in Rome where social work teachers and students from Loyola and some Italian universities gathered to study and discuss about migration (2009) and aging society (2010). This 2011 seminar offers an exploration into some of the main issues related with contemporary social work with families and children. This exploration is grounded in an understanding of the major transformation in some European (Italy, Switzerland and Czech Republic) and American societies, the trends in welfare policy, and the social work responses both in Europe and the United States. This seminar addresses the practice of social work as it applies to the concrete dilemmas posed by families and children and provides a comparative view of both nations. Seminar Location The University of Calabria, situated in Southern Italy (in Calabria near the town of Cosenza, about 500 km South of Rome), is a public institution established in 1972. The University of Calabria is a medium-sized university with about 36,000 students. Since its very beginning the University of Calabria has clearly set out the strategies for the development of its international dimension. In the past twenty years several bilateral agreements were established by the University of Calabria with European and other foreign universities. Such agreements aim at encouraging cooperation in the fields of research and didactic activities. -

Attitude Towards Bike Use in Rende, a Small Town in South Italy
sustainability Article Attitude towards Bike Use in Rende, a Small Town in South Italy Demetrio Carmine Festa and Carmen Forciniti * Department of Civil Engineering, University of Calabria, 87036 Rende, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected] Received: 16 April 2019; Accepted: 9 May 2019; Published: 13 May 2019 Abstract: The bike can contribute to the development of sustainable mobility. This requires interventions to promote bike use, such as increasing the cyclist safety, construction of bikeways, and provision of ancillary services and bike sharing activities. In the literature many studies focus on bike use and agree with the application of such interventions. However, these studies are often related to specific urban areas that are very different; the transferability of results and models has not been adequately analyzed. This work investigates the attitudes towards cycling in Rende, a small town in Southern Italy. The aim is to determine in what conditions the users would be willing to use bicycles in relation to the trip purpose, the presence or absence of cycle paths, and the availability of bike sharing services. Different factors, such as age, gender, and occupation, are taken into account. The results show that the bike use could be incentivized by enlarging the existent bike network, adopting bike sharing systems, and promoting specific policies oriented to sustainable transport modes. Furthermore, two aspects emerged from the analysis: the importance of studying the propensity to use bikes by different groups of users and the importance of focusing interventions on market segments with greater willingness to bike. Keywords: bicycle; sustainable mobility; bike user; bikeways 1. -

Riferimenti Logistici
Polo di Innovazione per l’Edilizia Sostenibile RIFERIMENTI LOGISTICI Green HoMe scarl c/o Università della Calabria – DIATIC, Via Pietro Bucci 8C 87036 Rende CS Italy P.IVA 03598080780 Email [email protected] PEC [email protected] Web www.greenhomescarl.it Polo di Innovazione per l’Edilizia Sostenibile Sommario LA SEDE DEL POLO GREEN HOME 3 COME ARRIVARE IN AEREO 3 Aeroporto e voli 3 Collegamenti Aeroporto Lamezia – Cosenza 3 Navette Aeroporto 3 Pullman di linea Lamezia - Cosenza 4 Treno Aeroporto - Cosenza 4 COME ARRIVARE IN TRENO 5 COME ARRIVARE IN PULLMAN 5 DOVE PERNOTTARE 6 Hotel 6 Residenza Socrates 6 PER MUOVERSI A COSENZA – RENDE 7 MAPPA DEL CAMPUS UNICAL 8 Green HoMe scarl c/o Università della Calabria – DIATIC, Via Pietro Bucci 8C 87036 Rende CS Italy P.IVA 03598080780 Email [email protected] PEC [email protected] Web www.greenhomescarl.it Polo di Innovazione per l’Edilizia Sostenibile La sede del Polo Green HoMe La sede di Green HoMe – Polo di Innovazione per l’Edilizia Sostenibile è ubicata all’interno del Campus dell’Università della Calabria, nella palazzina del cubo 8C di fronte al Centro Congressi Aula Magna “Beniamino Andreatta”. Green HoMe scarl c/o Università della Calabria – DIATIC, Via Pietro Bucci 8C, 87036 Rende CS Come arrivare in aereo Aeroporto e voli L’aeroporto di Lamezia Terme (CZ) si trova a 70 Km da Cosenza e dispone di collegamenti ferroviari, pullman, taxi-navetta e taxi privati con tempi di percorrenza fra 40’ e 60’. L’aeroporto di Lamezia Terme (CZ) è collegato con le principali destinazioni nazionali ed estere con voli diretti (Bologna, Bergamo/Milano, Pisa, Bruxelles, Londra) o con scalo a Roma. -

Affidatario: SC a Rl "CONSORZIO AUTOLINEE DUE"
Affidatario: S.C. a r.l. "CONSORZIO AUTOLINEE DUE" Esercente: CONSORZIO AUTOLINEE S.r.L. LINEA N. 136: COSENZA (Autostazione) - RENDE (Roges, Commenda, Quattromiglia, Arcavacata, S. Stefano, Contrada Dattoli, Contrada Rocchi) con diramazione per Rende (UNICAL, Terminal, Dipartimento Ingegneria) Percorsi: "ar"; "br"; "cr"; "fr"; "gr"; "jr"; "kr"; e "lr" CORSE DI RITORNO N°Corsa 209 2010 20187 2011 2037 20182 2081 2038 2039 2012 2040 20183 2013 2042 2043 2044 2014 20184 2045 2015 2046 2047 20185 2048 2016 20186 2049 2050 2072 2075 Periodo A A A A UNIV A SCO UNIV UNIV A UNIV A A UNIV UNIV UNIV A UNIV UNIV A UNIV UNIV UNIV UNIV A UNIV UNIV UNIV A UNIV FERMATE Cadenza FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 fer6 FER6 Percorso ar ar gr ar br fr cr br br ar br fr ar br br kr ar fr br ar br br fr br ar fr br br jr lr Km Tot 13,204 13,204 19,541 13,204 9,440 18,631 7,315 9,440 9,440 13,204 9,440 18,631 13,204 9,440 9,440 9,854 13,204 18,631 9,440 13,204 9,440 9,440 18,631 9,440 13,204 18,631 9,440 9,440 6,336 2,880 RENDE (Contrada Rocchi via V. De Gama) - - 07:10 - - 09:10 - - - - - 11:40 - - - - - 14:10 - - - - 16:30 - - 18:30 - - - - RENDE (Contrada Tufo n.c.152) - - 07:12 - - 09:12 - - - - - 11:42 - - - - - 14:12 - - - - 16:32 - - 18:32 - - - - RENDE (C.da Vermicelli-Via G.Cesare,4) - - 07:13 - - 09:13 - - - - - 11:43 - - - - - 14:13 - - - - 16:33 - - 18:33 - - - - RENDE(Arcavacata-Via Napoleone B. -

Travel & Accomodation Info
Cultural Heritage Matchmaking 2018 Università della Calabria, Rende (CS) 27 – 28 Settembre 2018 Travel & Accomodation info On-line registration and info on chm2018.b2match.io Info and coordination [email protected] info: Tel. +39 0984 839674 SPIN Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico srl Cultural Heritage Matchmaking 2018 Università della Calabria, Rende (CS) 27 – 28 Settembre 2018 Travel & Accomodation info How to get there: by plane Airports and flights Lamezia Terme (CZ ) International Airport is 70 Km from Cosenza and it is connected by trains, buses, taxi- shuttles and taxis, with journey times between 40 'and 60'. Lamezia Terme (CZ ) International Airport is connected to the main national and international destinations with direct flights or with a stopover in Rome. Many companies use in the airport (Alitalia, Ryanair, EasyJet, BlueAir, etc…). Info: lameziaairport.it Connections Lamezia Airport - Cosenza The main connections between the airport and Cosenza are by Taxi shuttle, Bus, Train. Taxi-shuttles This solution is the fastest and most convenient, at a reasonable cost (€ 20-25). Booking is required online or by phone. The normal operating conditions are as follows. TopClass taxi-shuttle. Service provided by “Top Class Agency”. The cost varies from € 21.50 to € 29.50 depending on the passengers. Info and online booking on www.topclassturismo.com (Phone 0984-846192) “Al Volo” taxi-shuttle. Service provided by AMACO, Ferrovie della Calabria and SaCal by using minibuses with 19 seats. Cost from € 20 to € 30 depending on the number of passengers. Bookin required at the link: www.al-volo.net or by phone ( 0984-8830894, Mon-Fri 8.30 – 18.00). -

Carta Dei Servizi Distretto "Velle Crati"
1 Carta dei Servizi (art. 32, c. 1 del d.lgs. 33/2013 Distretto Valle Crati Direttore: Dott. Achille Straticò 2 INDICE Presentazione ………………………………………………………………………… pag. 4-5 Dati Demografici……………………………………………………………………… pag. 6 - 7- 8 Organizzazione del Distretto…………………………………………………… pag. 9 - 10 URP ……………………………………………………………………………………….. pag. 11 Strutture Eroganti e Ambiti di erogazione………………………………. pag.12 – 13 - 14 Direzione- UOC Cure Primarie – UO Amministrativa ……………… pag.15 Assistenza Sanitaria Primaria…………………………………………………. pag. 16 – 17 - 18 Medicina di Base ……………………………………………………………………. pag. 19 – 20 -21 – 22 -23 -24 Ausili e Protesi ………………………………………………………………………… pag. 25 - 26 Medici di Medicina Generale e Pediatri………………………………….. pag.27 – 28-29 -30-31-32 Continuità Assistenziale – Guardia Medica ……………………………… pag. 33 - 34 – 35 PUA …………………………………………………………………………………………. pag . 36 – 37 UVM…………………………………………………………………………………………. pag.38 – 39 CDI (ADI)…………………………………………………………………………………… pag. 40 – 41 Specialistica Ambulatoriale Poliambulatorio Quattromiglia……………………………………………….. pag. 42 -43 – 44 – 45 Polo Sanitario Castrolibero……………………………………………………… pag. 46 Polo Sanitario di Bisignano………………………………………………………… pag.47 – 48 Poliambulatorio di Luzzi …………………………………………………………… pag.49 – 50 Poliambulatorio di Montalto Uffugo………………………………………… pag.51 – 52 Poliambulatorio di Acri e santa Sofia D’Epiro…………………………… pag. 53 -54 – Fisiatria ……………………………………………………………………………………. pag.55 - 56 Neurologia ad indir. Riabilitativo……………………………………………… pag. 57 Neuropsichiatria Infantile ………………………………………………………… -

IIEP Student Guide
ARRIVING TO UNICAL Upon arriving to UNICAL there are a series of things that students must bring with them and do in order to be fully registered along with obtaining housing. It is important to read and follow this carefully to minimize possible problems that a student may face. Below are listed locations and tasks separated in 2 days in chronological order that the student must follow to complete the housing process. However, note that it will take more than 2 days to complete the tasks below. 1. DATES OF ARRIVAL: Students are advised by the university to arrive around the third week of September. This is when the apartments for students usually are available. Please contact the Welcome Office to confirm a date ([email protected]). It is strongly recommended that students arrive on a week day as opposed to the weekend to guarantee that the offices are open. 2. LOCATIONS OF ARRIVAL: Students are advised to arrive to the nearest possible airport/ train station to UNICAL a. Plane: Lamezia Airport is the nearest airport to UNICAL (~45 miles from UNICAL) i. There is a shuttle bus (€1.50 if you buy a ticket at the edicola inside the airport or €2.50 on the bus) that will take you to the train station Lamezia Terme Centrale from the airport. From there you can take a train to Castiglione Cosentino, then a bus to the university. ii. There are busses that run directly from the airport to the university terminal. You can buy a ticket (€5-6) on the bus. -

Minimum Documentation Fiche 2015 Composed by Regional Working Party Of: Docomomo Italia /Campania, Italy
Minimum Documentation Fiche 2015 composed by regional working party of: Docomomo Italia /Campania, Italy 01. Picture of building Depicted item: University of Calabria source: (Rykwert, 1995) date: 1995 1. Identity of building 1.1 current name of building Università della Calabria (delle Calabrie) 1.2 variant or former name UniCal / Campus di Arcavacata 1.3 number & name of street 31c, via Pietro Bucci 1.4 town Rende (Quattromiglia), Cosenza 1.5 province/state Calabria 1.6 zip code 87036 1.7 country Italy 1.8 national grid reference 39° 21' 29.41'' N 16° 13' 32.17'' E 1.9 classification/typology University Campus 1.10 protection status & date None d o _ c o _ m o _ m o _ International working party for documentation and conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement 2 History of building 2.1 original brief/purpose University of Calabria is one of the most important Italian macro-structural constructions in the second half of the twentieth century. A “landscape architecture” at regional scale (3.6 Km) that, despite had numerous difficulties in execution, is an attempt to combine geography and architecture. This work, relevant for its size and design, is mainly representative design and theoretical research by Vittorio Gregotti one of the most important leaders and animators of the current Italian architectural debate. 2.2 dates: commission/completion Competition 1972 Commission 1973 Completion first phase 1979 2.3 architectural and other designers Team leader: Vittorio Gregotti Design Team: Vittorio Gregotti, Emilio Battisti, Hiromichi Matsui, Pierluigi Nicolin, Franco Purini, Carlo Rusconi Clerici, Bruno Viganò Whith: Spartaco Azzola, Vera Casanova, Cristina Castello, Rafaello Cecchi 2.4 others associated with building Lucio Gambi (geographer); Laris (urban design consultans); Giuseppe Grandori, Alfredo Castiglioni, Gilio Ballo, G. -

The University of Calabria ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE
The University of Calabria RENDE The most significant attraction for students from all over the Region and other parts of the world, is Anno Scolastico 2016 Vulcano Mirabelli;Rosy Ida Salerno, Francersco Veronica Schiavello, Phone Number: 0984443006/0984464161 Istituto Comprensivo Rende Centro Produced (Classe 2Bby: Scuola Secondaria 1 grado undoubtedly the University of Street Vanni 43, Calabria, in Arcavacata, one of - 2017 the largest University in the south of Italy. The University of Calabria, has brought the increasement of the population – domiciled in the territory; it is a Saporito di Rende) ISTITUTO COMPRENSIVO source of vitality for the trade, RENDE CENTRO construction, and service industries throughout the urban Scuola secondaria 1 grado Classe 2B area of Cosenza. The contribution in terms of cultural activities such Dirigente Scolastico as conferences, concerts, cinema, Maria Teresa Barbuscio literary debates, scientific Prof,sse Giuseppina Caputo exhibitions and so on, has also Domenica Federico raised considerably the quality of History The Castle Rende Acheruntia (the first name of Rende) was founded by the ancient Enotrii, from the Rende is a nice town placed. in the plain of St. Euphemia and Clampetia North-Western part of Calabria near (Amantea), near the river they called Cosenza. Acheron. Rende was later named Pandosia. This territory is crossed by the affluent rivers of Crati: Emoli, Surdo The place occupied by the Enotrii was and Campagnano. The old town is often attacked by enemies and poorly Name: The Norman Castle suited to defense, so some inhabitants placed on a hill at about 400 mt. Devoted to: The Byzantines above sea level.