Museiok30 Ultimo.QXD
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Codici E Documenti Dell'opera Dei Pupi Di Tradizione Catanese
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Dottorato di ricerca in Studi sul Patrimonio Culturale – XXIX Ciclo Simona Scattina Nella bottega della famiglia Napoli: codici e documenti dell’Opera dei pupi di tradizione catanese Tesi di Dottorato Tutor Chiar.ma Prof.ssa Stefania Rimini Coordinatore Chiar.ma Prof.ssa Grazia Pulvirenti 1 A Chiara e a Salvo e ai loro preziosi scatti 2 Indice Introduzione 5 Sul teatro di figura Capitolo 1 Premessa 9 Il teatro di figura in Italia 10 Il teatro di figura all’estero 18 Il teatro di figura e i suoi teorici 24 Marionette che passione! Tra seduzioni e testimonianze 32 Capitolo 2 Il teatro siciliano delle marionette 44 I capolavori del patrimonio immateriale 51 La compagnia La Marionettistica dei fratelli Napoli 53 Le ragioni del conservare: i fratelli Napoli 54 Il mestiere – I codici Capitolo 3 Il codice figurativo I cartelli del teatro dei pupi 60 I cartelli di tipo Palermitano 61 I cartelli di tipo Catanese 62 Aspetti formali e socio-culturali dell’arte popolare in Sicilia 68 Tipologia delle fonti iconografiche 71 Il repertorio e il rinnovamento del patrimonio figurativo 77 Gli influssi del teatro “popolare”: le maschere nell’Opera dei pupi 79 Iconografia teatrale 81 Gli influssi del teatro “colto”: codici gestuali e scenografie 82 Le storie dipinte: funzioni d’uso 84 «Noi Napoli ci dilettiamo di pittura» 86 Riscontri iconografici sui cartelli 88 Il Fondo Napoli 92 Bene vs male 93 La fede nei cartelli 97 Il tradimento 100 Malagigi 102 Gran serate 103 Un unicum 105 Cartelli censurati 106 3 Il verso 107 I cartelli -

Dal Cunto All'opera Dei Pupi
Titolo || Dal Cunto all’Opera dei Pupi Autore || Valentina Venturini Pubblicato || Valentina Venturini (a cura di), Dal Cunto all’Opera dei Pupi, Roma, Dino Audino editore, 2003, pp. 5-31 Diritti || © Tutti i diritti riservati. Numero pagine || pag 1 di 18 Lingua|| ITA DOI || Dal Cunto all’Opera dei Pupi di Valentina Venturini «E ora, signuri mei, ddocu a lassu, e n’autra vota va cuntu»... Lo spettacolo è finito, il puparo-cuntista lascia la scena, le luci si accendono ma gli occhi di molti restano immersi nel mondo meraviglia che l’attore ha saputo creare nelle loro menti. Ogni sera Mimmo Cuticchio racconta una storia, servendosi dei suoi pupi, di una spada di legno e di una camicia bianca; e ogni sera la fantasia dello spettatore si accende per ricreare i mondi della memoria, assecondando gli accenti del narratore, le sue parole spezzate in briciole di fuoco, le apparizioni sapientemente suscitate. Le storie variano di spettacolo in spettacolo, quello che non cambia è la linea sulla quale vive l’arte di Cuticchio, la sua traccia materiale fatta di pupi, di spade di legno, del battito del piede, dei silenzi e dei toni di voce. Sono gli strumenti tradizionali dei contastorie del Cunto1 e dei pupari, quelli che segnano le premure, gli appoggi e le sortite fra i quali viaggia Mimmo Cuticchio: non come passeggero da un’arte all’altra ma come nomade verso una terra nuova, quasi un paese, in cui vive e si concentra il suo teatro. Mimmo Cuticchio nasce da una famiglia di pupari di Palermo: il padre fu grande maestro di quest’arte; il nonno, che Mimmo definisce “più teatrinaro che oprante”, gestiva un teatrino di pupi occupandosi anche di reclutare gli opranti, ossia i manovratori e i recitanti; la madre realizza ancora i costumi dei pupi, i sipari, i fondini e dipinge scene e cartelli. -

The Antonio Pasqualino International Puppet Museum Rosario Perricone
The Antonio Pasqualino International Puppet Museum Rosario Perricone The opening of the Antonio Pasqualino International Puppet Museum follows the establishment of the Association for the Conservation of Folk Traditions in 1965, the congress “Museografia e folklore”, organized in Palermo in 1967, and the enthusiastic collecting of some highbrows. Its history is deeply linked to its founder Antonio Pasqualino, who was a surgeon and an appreciated anthropologist expert of the history and culture of Sicily. He dedicated his researches to a theatrical form that, in the second half of the 20th century, seemed to be inexorably disappearing: Sicilian puppet theater – the Opera dei pupi. These enthusiastic researches led Antonio Pasqualino and some scholars to establish the Association for the Conservation of Folk Traditions with the primary goal of avoiding the disappearance of the Opera dei pupi – that was a real paradigm of the social universe of the Sicilian people –, and safeguarding and promoting folk traditions. The initial focus of the collection – and the Association’s researches that would lead to the Museum foundation in 1975 – concerned Sicilian marionettes, the pupi (pup- pets). In those years, the decisive action of collecting and conserving objects that seemed to have lost life on stage as well as an audience, was associated to the encouragement of Sicilian puppeteers, the pupari, and to an intense supportive action aimed to help with gradual reintegration and promotion of the shows toward a new audience, different from the traditional one. These actions created a deep understanding between research- ers, the pupari, and the few groups from the traditional audience that had survived the crisis of 1960s and thus were prized witnesses of the values of the past. -

The University of Chicago the Art of Indeterminacy in The
THE UNIVERSITY OF CHICAGO THE ART OF INDETERMINACY IN THE PROSE WORKS OF GOLIARDA SAPIENZA A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE DIVISION OF THE HUMANITIES IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF ROMANCE LANGUAGES AND LITERATURES BY ELANA STEPHENSON KRANZ CHICAGO, ILLINOIS DECEMBER 2016 COPYRIGHT 2016 ELANA STEPHENSON KRANZ For my family TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS ........................................................................................................... v INTRODUCTION .................................................................................................................................... 1 CHAPTER ONE SAPIENZA’S CICLO AUTOBIOGRAFICO: MULTIPLE, RELATIONAL AND FUSED/FUSING SELVES ................................................................. 14 CHAPTER TWO THE INFLUENCE OF THEATER IN SAPIENZA’S PROSE WORKS..................................................... 52 CHAPTER THREE CONFINEMENT AS LIBERATION: FEMALE SPACES IN SAPIENZA’S PROSE WORKS ................ 88 CHAPTER FOUR NARRATING TRANSGRESSION; OR, WHY MODESTA KILLS ....................................................... 125 CONCLUSION .................................................................................................................................... 164 BIBLIOGRAPHY ............................................................................................................................... 170 iv ACKNOWLEDGEMENTS First and foremost, I would like to thank my dissertation director, Rebecca West. -

Sicilian Puppet Theater
Sicilian puppet theater Jo Ann Cavallo (Columbia University ) Places: Italy. The Sicilian Opera dei pupi is a form of prose theater that dramatizes primarily chivalric narratives using large wooden puppets with full armor, swords, and shields. The puppets weigh an average of twenty-two pounds in the Palermo tradition and sixty-five pounds in the Catanese tradition, and they are manipulated from above by means of iron rods. These characteristics distinguish the Opera dei pupi from other forms of teatro di figura traditionally practiced in Italy, such as the marionette, light-weight puppets supported by strings, and the burattini, or hand-puppets, both of which present varied, primarily comic, stories outside the context of chivalry. Puppet theater can be found throughout the world from Northern Europe to Indonesia and is attested to in Sicily since the fourth century B.C.E. (Xenophon, Symposium). The concrete origins of the Opera dei pupi tradition, however, are a matter of speculation due to scanty documentation prior to the early nineteenth century. Readers of Cervantes’ Don Quixote may remember how the ill-fated knight mistook puppet theater for reality and attempted to save the puppet Melisenda from the Moors. Whether or not the Italian Opera dei pupi came from Spain (or from Naples, as some sources indicate), it is documented on the island in the early 1800s. Sicilian puppeteers appear to have transformed the art form by creating puppets dressed in decorative metallic armor and capable of intricate movements. Although it was also successful elsewhere, in particular Rome, Naples, and Modena, the Opera dei pupi achieved its greatest popularity in Sicily during the course of the nineteenth century. -

Opera Dei Pupi
OPEORPAER AD DEEII PPUUPIPI Mallorie Francis TEACHER'S RESOURCE GUIDE Shadows, Strings and Other Things Mallorie Francis Mallorie Francis OBJECTIVE The objective of this teaching guide is to provide educators with the opportunity and resources necessary to explore the tradition of Sicilian marionette theatre. Through the use of text, visuals, activities, and discussions, students will be able to learn about the history, content, and cultural context of the Opera dei pupi. Students will also gain a better understanding not only of puppet theatre and its role in Sicilian culture, but of global cultural heritage and the ways in which we interact with art and storytelling. Goals: Learn about Sicilian culture through traditional puppet theatre Understand the importance of family, tradition, and cultural heritage Experiment with storytelling and visual art to explore core themes and perspectives INTRODUCTION The Opera dei pupi is a traditional form of marionette theatre from the island of Sicily. Combining romantic tales and grand adventures, it uses large, handcrafted puppets to enact a selection of medieval and Renaissance epics. Many of the characters are knights, adorned in decorative armour and designed with articulated limbs that allow for such intricate movements as jumping on a horse or drawing a sword. Additional characters include kings, ladies, and civilians, as well as a number of animals and supernatural creatures. Although this tradition was once more widespread, today there are two distinct practices in Catania and Palermo. Pupi performances are characterised by their foundation in traditional themes and codes of conduct, including honour, chivalry, and the preservation of faith and justice. -

A Sealion's Tale May 2021 Issue LVI(56) CONTENTS
A Sealion's Tale May 2021 Issue LVI(56) CONTENTS : Front Cover: Hortus Del i ci arum dating 1167-1185 Artist: Harrad Landsberg. Alsatian nun and abbess of Hohenburg Abbey in the Vosges mountains. She was known as the author of the pictorial encyclopedia Ho rtus del i ci arum (The Garden of Delights). Lo cati o n: Hohenburg Abbey, France https://www.numistral.fr/ark:/12148/bpt6k9400936h/f9.image This Page: Shakespeare's Gobal Theater https://haleighshakespeare.weebly.com/the-globe-theater.html Page 3. A Letter From the Coronets Page 4. A Letter From the S eneschal Page 5. A Letter From the Chroni cl er Page 6 . Gl eann Abhann's Cal endar Page 7. Barony of S el eone's Cal endar Page 8 . Meeting Places Page 9 . Terracotta jointed "doll" Page 1 0 -11. Punch and Judy Page1 2 -13. History of Marionettes, Sicilian Puppet Th eatre – Opera Dei Pupi Page 1 4 -16. Phun Page, Make Your Own Theater and Puppets Page 1 7 . Recipe of the Month, Sicilian Chicken Page 1 8 -21. Baronial Officers for S el eone and Position Responsibilities. Page 22. Publication Information A Letter form the Coronets Wow! Can you believe it is May already. It has been a year since we were told no more activities. Well so be it. That was the past this is the now. Now we are looking forward to events and gatherings again. We still have restrictions but if we wish to gather and see each other those are things we will have to do. -

Ulysses's Journey and Homer's Odyssey
Ulysses’s Journey and Homer’s Odyssey: An Eternal Return MARTINA TREU Abstract Homer’s Odyssey provides a perfect case for showing the eternal return of the Greek myths in contemporary literature, and culture: tales of Ulysses’s journeys have always been popular, till nowadays. He is the only survivor of an entire crew: he safely arrived home alone, and soon left, heading for a new journey. Today, in a way, he keeps coming back, on and on: in all sort of books, in fine arts, inside and outside theatres. Ulysses and his myth are also “surfing the web”, as I proved with a recent survey on the use of the terms ‘Odyssey’, ‘Odysseus’, and ‘Ulysses’, on the Internet. Moreover, the last decades recorded, all over the world, an increasing amount of modern versions of Odyssey, and related myths. I focus particularly on the most recent translations and adaptations for the stage: many of them are dedicated to those who did not come back home – unlike Ulysses – or did not survive at all. In 2010, for instance, the Italian playwright and director Marco Martinelli wrote Rumore di Acque (“Noise in the Waters”), a play later translated into English, French, German, and other languages. Ulysses’s myth and its happy end are reversed, in his antiheroic Odyssey, inspired by the tragic death of immigrants, in the shipwreck of their boats, while they try to reach Southern Italy and Sicily. The play was staged in Lampedusa – the island on Italy’s Southern border where many ships land, and countless corpses are found – and it is still on tour in Europe, Africa, and U.S. -

Sicily (Sicilia)
Sicily (Sicilia) General Sicily (Italian: Sicilia) is an autonomous region of Italy, in Southern Italy along with surrounding minor islands, officially referred to as Regione Siciliana. Sicily is located in the central Mediterranean Sea, south of the Italian Peninsula, from which it is separated by the narrow Strait of Messina. Its most prominent landmark is Mount Etna, the tallest active volcano in Europe, and one of the most active in the world, currently 3,329 m (10,922 ft.) high. The island has a typical Mediterranean climate. Administrative Divisions Administratively, Sicily is divided into 9 administrative provinces, each with a capital city of the same name as the province. The areas and populations of these provinces are: Province of Agrigento ......................................... 3,042 km2 ....... pop. 453,594 Province of Caltanissetta .................................... 2,128 km2 ....... pop. 271,168 Province of Catania ............................................ 3,552 km2 .... pop. 1,090,620 Province of Enna ................................................ 2,562 km2 ....... pop. 172,159 Province of Messina ........................................... 3,247 km2 ....... pop. 652,742 Province of Palermo ........................................... 4,992 km2 .... pop. 1,249,744 Province of Ragusa ............................................ 1,614 km2 ....... pop. 318,980 Province of Siracusa ........................................... 2,109 km2 ....... pop. 403,559 Province of Trapani ............................................. 2,460 km2 ....... pop. 436,240 The City of Palermo is the Capital City of the region Small surrounding islands are also part of various Sicilian provinces: Aeolian Islands (Messina), The isle of Ustica (Palermo), Aegadian Islands (Trapani), The isle of Pantelleria (Trapani) and Pelagian Islands (Agrigento). Geography Sicily is the largest island in the Mediterranean Sea. It has a roughly triangular shape, earning it the name Trinacria. -

Puppet Theatre in Italy John Mccormick
MÓIN-MÓIN 53 Puppet theatre in Italy John McCormick Many puppet traditions can be traced back to Italy. For geographical, social, historical and political reasons Italy includes some of the poorest regions of Europe. Emigration has always been endemic. Amongst those leaving Italy, whether on a seasonal or more permanent basis, were de Estudos sobreRevista T entertainers. The actors of the Commedia dell’Arte found they could earn more money abroad, whether in France, Spain, England, the German states or even Russia. Some of these brought puppets with them. By the mid seventeenth century puppet showmen with their companies were travelling with marionette performances and these were often called after the main figure, Pulcinella. Glove puppet players belonged more to the ranks of street entertainers, and travelled with a rudimentary stage and a few puppets. The most famous of these was Giovanni Piccini of Piacenza, who probably reached England around 1780 and became the “father” of the English Ani Formas de eatro Punch and Judy show. By the nineteenth century, showmen were crossing the Atlantic Ocean with increasing frequency, particularly visiting South America. In Classical times there are plenty of references to show that puppets were familiar to people in Italy. It is highly likely that medieval clerics used marionettes as a means of teaching the scriptures, but that, like the mystery plays, these passed rapidly into the hands of popular entertainers and soon madas became secularised. There is also evidence of simple street glove-puppet shows. Until unification in 1861, Italy was a series of states, most ruled or MÓIN-MÓIN 54 controlled by different foreign powers, and even the development of a single Italian language spoken by the entire population is a comparatively recent phenomenon. -

Dal Cunto All'opera Dei Pupi. Il Teatro Di Cuticchio Introduzione Valentina
Valentina Venturini (a cura di) Dal Cunto all’Opera dei pupi. Il teatro di Cuticchio ROMA, DINO AUDINO EDITORE, 2003, PP. 144, EURO 14, 00 Introduzione Valentina Venturini Dal Cunto all’Opera dei pupi «E ora, signuri mei, ddocu a lassu, e n’autra vota va cuntu»... Lo spettacolo è finito, il puparo-cuntista lascia la scena, le luci si accendono ma gli occhi di molti restano immersi nel mondo meraviglia che l’attore ha saputo creare nelle loro menti. Ogni sera Mimmo Cuticchio racconta una storia, servendosi dei suoi pupi, di una spada di legno e di una camicia bianca; e ogni sera la fantasia dello spettatore si accende per ricreare i mondi della memoria, assecondando gli accenti del narratore, le sue parole spezzate in briciole di fuoco, le apparizioni sapientemente suscitate. Le storie variano di spettacolo in spettacolo, quello che non cambia è la linea sulla quale vive l’arte di Cuticchio, la sua traccia materiale fatta di pupi, di spade di legno, del battito del piede, dei silenzi e dei toni di voce. Sono gli strumenti tradizionali dei contastorie del Cunto1 e dei pupari, quelli che segnano le premure, gli appoggi e le sortite fra i quali viaggia Mimmo Cuticchio: non come passeggero da un’arte all’altra ma come nomade verso una terra nuova, quasi un paese, in cui vive e si concentra il suo teatro. Mimmo Cuticchio nasce da una famiglia di pupari di Palermo: il padre fu grande maestro di quest’arte; il nonno, che Mimmo definisce “più teatrinaro che oprante”, gestiva un teatrino di pupi occupandosi anche di reclutare gli opranti, ossia i manovratori e i recitanti; la madre realizza ancora i costumi dei pupi, i sipari, i fondini e dipinge scene e cartelli. -
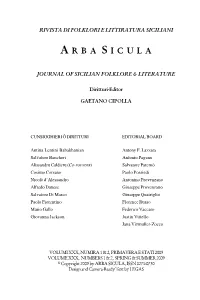
A R B a S I C U L A
RIVISTA DI FOLKLORI E LITTIRATURA SICILIANI A R B A S I C U L A JOURNAL OF SICILIAN FOLKLORE & LITERATURE Diritturi-Editor GAETANO CIPOLLA CUNSIGGHIERI Ô DIRITTURI EDITORIAL BOARD Antina Lentini Babakhanian Antony F. Lazzara Salvatore Bancheri Antonio Pagano Alissandru Caldieru (CO-FOUNDER) Salvatore Paternò Cosimo Corsano Paolo Possiedi Nicolò d’Alessandro Antonino Provenzano Alfredo Danese Giuseppe Provenzano Salvatore Di Marco Giuseppe Quatriglio Paolo Fiorentino Florence Russo Mario Gallo Federico Vaccaro Giovanna Jackson Justin Vitiello Jana Vizmuller-Zocco VOLUMI XXX, NUMIRA 1 & 2, PRIMAVERA E STATI 2009 VOLUME XXX, NUMBERS 1 & 2, SPRING & SUMMER 2009 © Copyright 2009 by ARBA SICULA, ISSN 0271-0730 Design and Camera-Ready Text by LEGAS ARBA SICULA è l’organu ufficiali dâ società siculu-americana dû stissu nomi ca si proponi comu obbiettivu principali di prisirvari, studiari, e promoviri a lingua e a cultura siciliani. ARBA SICULA è normalmenti pubblicata dui voti l’annu, ntâ primavera e nta l’autunnu. Pi comunicari direttamenti cû diritturi, pi mannari materiali pâ rivista, pi l’abbunamenti e pi informazioni supra a nostra società, scriviti a Gaetano Cipolla, Languages and Literatures Department, St. John’s University, 8000 Utopia Pkwy, Queens, NY 11439. I materiali ricevuti non si restituisciunu si nun si manna puru na busta affrancata cû nomu e indirizzu. ABBUNAMENTI Cu si abbona a la rivista, diventa automaticamenti sociu di Arba Sicula. Cu n’abbunamentu annuali i soci ricivunu du nummira di Arba Sicula (unu, si pubblicamu un numiru doppiu) e dui di Sicilia Parra. Arba Sicula è na organizzazioni senza scopu di lucru. Abbunamenti fora dî Stati Uniti $40.00 Abbunamentu regolari $35.00 Anziani e studenti $30.00 ARBA SICULA is the official journal of the Sicilian-American organization by the same name whose principal objective is to preserve, study, and promote the language and culture of Sicily.