Federico Zeri
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Animal Life in Italian Painting
UC-NRLF III' m\ B 3 S7M 7bS THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESENTED BY PROF. CHARLES A. KOFOID AND MRS. PRUDENCE W. KOFOID ANIMAL LIFE IN ITALIAN PAINTING THt VISION OF ST EUSTACE Naiionai. GaM-KUV ANIMAL LIFE IN ITALIAN PAINTING BY WILLIAM NORTON HOWE, M.A. LONDON GEORGE ALLEN & COMPANY, LTD. 44 & 45 RATHBONE PLACE 1912 [All rights reserved] Printed by Ballantvne, Hanson 6* Co. At the Ballantyne Press, Edinburgh / VX-/ e3/^ H67 To ©. H. PREFACE I OWE to Mr. Bernhard Berenson the suggestion which led me to make the notes which are the foundation of this book. In the chapter on the Rudiments of Connoisseurship in the second series of his Study and Criticism of Italian Art, after speaking of the characteristic features in the painting of human beings by which authorship " may be determined, he says : We turn to the animals that the painters, of the Renaissance habitually intro- duced into pictures, the horse, the ox, the ass, and more rarely birds. They need not long detain us, because in questions of detail all that we have found to apply to the human figure can easily be made to apply by the reader to the various animals. I must, however, remind him that animals were rarely petted and therefore rarely observed in the Renaissance. Vasari, for instance, gets into a fury of contempt when describing Sodoma's devotion to pet birds and horses." Having from my schooldays been accustomed to keep animals and birds, to sketch them and to look vii ANIMAL LIFE IN ITALIAN PAINTING for them in painting, I had a general recollection which would not quite square with the statement that they were rarely petted and therefore rarely observed in the Renaissance. -

Peripheral Packwater Or Innovative Upland? Patterns of Franciscan Patronage in Renaissance Perugia, C.1390 - 1527
RADAR Research Archive and Digital Asset Repository Peripheral backwater or innovative upland?: patterns of Franciscan patronage in renaissance Perugia, c. 1390 - 1527 Beverley N. Lyle (2008) https://radar.brookes.ac.uk/radar/items/e2e5200e-c292-437d-a5d9-86d8ca901ae7/1/ Copyright © and Moral Rights for this thesis are retained by the author and/or other copyright owners. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the copyright holder(s). The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. When referring to this work, the full bibliographic details must be given as follows: Lyle, B N (2008) Peripheral backwater or innovative upland?: patterns of Franciscan patronage in renaissance Perugia, c. 1390 - 1527 PhD, Oxford Brookes University WWW.BROOKES.AC.UK/GO/RADAR Peripheral packwater or innovative upland? Patterns of Franciscan Patronage in Renaissance Perugia, c.1390 - 1527 Beverley Nicola Lyle Oxford Brookes University This work is submitted in partial fulfilment of the requirelnents of Oxford Brookes University for the degree of Doctor of Philosophy. September 2008 1 CONTENTS Abstract 3 Acknowledgements 5 Preface 6 Chapter I: Introduction 8 Chapter 2: The Dominance of Foreign Artists (1390-c.1460) 40 Chapter 3: The Emergence of the Local School (c.1450-c.1480) 88 Chapter 4: The Supremacy of Local Painters (c.1475-c.1500) 144 Chapter 5: The Perugino Effect (1500-c.1527) 197 Chapter 6: Conclusion 245 Bibliography 256 Appendix I: i) List of Illustrations 275 ii) Illustrations 278 Appendix 2: Transcribed Documents 353 2 Abstract In 1400, Perugia had little home-grown artistic talent and relied upon foreign painters to provide its major altarpieces. -

Pietro Scarpellini
©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte PIETRO SCARPELLINI NOTE SULLA PITTURA DEL RINASCIMENTO NELLA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA (A PROPOSITO DI UN RECENTE CA T ALOGO) Il secondo volume del catalogo scientifico della Galleria con le effigi tradizionali di Tommaso Parentucelli da Sar Nazionale dell'Umbria a Perugia (F. SANTI, Galleria Na zana, eletto papa il 6 marzo 1447, col nome appunto di zionale dell' Umbria. Dipinti, sculture, oggetti dei secoli XV, Niccolò V.3) Di qui un terminus post quem per l'esecuzione XVI, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1985) del complesso che viene a collocarlo nel pieno dell'attività si apre con la scheda relativa al PoI ittico dei Domenicani romana, tra il 1447 ed il 1448, coinvolgendo nei tempi la del Beato Angelico in cui molto giustamente il Santi rico stessa affrescatura della Cappella Nicolina.4) nosce una quasi totale autografia, estesa anche a gran Ora tali ingegnose osservazioni lasciano però il margine parte della predella. Nessun dubbio difatti che ci si trovi a più di un dubbio. Per esempio, io credo che il Santi dinanzi ad una delle opere più belle del grande pittore, abbia ragione quando afferma, assieme con lo Zampetti, ove la qualità non scade mai o quasi mai, ed il cui ruolo che echi del lavoro dell' Angelico si avvertono già molto nelle vicende dell' arte umbra quattrocentesca è stato in evidenti tanto nella tavola principale quanto nella pre passato alquanto sottovalutato. Vorrei in proposito innan della della 'Madonna del Pergolato', opera di -

Francesco Caglioti and Andrea De Marchi)
INDEX 1) Press release 2) Fact Sheet 3) Photo Sheet 4) Introduction to the exhibition sections from the catalogue entries (Francesco Caglioti and Andrea De Marchi) 5) Introduction to the exhibition by Fondazione Palazzo Strozzi Director General, Arturo Galansino and Director of the Musei del Bargello, Paola D’Agostino 6) Introduction to the catalogue by exhibition curators Francesco Caglioti and Andrea De Marchi A CLOSER LOOK a) A new Leonardo: Virgin with the Laughing Child b) Important works of art restored expressly for the exhibition c) Fuorimostra for Verrocchio, Master of Leonardo (with maps) d) Andrea del Verrocchio timeline e) Andrea del Verrocchio’s artistic genealogy 7) Activities in the exhibition and beyond 8) List of the works PRESS RELEASE Verrocchio, Master of Leonardo A major exhibition celebrating Andrea del Verrocchio and his most famous pupil, Leonardo da Vinci, curated by Francesco Caglioti and Andrea De Marchi Palazzo Strozzi, 9 March – 14 July 2019 Promoted and organised by the Fondazione Palazzo Strozzi and Musei del Bargello in collaboration with the National Gallery of Art, Washington DC www.palazostrozzi.org #Verrocchio @palazzostrozzi The first comprehensive retrospective devoted to Andrea del Verrocchio (1435‐1488) will open in Florence this Spring at the Palazzo Strozzi, with an accompanying presentation at the Museo Nazionale del Bargello. Verrocchio, Master of Leonardo will bring together masterpieces by Verrocchio from collections around the world, contextualised by works from his forefathers and peers, as well as by the pupils he worked intensively with, including Leonardo da Vinci, Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio and Sandro Botticelli. The exhibition will demonstrate Verrocchio's remarkable creativity as a solo artist, illustrating his workshop as a crucial place of collaboration, exchange and co-working, where the language and the style of Renaissance art in Florence was forged. -
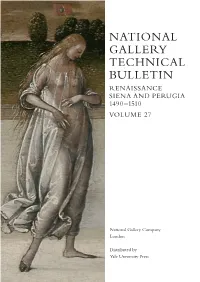
Working with Perugino: the Technique of an Annunciation Attributed to Giannicola Di Paolo
NATIONAL GALLERY TECHNICAL BULLETIN RENAISSANCE SIENA AND PERUGIA 1490–1510 VOLUME 27 National Gallery Company London Distributed by Yale University Press This volume of the Technical Bulletin has been funded by the American Friends of the National Gallery, London with a generous donation from Mrs Charles Wrightsman. ‘The Master of the Story of Griselda and Paintings for Sienese Palaces’ is published with the additional generous support of The Samuel H. Kress Foundation. Series editor Ashok Roy Photographic credits All photographs reproduced in this Bulletin are © The National Gallery, London, unless credited otherwise below. © National Gallery Company Limited 2006 BALTIMORE MD.Walters Art Gallery: p. 23, pl. 25; p. 51, pl. 70; p. All rights reserved. No part of this publication may be 53, pl. 74; p. 56, pl. 77. transmitted in any form or by any means, electronic or BLOOMINGTON IN. Indiana University mechanical, including photocopy, recording, or any Art Museum. Photo Michael Cavanagh and Kevin Montague: p. 22, information storage and retrieval system, without the pl. 23; p. 54, pls. 75, 76; p. 55, figs. 38, 39. BORDEAUX. Musée des prior permission in writing of the publisher. Beaux-Arts, photo Lysiane Gauthier: p. 106, pl. 9. BUDAPEST. Szépmüvészéti Muzeum. Photo: András Rázsó: p. 21, pl. 22; p. 57, pl. 2006 First published in Great Britain in by 78; p. 59, pl. 82. FANO. Chiesa di Santa Maria Nuova © 1997. Photo National Gallery Company Limited Scala, Florence: p. 102, pl. 5. FLORENCE. Galleria dell’ Accademia. St Vincent House, 30 Orange Street Courtesy of the Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro, London wc2h 7hh Florence: p. -

Rinascimento Italiano in DVD This Publication Is Supervised and Commented by Antonio Paolucci, Director of the Vatican Museums
8000 Images, 500 Artists ARinascimento DVD collection of the Italian Renaissance masterpieces inItaliano the highest definition available Archivage des images numériques de la peinture de la Renaissance Italienne Archivio digitale dei dipinti del Rinascimento Italiano in DVD This publication is supervised and commented by Antonio Paolucci, Director of the Vatican Museums. Rinascimento Italiano “The publication of this digital archive marks a change in the study of the history of renaissance art.” « La publication de cet archivage numérique va faire évoluer l’étude de la Renaissance italienne. » « La pubblicazione di questo archivio digitale segna una tappa importante per lo studio del Rinascimento italiano. » Scala in Florence, with its 50-year history and the biggest printed art archive in Italy, has put all its energy into creating this digital art archive, published around the world simultaneously in four languages: English, French, Italian and Japanese. From the second half of the thirteenth century through to the early seventeenth century, 506 artists took an active part in what is widely termed the Italian Renaissance. Their main art works here contain 8000 art pieces in all, which displayed with a maximum of 10,000 by 7,500 pixels (more than 20 times the resolution of high vision) represent the absolutely highest definition that can be seen. It is as if everything appears right there before your eyes. You can see such detail that even the touches of the brush strokes are visible. Les images apparaissent saisissantes comme si vous étiez devant l’original. Vous pouvez apprécier des détails comme les coups de pinceaux de l’artiste. -
Perugia TOURIST GUIDE PERUGIA
umbria TOURIST GUIDE THE GREEN HEART OF ITALY Comune di Perugia Turismo PERUGIA TOURIST INFORMATION AND ASSISTANCE OFFICES IN UMBRIA IAT di Perugia IAT di Gubbio (Municipalities of Perugia, Corciano, Deruta, (Municipalities of Gubbio, Costacciaro, Fossato Torgiano) di Vico, Gualdo Tadino, Scheggia, Sigillo, Loggia dei Lanari Valfabbrica) piazza Matteotti, 18 - 06121 PERUGIA via della Repubblica, 15 - 06024 GUBBIO (PG) tel. +39 075 5736458 - 5772686 tel. +39 075 9220693 - fax +39 075 9273409 fax +39 075 5720988 [email protected] Infopoint Porta Nova - Pian di Massiano tel. +39 075 5058540 IAT dell’Orvietano [email protected] (Municipalities of Orvieto, Allerona, Baschi, [email protected] Castelgiorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, http://turismo.comune.perugia.it Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo) IAT di Terni piazza Duomo, 24 - 05018 ORVIETO (TR) (Municipalities of Terni, Acquasparta, Arrone, tel. +39 0763 341772 - fax +39 0763 344433 Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Montefranco, [email protected] Narni, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone) IAT di Spoleto viale Cassian Bon, 4 - 05100 TERNI (Municipalities of Spoleto, Campello sul Clitunno, tel. +39 0744 423047 - fax +39 0744 427259 [email protected] Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria) piazza della Libertà, 7 - 06049 SPOLETO (PG) IAT dell’Alta Valle del Tevere tel. +39 0743 218620 - 21 - 11 (Municipalities of Città di Castello, Citerna, fax +39 0743 218641 Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, [email protected] Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide) IAT del Trasimeno piazza Matteotti - Logge Bufalini (Municipalities of Castiglione del Lago, 06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG) Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, tel. -

Paesaggi D'arte E Vedute Nella Pittura
Gentes, anno I numero 1 - dicembre 2014 Visioni interdisciplinari Paesaggi d’arte e vedute nella pittura rinascimentale: il lago del XV secolo, sulla scia di Hans Memling, come se ne sonoartistici visti abbia numerosi copiato nella modelli splendida della pitturamostra fiamminga che la Gal- Trasimeno come soggetto leria Palatina di Firenze dedicò nel 2008 ai rapporti artistici intercorsi tra Firenze e gli antichi Paesi Bassi Elvio Lunghi 2. Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Non che Pietro Perugino non abbia mai ritratto ve- Università per Stranieri di Perugia dutenell’età di delluoghi Rinascimento reali negli sfondi paesistici dei suoi Keywords: pittura rinascimentale, lago Trasimeno, paesaggio lacustre quadri. Se ne conoscono due, uno a Deruta e uno a Pe- rugia, in casi che hanno il sapore della religione civica - Una vulgata sovente ripetuta vuol riconoscere nel lago mente riconoscibile: perché una richiesta di soccorso Trasimeno il soggetto che compare negli sfondi di pa- celestee che per non tanto andava richiesero posta un’ambientazionea caso. Il primo esempio perfetta è esaggio che si aprono alle spalle dei santi dai grandi offerto da un affresco con le immagini dei santi Roma- occhioni sorridenti che affollano le sacre conversa- no e Rocco che si conserva nella Pinacoteca Comunale zioni dipinte a cavallo dei secoli XV e XVI da Pietro di Deruta, ma che era in origine nella chiesa di San Francesco dei frati Minori conventuali. Ai piedi dei peninsulare per il maggiore pittore umbro del Rina- due santi si affaccia una minuziosa rappresentazione scimentoPerugino: 1la. Perugino più estesa abbandonò superficie i fondilacustre oro dell’Italia tradizio- nali della pittura sacra medievale per adottare una Comune e il campanile della chiesa dei frati sopra una cifra verde movimentata da dolci declivi e da rocce a volo d’uccello del castello di Deruta, con la torre del incombenti, dove crescono foreste di faggeti e chiome - isolate, in mezzo alle quali si nascondono castelli e cit- distesa di tetti e di case. -

Max Hutzel Photographs of Art and Architecture in Italy
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c87s7qqc Online items available Finding aid for Foto arte minore: Max Hutzel photographs of art and architecture in Italy Martha Steele, Andra Darlington, Laney McGlohon, and Tracey Schuster Finding aid for Foto arte minore: Max 86.P.8 1 Hutzel photographs of art and architecture in Italy ... Descriptive Summary Title: Foto arte minore: Max Hutzel photographs of art and architecture in Italy Date (inclusive): 1960-1990 Number: 86.P.8 Creator/Collector: Hutzel, Max Physical Description: 915 boxes(circa 67,275 black-and-white photographic prints, circa 86,400 black-and-white negatives) Repository: The Getty Research Institute Special Collections 1200 Getty Center Drive, Suite 1100 Los Angeles 90049-1688 [email protected] URL: http://hdl.handle.net/10020/askref (310) 440-7390 Abstract: This collection contains thorough photographic documentation by Max Hutzel of art and architecture in Italy ranging in date from Antiquity to late Baroque. Included are photographs of secular buildings, museum holdings, ancient ruins, and religious institutions covering a broad range of artistic forms and styles, including architecture, paintings, frescoes, sculpture, manuscripts, metalwork and other minor arts. The regions most heavily represented are: the Abruzzi, Lazio (including Rome), the Marches, and Umbria. Request Materials: Request access to the physical materials described in this inventory through the catalog record for this collection. Click here for the access policy . Language: Collection material is in English Biographical / Historical German-born photographer and scholar Max Hutzel (1911-1988) photographed in Italy from the early 1960s until the late 1980s, resulting in a vast body of photographs that he referred to as "Foto arte minore." Over the years he amassed a collection of about one million negatives and sold his photographs to individual scholars for publication and to institutions such as the Biblioteca Herziana, the National Gallery in Washington, and the Kunsthistorische Institut in Florence. -

Pietro Perugino 1 Pietro Perugino
Pietro Perugino 1 Pietro Perugino Pietro Perugino Self-portrait, 1497–1500 Birth name Pietro Vannucci Born c. 1446Città della Pieve, Umbria, Italy Died 1523Fontignano, Umbria, Italy Nationality Italian Field Painting, Fresco Training Andrea del Verrocchio Movement Italian Renaissance Works The Delivery of the Keys Pietro Perugino (c. 1446/1450–1523), born Pietro Vannucci, was an Italian Renaissance painter of the Umbrian school, who developed some of the qualities that found classic expression in the High Renaissance. Raphael was his most famous pupil. Biography Early years He was born Pietro Vannucci in Città della Pieve, Umbria, the son of Cristoforo Vannucci; his nickname characterizes him as from Perugia, the chief city of Umbria. Despite what stated by his biographer Giorgio Vasari, the Vannucci were one of the richest in the town.[1] His exact date of birth is not known, although, basing on his age at the death mentioned by Vasari and Giovanni Santi, it has been dated between 1446 and 1452.[1] He most likely began to study painting in Perugia, in local workshops such as those of Bartolomeo Caporali or Fiorenzo di Lorenzo.[1] The date of this first Florentine sojourn is unknown; some make it as early as 1466/1470, others push the date to 1479.[1] According to Vasari, he apprenticed in the workshop of Andrea del Verrocchio alongside Leonardo da Vinci, Domenico Ghirlandaio, Lorenzo di Credi, Filippino Lippi and others. He may have learned perspective from Piero della Francesca. In 1472 he must have completed his apprenticeship, for he was enrolled as a painter in the confraternity of St Luke. -

Leonardo Da Vinci: Face to Face
Leonardo da Vinci: Face to Face Rafael Capurro Who was Leonardo da Vinci? He was the spokesman of nature in all its variety, revealing and concealing its infinity in never ending transformations. Nature was his master. Mathematics is the language that allows Leonardo a discrete approximation to the continuum of nature. Experience, l'esperienza , is the path of science in order to avoid the pitfalls of speculation. Leonardo is not Kant. We are natural beings having the capacity of judging what we think and do without submitting nature to a priori forms of human knowledge. Leonardo is aware of space-time infinity. His sfumato makes it manifest for the senses. He thinks in form of notes and sketches. Thinking is design and design is thinking. His notes, written underway, are the matter of possible treatises that turn to be themselves sketches, not an opus . Although he recommends the painter in the after his death compiled Trattato della Pittura (in the following as TP) to be lonely ( solitario ) in order to be himself ( E se tu sarai solo, tu sarai tutto tuo , II, 48) 1 his thinking is dialogical. He addresses his readers either as future painters or just as human beings. He faces animals, plants, mountains, rocks, air, fire or rivers letting them be what they are. Leonardo is a phenomenologist avant la lettre . Mathematics is the via regia of science. But science is the small daughter ( figliola ) of experience, not its master. "Truth was only the small daughter of time" ( La verità fu sola figliola del tempo , Pensieri e Aforismi, 103). -

Piano Strategico 2020–20233 PRESENTAZIONE
GALLERIA NAZIONALE Dati 2016–2019 2 DELL’UMBRIA Piano Strategico 2020–20233 PRESENTAZIONE Il Piano strategico 2020–2023 costituisce il portolano che consentirà di orientare la navigazione della Galleria Nazionale dell’Umbria nei prossimi quattro anni. Nel redigerlo si è tenuto conto delle linee programmatiche messe in atto nel periodo 2016–2019 e della loro realizzazione, considerando le attività previste nel Piano strategico 2020–2023 come il naturale proseguimento e completamento di ciò che è stato previsto, avviato o compiuto fin qui. Alla fine del percorso di otto anni, i primi durante i quali il museo ha speri- mentato le possibilità offerte dall’autonomia scientifica, gestionale e finan- ziaria conferita ai sensi del DPCM 29 agosto 2014 n. 171, la Galleria avrà cambiato completamente volto, pur avendo mantenuta integra la propria identità storica. Lo scopo del processo evolutivo che si è intrapreso, infatti, è quello di ren- dere il museo un luogo sempre più accogliente, inclusivo, concentrato non soltanto sulla conservazione del patrimonio ma anche sulla ricerca e sulla sua massima condivisione, sull’estensione delle tipologie di pubblico, sul- la completa accessibilità e sull’apertura nei confronti di altre forme d’arte, dalla musica al teatro, dalla letteratura al cinema. In questo senso la radicale digitalizzazione della Galleria ha impresso un ritmo decisamente più sostenuto a tutte le attività, a partire da quelle legate alla conservazione e allo studio, fino alla comunicazione e all’ordinaria ge- stione amministrativa, nella piena consapevolezza che l’unico modo che un museo ha per rimanere sé stesso è quello di trasformarsi continuamente. Il Direttore 4 5 STORIA, IDENTITÀ E COLLEZIONE La Galleria Nazionale dell’Umbria, una delle principali raccolte d’arte d’Italia, è ospitata ai piani superiori del Palazzo dei Priori di Perugia, sede del Comune fin dall’epoca medievale e significativo esempio di architettura civile gotica.