Quadernicird 21
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rosandra Valley, Classical Karst)
Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-4257, 2009 EGU General Assembly 2009 © Author(s) 2009 Hazard connected to tunnel construction in Mt Stena karstic area (Rosandra Valley, Classical Karst) F. CUCCHI, W. BOSCHIN, L. VISINTIN, and L. ZINI University of Trieste, Department of Geological Environmental and Marine Sciences, Trieste, Italy ([email protected]) Rosandra Valley –a unique geomorphological environment– is located in the western side of the Classical Karst plateau. This deep limestone gorge is crossed by a stream that is fed by a large basin located in Slovenia. Rosandra Valley is the only example of Classical Karst river valley with surface hydrography; the torrent digs a deep gully into the rock, rich in rapids, swirl holes, small waterfalls, enclosed meanders and basins; here, the first seepage phenomena occur, and part of the water feeds the underground aquifer. Rosandra Valley is theatre to complex structural situation; the NE slope culminates in the structure of Mt Stena, a limestone tectonic scale located between two faults and firmly rooted in the karst platform. Tectonics is quite important for the development of deep karst in this area; Mt Stena, in particular, hosts a comprehensive net of articulated and diversely shaped caves, basically organised on several levels, which stretches over a total of 9,000 metres, bearing testimony to ancient geological and hydrogeological origins. The deepest areas of the system reach a suspended aquifer that is probably sustained by an overthrust and placed about 100 meters above Rosandra torrent underground aquifer. During feasibility studies about Trieste-Divacaˇ high velocity railway link, interaction between project and karst features was examined; in fact the proximity of proposal project and Mt Stena karst system suggest to improve the knowledge related to karst and hydrogeological aspects of the massif. -
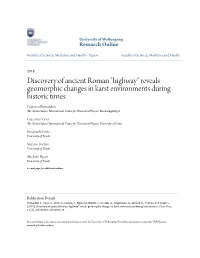
Reveals Geomorphic Changes in Karst Environments During Historic Times
University of Wollongong Research Online Faculty of Science, Medicine and Health - Papers Faculty of Science, Medicine and Health 2018 Discovery of ancient Roman "highway" reveals geomorphic changes in karst environments during historic times Federico Bernardini The 'Abdus Salam' International Centre for Theoretical Physics, [email protected] Giacomo Vinci The 'Abdus Salam' International Centre for Theoretical Physics, University of Udine Emanuele Forte University of Trieste Stefano Furlani University of Trieste Michele Pipan University of Trieste See next page for additional authors Publication Details Bernardini, F., Vinci, G., Forte, E., Furlani, S., Pipan, M., Biolchi, S., De Min, A., Fragiacomo, A., Micheli, R., Ventura, P. & Tuniz, C. (2018). Discovery of ancient Roman "highway" reveals geomorphic changes in karst environments during historic times. PLoS One, 13 (3), e0194939-1-e0194939-19. Research Online is the open access institutional repository for the University of Wollongong. For further information contact the UOW Library: [email protected] Discovery of ancient Roman "highway" reveals geomorphic changes in karst environments during historic times Abstract Sinkholes are a well-known geologic hazard but their past occurrence, useful for subsidence risk prediction, is difficult to define, especially for ancient historic times. Consequently, our knowledge about Holocene carbonate landscapes is often limited. A multidisciplinary study of Trieste Karst (Italy), close to early Roman military fortifications, led to the identification of possible ancient road tracks, cut by at least one sinkhole. Electrical Resistivity Tomography through the sinkhole has suggested the presence of a cave below its bottom, possibly responsible of the sinkhole formation, while Ground Penetrating Radar has detected no tectonic disturbances underneath the tracks. -

Geology of the Classical Karst Region (SW Slovenia–NE Italy)
Journal of Maps ISSN: (Print) 1744-5647 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/tjom20 Geology of the Classical Karst Region (SW Slovenia–NE Italy) Bogdan Jurkovšek, Sara Biolchi, Stefano Furlani, Tea Kolar-Jurkovšek, Luca Zini, Jernej Jež, Giorgio Tunis, Miloš Bavec & Franco Cucchi To cite this article: Bogdan Jurkovšek, Sara Biolchi, Stefano Furlani, Tea Kolar-Jurkovšek, Luca Zini, Jernej Jež, Giorgio Tunis, Miloš Bavec & Franco Cucchi (2016) Geology of the Classical Karst Region (SW Slovenia–NE Italy), Journal of Maps, 12:sup1, 352-362, DOI: 10.1080/17445647.2016.1215941 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/17445647.2016.1215941 © 2016 Sara Biolchi View supplementary material Published online: 12 Aug 2016. Submit your article to this journal Article views: 355 View related articles View Crossmark data Citing articles: 1 View citing articles Full Terms & Conditions of access and use can be found at http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tjom20 Download by: [University of Trieste] Date: 16 May 2017, At: 01:24 JOURNAL OF MAPS, 2016 VOL. 12, NO. S1, 352–362 http://dx.doi.org/10.1080/17445647.2016.1215941 SCIENCE Geology of the Classical Karst Region (SW Slovenia–NE Italy) Bogdan Jurkovšeka, Sara Biolchib, Stefano Furlanib, Tea Kolar-Jurkovšeka, Luca Zinib, Jernej Ježa, Giorgio Tunisb, Miloš Baveca and Franco Cucchib aGeological Survey of Slovenia, Ljubljana, Slovenia; bDepartment of Mathematics and Geosciences, University of Trieste, Trieste, Italy ABSTRACT ARTICLE HISTORY The paper aims to present the geology of the western part of the Classical Karst (NW Dinarides), Received 27 May 2016 located at the border between Slovenia and Italy. -
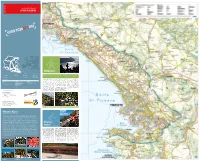
Trieste's Karst Footpaths Bicycle Routes
HOW AND WHERE HOW A borderland, a land of emotions of land a borderland, A TRIESTE’S KARST TRIESTE’S AUSTRIA AUSTRIA Arta Terme Tarvisio A23 Tolmezzo Gemona SLOVENIA Dolomiti Friulane del Friuli Europa San Daniele Cividale Piancavallo del Friuli del Friuli Regione Spilimbergo Friuli Venezia Giulia UDINE SLOVENIA Palù di Livenza PORDENONE Italia Palmanova GORIZIA A28 A4 TREVISO Aeroporto FVG A4 Ronchi dei Legionari Aquileia VENEZIA SLOVENIA Lignano Grado TRIESTE Footpaths Sabbiadoro - Aquileia - - Dolomiti Friulane - - Cividale del Friuli - - Palù di Livenza - IO M NIO M ON U O UN ONIO MU NIO M M N IM D M N O UN I D R I D IM D R I T IA R I R T A T A T IA A L A L A L • A L • P P • P • • • P • W W • W W L L L L O O A O A A O A I I I R R I R R D D L L D L D L D D N N D N D N O O H O H H O Many are the paths to be followed on the territory of Trieste’s Karst, the main ones are shown on the H E M E M E M R R E M E I E R E R IT T N I I E A IN A I TA IN T N G O G O G O A I E • IM E • IM E • M G O PATR PATR PATRI E • PATRIM United Nations Archaeological Area and United Nations The Dolomites United Nations Longobards in Italy. -

Bike Experience
ENGLISH BIKE EXPERIENCE Gorizia and sorroundings Grado Carnia Lignano and sorroundings Pordenone, Piancavallo and Magredi Tarvisio, Gemona and sorroundings Trieste and the Karst Udine and the sorrounding hills FREE WHEELING FRIULI VENEZIA GIULIA IS A BIKE EXPERIENCE! Miles of bike routes, cycle paths, off-road tracks and circuits used by great champions, surrounded by a unique combination of unspoilt nature and treasures of art: Friuli Venezia Giulia is the promised land for anyone who loves cycling. The region’s specific geographical position, connecting the Alps and the Adriatic, means you can choose from countless spectacular settings and, if you wish, you can quickly change scenery. Peaceful forests, bold peaks and legendary trails are waiting for you in the mountains, while the coast offers tranquil lagoons and sheer cliff faces overlooking the sea. In the heart of the region, you will find the large, spectacular Tagliamento River, the romantic hillsides used for vineyards, and vast stretches of plains organised by the shapes of the reclamation areas. Rural villages and small historic towns are waiting for you to taste the regional food and wine specialities all along the trail. Whether you are a speed junkie or prefer the slow life, a dreamer or a daredevil, on your own or with your family, you can easily find your perfect route here: we have the most suitable trails and accommodation for your needs. 2 THE BIKE EXPERIENCE CLUB: FRIULI VENEZIA GIULIA FOR ANYONE TRAVELLING BY BIKE The Bike Experience Club has selected a list of facilities equipped with all the services needed to welcome cycle tourists as best as possible. -

Non-Invasive Methodological Approach to Detect And
remote sensing Article Non-Invasive Methodological Approach to Detect and Characterize High-Risk Sinkholes in Urban Cover Evaporite Karst: Integrated Reflection Seismics, PS-InSAR, Leveling, 3D-GPR and Ancillary Data. A NE Italian Case Study Alice Busetti 1, Chiara Calligaris 1,* , Emanuele Forte 1 , Giulia Areggi 1 , Arianna Mocnik 2 and Luca Zini 1 1 Mathematical and Geosciences Department, University of Trieste, Via Weiss 2, 34128 Trieste, Italy; [email protected] (A.B.); [email protected] (E.F.); [email protected] (G.A.); [email protected] (L.Z.) 2 Esplora Srl, Spin-Off University of Trieste, Via Weiss 1, 34128 Trieste, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected] Received: 22 October 2020; Accepted: 18 November 2020; Published: 20 November 2020 Abstract: Sinkholes linked to cover evaporite karst in urban environments still represent a challenge in terms of their clear identification and mapping considering the rehash and man-made structures. In the present research, we have proposed and tested a methodology to identify the subsiding features through an integrated and non-invasive multi-scale approach combining seismic reflection, PS-InSAR (PSI), leveling and full 3D Ground Penetrating Radar (GPR), and thus overpassing the limits of each method. The analysis was conducted in a small village in the Alta Val Tagliamento Valley (Friuli Venezia Giulia region, NE Italy). Here, sinkholes have been reported for a long time as well as the hazards linked to their presence. Within past years, several houses have been demolished and at present many of them are damaged. The PSI investigation allowed the identification of an area with higher vertical velocities; seismic reflection imagined the covered karst bedrock, identifying three depocenters; leveling data presented a downward displacement comparable with PSI results; 3D GPR, applied here for the first time in the study and characterization of sinkholes, defined shallow sinking features. -

CULTURAL HERITAGE and LIMESTONE Appendix 3.I.2 Site Specific Study for the Comune Di San Dorligo Della Valle/Dolina Municipality
RoofOfRock Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast CULTURAL HERITAGE AND LIMESTONE Appendix 3.I.2 Site specific study for the Comune di San Dorligo della Valle/Dolina Municipality Annex 3.I.2.1 Geological elaborate Igor RIŽNAR September 201 4 IPA Adriatic Cross‐border Cooperation Programme 2007 – 2013 Project »Roof of Rock ‐ Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast« Geological elaborate for the study about the flysch / carbonates junction in the San Dorligo della Vale‐Dolina Municipality and the influence of this junction on architecture CLIENT Comune di San Dorligo della Valle/Občina Dolina Investment, Environment and Culture European Projects Department Dolina 270 34018 San Dorligo della Valle/Dolina (TS) RESPONSIBLE AT STUDIO, Aleksandra Torbica s.p. Grčna 6a 5000 Nova Gorica SLOVENIA AUTHOR Dr. Igor Rižnar September 2014 1 2°ord/0033/0: GEOLOGICAL ELABORATE, Page 2 of 48 INDEX 1 Introduction ..............................................................................................................................................3 2 Paleogeographical overview and tectonic subdivision............................................................3 3 Basic geomorphological characteristics of the area......................................................................4 4 Lithostratigraphic units.............................................................................................................................8 -
Geology and Geomorphology of the “Rosandra” Valley for a Cultural Enhancement
Il Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences 18(1), 2005 - Volume Speciale, 185-196 GEOLOGY AND GEOMORPHOLOGY OF THE “ROSANDRA” VALLEY FOR A CULTURAL ENHANCEMENT Franco Cucchi, Alessio Mereu, Sara Oberti, Chiara Piano, Anna Rossi & Luca Zini Department of Geological, Environmental and Marine Sciences, University of Trieste; [email protected] ABSTRACT: F. Cucchi et al., Geology and Geomorphology of the “Rosandra” Valley for a Cultural Enhancement. (IT ISSN 0394-3356, 2005). The Rosandra Valley is located near Trieste (Italy), on the border of Classical Karst, and is a canyon-like depression excavated in ter- tiary limestone. The origin of the valley is mainly due to presence of faults and overthrusts and different attitude to erosion between limestone and marls, which makes it a beautiful example of lithological and structural control on morphogenesis. Furthermore, its slo- pes are interested by extended and mature underground karst phenomena that contribute to making the whole hydro-structure more interesting. The valley is also remarkable for its local vegetation, due to its particular climatic conditions, and to its prehistoric and historical value, stemming from its geographic location. RIASSUNTO: F. Cucchi et al., Geologia e Geomorfologia della Val Rosandra per una sua valorizzazione culturale. (IT ISSN 0394-3356, 2005). La Val Rosandra è ubicata in provincia di Trieste, al confine del Carso Classico, ed è una valle profondamente incisa in calcari terziari. La sua origine è principalmente legata alla presenza di faglie e di sovrascorrimenti ed all’erosione selettiva dovuta alla presenza di litoti- pi diversi come calcari e marne; tutto ciò ha creato un esempio spettacolare di forme influenzate dalla litologia e dalla tettonica. -
Una Visita Di Studio Nella Riserva Naturale Regionale Della Val Rosandra (TS)
DOI: 10.13137/2039-8646/13946 Una visita di studio nella Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra (TS). Forme, ambienti e materiali DAVID DE FIORIDO* Scuola secondaria di primo grado “G. Randaccio” Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli [email protected] SUNTO L’esperienza maturata durante il Percorso Abilitante Speciale ha permesso di organizzare un complesso progetto didattico multidisciplinare centrato su una visita di studio nella Val Rosandra (TS). La visita ha seguito un percorso studiato per poter osservare le numerose peculiarità geologiche, storiche e naturalistiche della valle, consentendo agli alunni di sviluppare e approfondire conoscenze e competenze specifiche. Dati i numerosi argomenti da trattare, la visita è stata suddivisa in nove fasi, nel corso delle quali gli alunni hanno svolto attività individuali e di gruppo, tra cui un laboratorio cartografico utilizzando stralci di carte tecniche regionali e un laboratorio biologico-ambientale attuando il Protocollo I.B.E. Il progetto si è concluso con diverse attività di consolidamento. PAROLE CHIAVE DIDATTICA DELLE SCIENZE / SCIENCE EDUCATION; VISITA DI STUDIO / STUDY VISIT; LABORATORIO TERRITORIALE / TERRITORIAL LABORATORY; GEOMORFOLOGIA CARSICA / KARST GEOMORPHOLOGY; INDICE BIOTICO ESTESO (I.B.E.) / EXTENDED BIOTIC INDEX; FRIULI-VENEZIA GIULIA / FRIULI-VENEZIA GIULIA (ITALY); AREE PROTETTE / PROTECTED AREAS; VAL ROSANDRA (TS) / ROSANDRA VALLEY (TRIESTE, FRIULI-VENEZIA GIULIA, ITALY). 1. LA DIDATTICA TERRITORIALE: DAL PAS ALLA SCUOLA La visita di studio di -

Indici Memorie Società Geologica Italiana 1982 -2002
Indici Memorie Società Geologica Italiana 1982 -2002 Numero, fasc., pagg., ff. e Autore Anno Titolo tavv. Parole Chiave LENTINI F. 1982 The geology of Mt. Etna Basement 23,7-25, 11, 0 stratigraphy, tectonics, Eastern Sicily Succession of the volcanic activity in ROMANO R. 1982 the etnean area 23, 27-48, 10, 0 stratigraphy, volcanology, Mt. Etna Styles of eruption and flow GUEST J.E. 1982 morphology on Mt. Etna 23, 49-73, 15, 0 styles of eruption, lava flow morphology, Mt. Etna ROMANO R., STURIALE The historical eruptions of Mt. Etna C. 1982 (volcanological data) 23, 75-97, 6, 0 historical eruptions, volcanological data, Mt. Etna CRISTOFOLINI R., Petrologic features of the etnean ROMANO R. 1982 volcanic rocks 23, 99-115, 10, 0 petrology, tholeiitic suite, alkalic suite, Mt. Etna RASÀ R., ROMANO R., A structural survey of Mt. Etna on a LO GIUDICE E. 1982 morphologic basis 23, 117-124, 1, 1 structural survey, morphology, volcanology, Mt. Etna LO GIUDICE E., PATANÈ G., RASÀ R., The structural framework of Mount structure, morphology, volcanology, seismotectonics, regional ROMANO R., 1982 Etna 23, 125-158, 18, 0 tectonics, stress field, Mt. Etna COSENTINO M., Seismological researches on Mount LOMBARDO G., Etna: state of the art and recent PATANÈ G., SCHICK R., 1982 trends 23, 159-205, 40, 0 seismicity, macroseismic, tremor, deep structure, Mt. Etna Concordanza stratigrafica tra carbonati, radiolariti e flysch ercinico stratigrafia, Devoniano superiore, Famenniano, Dinantiano, nele Alpi Carniche (Devoniano- tettonica distensiva sinsedimentaria, discontinuità e SPALLETTA C. 1982 Silesiano) 24,1,11-21, 5, 0 discordanza, fasi tettoniche carniche, Carnia, Alpi Meridionali Il bacino ercinico di Pramollo (Alpi Carbonifero, Permiano, litostratigrafia, analisi di bacino, Carniche): un'evoluzione regolata evoluzione paleotettonica, paleogeografia, Alpi Carniche, VENTURINI C. -

Masterarbeit
MASTERARBEIT Titel der Masterarbeit “The other Trieste: integration of a community on the border” verfasst von Alessandro Baracetti BA angestrebter akademischer Grad Master of Art (M.A.) Wien, 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A066 656 Studienrichtung lt. Studienblatt: CREOLE-Cultural Differences and Transnational Processes Betreuerin: Mag.a Dr.in Jelena Tošić The other Trieste: a community on the border 2 Construction of a local identity Contents Acknowledgments and remarks .................................................................................................................... 7 Introduction ...................................................................................................................................................... 8 1. Research Methods ................................................................................................................................... 12 1.1. Interviews ............................................................................................................................................ 12 1.2. Observations and research notes ................................................................................................... 14 1.3. Translations ........................................................................................................................................ 17 2. Trieste through time: history, social texture and ethnic communities ............................................... 18 2.1. Trieste: patterns of coexistence ..................................................................................................... -

Taste Experience
TASTE EXPERIENCE FOOD AND WINE AND FOOD AN AREA TO BE FULLY SAVOURED FULLY BE TO AREA AN The experiences you can live in Friuli Venezia Giulia TASTE EXPERIENCE INDEX OUTDOOR EXPERIENCE Friuli Venezia Giulia to savor: All the region’s fine food and wine Friuli Venezia Giulia on the go: tasting tours and activities All the activities for a dynamic vacation filled with sports and adventure. BIKE EXPERIENCE FAMILY EXPERIENCE Friuli Venezia Giulia on two wheels: An area to be fully savoured La Barbatella — wine cutting All the activities to discover the beauty 5 46 of the region by bike. Friuli Venezia Giulia for the family: The Wine and Dine Route of FVG All the activities for a family-friendly 8 Prosciutto di San Daniele and other vacation to discover all that the region 48 cured meats has to offer. 10 The Mountains SLOW ART & 14 Wild Herbs 50 Pork meat EXPERIENCE CULTURE 20 From Malga to Malga 52 Montasio cheese EXPERIENCE 22 The magical world of beer 54 Tergeste Oil and other oils 24 The Hills 56 Brovada 34 The Trout 58 PGI products 35 The Apple 60 The Slow Food Presidia Friuli Venezia Giulia to relish: The Seaside A quick recap All the activities to help you slow Friuli Venezia Giulia with art: 36 66 All the activities for exploring the down, relax, and discover the region’s The Historical cafés of Trieste unhurried beauty. region and its historical, artistic and 42 Dulcis in fundo... cultural treasures. 68 44 Thewines of Friuli Venezia Giulia Tiramisù The Ultimate dessert! AN AREA TO BE FULLY SAVOURED A trip to Friuli Venezia Giulia, a region with land borders, mountains, hills, lakes and the sea, combines the pleasure of good food and drink with a diverse, welcoming and lush natural environment, in addition to a history that dates back thousands of years, that is steeped in languages, traditions and important artistic heritage.