Il Comportamento Dei Consumatori Giapponesi E La
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Universitatea
10.2478/ewcp-2020-0011 Japan’s Food Culture – From Dango (Dumplings) to Tsukimi (Moon-Viewing) Burgers OANA-MARIA BÎRLEA Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania Abstract The purpose of this essay is to present how Japanese eating habits have changed in the context of globalization. We start from the premise that eating is not merely about meeting a basic need, but about creating a relationship with nature. It can be regarded as a ritual practice because it reveals a culture and its people’s beliefs, values and mind-sets. As Geert Hofstede et al. note, life in Japan is highly ritualized and there are a lot of ceremonies (192). Starting from the idea that food consumption is based on rituals too, we intend to explain the relationship between eating habits and lifestyle change in contemporary Japan. Considering that the Japanese diet is based on whole or minimally processed foods, we ask ourselves how Western food habits ended up being adopted and adapted so quickly in the Japanese society. With this purpose in mind, we intend to describe some of the most important festivals and celebrations in Japan, focusing on the relationship between special occasions and food. In other words, we aim to explain the cultural significance of food and eating and to see if and how these habits have changed in time. Keywords: Japan, Japanese culture, gastronomy, globalization, traditional eating, modern eating, food studies, eating habits, change, food-body-self relationship. Oana-Maria Bîrlea 55 Introduction The Japanese are known for their attention to detail, balance and desire to improve (Sarkar 134). -

Information to Users
INFORMATION TO USERS While the most advanced technology has been used to photograph and reproduce this manuscript, the quality of the reproduction is heavily dependent upon the quality of the material submitted. For example: • Manuscript pages may have indistinct print. In such cases, the best available copy has been filmed. • Manuscripts may not always be complete. In such cases, a note will indicate that it is not possible to obtain missing pages. • Copyrighted material may have been removed from the manuscript. In such cases, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, and charts) are photographed by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each oversize page is also filmed as one exposure and is available, for an additional charge, as a standard 35mm slide or as a 17”x 23” black and white photographic print. Most photographs reproduce acceptably on positive microfilm or microfiche but lack the clarity on xerographic copies made from the microfilm. For an additional charge, 35mm slides of 6”x 9” black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations that cannot be reproduced satisfactorily by xerography. Order Number 8726664 Organizational adaptation of Japanese companies in the United States Ito, Kinko, Ph.D. The Ohio State University, 1987 Copyright ©1987 by Ito, Kinho. All rights reserved. UMI 300 N. Zeeb Rd. Ann Arbor, MI 48106 PLEASE NOTE: In all cases this material has been filmed in the best possible way from the available copy. -
Lawn Seed Rent One First Jt Hold True to the Veteran Who Is Mif
•7- (N.-J;_) CITIZEN^AND CHRONICLE—TllUUSDAY, JMARCIl ic, 1 career . advancement pr SPECIAL! Kashariaii Undefeated sponsored by tjie Busines 1 FREE! PLANTABBS IC As RutgeiS Wiesller Professional. Women's Cli Fiinwood and Scotch Plair Wiflt Purchase of $2 Worth oi |. KE.NILKE.NIL'WOHTO H —E Edward; Kas- Week.' —•--- -,' . ' ,' '•'••• At St. Paul's tariim of 1TH Boulevard e FERRY—MORSE & CO. -T •' '!' • '• : ui :i n the GARWOOD ; — ' !<th Miirluv ''' " undefeated niuuiber of ' NORTHRUP -~ KING & CO iNr wrestlinli g tciuii Second Clasi Poslafie Paid Power of God" will be the sermon in five" matches. "• , , Fund Drive At Craniord Nr'OtT"^ GARDEN TOOLS GARDEN SEEDS CftANFQRD, NEW JERSEY^ THURSDAY, MARCH 23, ? 1961- topic of the Rev. Stephen Szabo, "• A freshman'ill Hulgers, tic com- Vol. LXVIII. 3 Sections, 24 Pages pastor, at (Tie 11 a.m. worship 'pc-ted in thl; Metropolitan 'Wrest- Report Awaite Value 79c and 89c ling Championship' last week at MW t( Iff UlJ Utl UlNJUX It I 111 I UU&ftfUiUMUIUUItUUI servict in St.'Paul's United Church Montclair 'State-,- winning 'thre At St. Theresa Joint Civic . of •• Christ.this-Sunday. The Youth nut of tour matches in the 130 Percent Ratid Effect class* Me is the son of Cou»- .KKNILWOHTH.'—^ii. ' Choir,''..'."under"'direction of Mrs. ;' i tlic development drive • o: "God cilman. and Mrs. Edward H. TlnitNanw^ Raymond R:nnbov w.jH "Arclidiocesc of- Newark i So_ Loved the .\Vor|d, by "John Theresa's'.parish will be ma • Flower Pots . Stainer. •" j -night^t 7 o'clock at St. Th<,_ New dispersing Idea The avprage t^x bill here (except ir» the case^f-a veteran, New Officers Church School.*'will • Sprayers •:. -

Reframing the Japanese Legal System in Comparative Legal Scholarship: Recognising the Role and Function of Socio-Cultural Regula
1 Reframing the Japanese legal system in comparative legal scholarship: recognising the role and function of socio-cultural regulatory norms through legal culture and critical legal pluralism. Rosemary Louise Taylor Fox Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Leeds School of Law October 2019 2 The candidate confirms that the work submitted is her own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. The right of Rosemary Louise Taylor Fox to be identified as Author of this work has been asserted by her in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. 3 Acknowledgements This thesis would not have been completed without the help and support of so many important and special people. I would first like to thank my supervisors, Dr Jen Hendry and Professor Surya Subedi, for their patience, advice, and support throughout this journey. As my primary supervisor, Jen has been endlessly patient, kind, and believed in me when I had given up on myself. I cannot thank her enough. Thank you to Dr Imogen Jones, my mentor and friend, for starting me on the path to getting well, for helping me put things in perspective, and for her unwavering support, kindness and reassurance. Huge thanks to my fantastic colleagues at the School of Law (especially those on the party floor!) - Alastair, Anna, Yousra, Adam, Lydia, Andrew, Carrie, Sean, Maisie, Amrita, Marika, Olivia, Amanda, Ilias, Rebecca, Craig, Rachael, Josh, Chloe, Alex, Stuart, Tracey, Nick, Rachael, Antony, Jimmy, Mitch, Bev, Priyasha, Steven, Katie, Ben, Chris, Jo, Amanda, Ilaria, Jose, Cesar, Cin, Abi, Maria, Richard, Henry, Priyasha, Konstantinos, Gerry, Elies, Suzanne, and George. -

02 Whole.Pdf (9.518Mb)
Copyright is owned by the Author of the thesis. Permission is given for a copy to be downloaded by an individual for the purpose of research and private study only. The thesis may not be reproduced elsewhere without the permission of the Author. Blurring the boundaries: Japanese students negotiating their experiences in a New Zealand tertiary institution with international characteristics A thesis presented in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Second Language Teaching At Massey University, Manawatu, New Zealand. Douglas James Rapley 2017 i Abstract This research uses a sociocultural perspective to explore the experiences of a group of Japanese study abroad students living and studying in a private, Japanese-owned tertiary institution in New Zealand. The data collection included a questionnaire investigating pre- arrival expectations and a longitudinal phase of semi-structured interviews. The Japanese characteristics of the college, in spite of its location in New Zealand, constructed the students’ experience in a way that blurred the boundaries between study in Japan and study abroad. For example, the number of Japanese students present and numerous physical aspects reminiscent of Japan combined with factors, such as the college’s Japanese focused support and continued support from home via the internet, to limit the students’ ability to have a truly international experience. In examining this, the thesis draws an analogy with the Dejima situation, referring to a famous artificial island in Nagasaki, which accommodated Dutch merchants during Japan’s isolationist period and was linked to the mainland by a narrow bridge. In this environment, the Dutch were not permitted entry into Japan proper, thus never gained a real sense of Japanese life nor membership to its society. -

Traductor: Billywtr Traductor: Billywtr Traductor: Billywtr Traductor: Billywtr Traductor: Billywtr Prólogo
Traductor: BillyWTR Traductor: BillyWTR Traductor: BillyWTR Traductor: BillyWTR Traductor: BillyWTR Prólogo El Esper más fuerte (y el único) No hacer nada más sino entrenar mi Psicoquinesis Creo que todos los humanos han deseado superpoderes o habilidades psíquicas al menos una vez. Como desear poder teletransportarse o volverse invisible. Por ejemplo, supongamos que usted está atrapado en el tráfico y va a llegar tarde, y piensas en cómo podría llegar fácil y rápidamente a su destino si pudiera teletransportarse. Si eres un estudiante masculino saludable, una o dos veces probablemente has tenido ilusiones acerca de volverte invisible y hacer "esto y aquello", *Dufufufu....*. Si eres una señorita, puede que hayas pensado en ser capaz de "encantar" a los hombres para que sean tu pareja, *Uhehehe...*. No sé si las mujeres realmente tienen tales pensamientos. Por supuesto, como estudiante de secundaria, yo también tenía estos pensamientos. Pero para los típicos homosapiens que viven en el siglo 21, ninguno de estos pensamientos sucedió realmente. Y cuando la mayoría de la gente se convierte en estudiantes de secundaria, estos desorientados delirios comienzan a estabilizarse, ya que hay demasiadas otras cosas en las que pensar. Pero mientras charlamos, el interrogante "¿Qué harías si tuvieras superpoderes?" seguirá apareciendo de vez en cuando. Estaba hablando de esto mientras caminaba a casa con mis amigos desde la escuela secundaria, y por eso todavía estaba en mi mente cuando llegué a mi casa. Después de llegar a casa, me senté en el sofá de la sala de estar con unas galletas de arroz y vi un soso programa de variedades. -

Postcolonial Theory Reconsidered: Discourses of Race, Gender, and Imperialism in the German-Japanese Realm
Postcolonial Theory Reconsidered: Discourses of Race, Gender, and Imperialism in the German-Japanese Realm by Christin Bohnke A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Germanic Languages and Literatures University of Toronto © Copyright by Christin Bohnke (2017) Postcolonial Theory Reconsidered: Discourses of Race, Gender, and Imperialism in the German- Japanese Realm Christin Bohnke Doctor of Philosophy Department of Germanic Languages and Literatures University of Toronto 2017 Abstract This study explores the intersections of race and gender as they manifest in film and print media across a century of transnational flows between Germany and Japan. I argue that German-Japanese relations in the twentieth century invite novel re-readings of existing postcolonial theories, resulting in a productive re-evaluation of inherited terms such as ‘hybridity’ and ‘race’. Each chapter of my dissertation is devoted to a particular strand of the cultural fabric woven between Germany and Japan and its consequences for the broader relationship between East Asia and Europe. Chapter two focuses on the German-language magazine East Asia (Ost-Asien) published by the Japanese Tamai Kisak from 1898-1910 in Berlin, on Kitasato Takeshi’s German-language drama Fumio (1900), and on the silent film Bushido (1926). These works negotiate Japan’s complex situation as simultaneously belonging to an Asian and a European cultural realm in often contradictory ways. Chapter three pursues an in-depth analysis of the German-Japanese relationship between 1932 and 1945 via such diverse cultural artifacts as the results of a German-Japanese essay contest held in 1944, German newsreels, and German-Japanese filmic co-productions. -

“Melancholic Things”
“Melancholic Things” Volume 1: The Major Work “The Things She Owned” and Volume 2: The Exegesis “Objects as Markers for Identity Transformation in Fictional Grief Narratives” Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Department of English and Creative Writing School of Humanities Faculty of Arts University of Adelaide Submitted March 2016 Table of Contents Abstract i Declaration iv Acknowledgements v Volume 1: The Major Work “The Things She Owned” 1 Volume 2: The Exegesis “Objects as Markers for Identity Transformation in Fictional Grief Narratives” Introduction 234 Chapter 1: The Story Behind the Story 240 Chapter 2: The Things Behind The Things 257 Chapter 3: Melancholic Things: Fossil-Objects, Relic-Objects, Fetish-Objects and Totem-Objects 274 Conclusion 299 Endnotes 301 Bibliography 302 Abstract “The Things She Owned” is a work of literary fiction in the genre of the grief narrative. The interwoven stories of Michiko and Eriko, a mother and daughter, follow Michiko’s life from her wartime childhood in Tokyo to early adulthood, and Erika’s, after her mother’s death, in contemporary London. Erika has not dealt with an urn containing some of Michiko’s bones, nor with other things once owned by her mother, all of which sit untouched and hidden in a dusty cabinet. The arrival of her Japanese cousin Kei forces Erika to confront the difficult feelings stirred up by the sight of these objects. Each section of the narrative from Erika’s life is prefaced by an ekphrastic description of objects that once belonged to Michiko; the things appear within the body of the narrative, each playing a different role in reflecting Erika’s sense of identity in relation to the death of her mother. -

Japanese Cinema: Texts and Contexts
JAPANESE CINEMA: TEXTS AND CONTEXTS Japanese Cinema: Texts and Contexts includes twenty-four chapters on key films of Japanese cinema, from the silent era to the present day, providing a com- prehensive introduction to Japanese cinema history and Japanese culture and society. Studying a range of important films, from Late Spring, Seven Samurai and In the Realm of the Senses to Godzilla, Hana-Bi and Ring, the collection includes discus- sion of all the major directors of Japanese cinema including Ozu, Mizoguchi, Kurosawa, Oshima, Suzuki, Kitano and Miyazaki. Each chapter discusses the film in relation to aesthetic, industrial or critical issues and ends with a complete filmography for each director. The book also includes a full glossary of terms and a comprehensive bibliography of readings on Japanese cinema. Bringing together leading international scholars and showcasing pioneering new research, this book is essential reading for all students and general readers interested in one of the world’s most important film industries. Contributors: Carole Cavanaugh, Darrell William Davis, Rayna Denison, David Desser, Linda Ehrlich, Freda Freiberg, Aaron Gerow, Alexander Jacoby, D. P. Martinez, Keiko I. McDonald, Joan Mellen, Daisuke Miyao, Mori Toshie, Abé Mark Nornes, Alastair Phillips, Michael Raine, Donald Richie, Catherine Russell, Isolde Standish, Julian Stringer, Mitsuyo Wada-Marciano, Yomota Inuhiko, Mitsuhiro Yoshimoto. Alastair Phillips is Associate Professor in Film Studies at the University of Warwick. Julian Stringer is Associate Professor in Film Studies at the University of Nottingham. JAPANESE CINEMA: TEXTS AND CONTEXTS Edited by Alastair Phillips and Julian Stringer First published 2007 by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge 270 Madison Ave, New York, NY 10016, USA Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2007. -

UC San Diego UC San Diego Electronic Theses and Dissertations
UC San Diego UC San Diego Electronic Theses and Dissertations Title Lure of the intimate : power practices in Japanese adolescent friendship Permalink https://escholarship.org/uc/item/7tq0p40k Author Hallman, Heather Spector Publication Date 2011 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO Lure of the Intimate: Power Practices in Japanese Adolescent Friendship A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Anthropology by Heather Spector Hallman Committee in charge: Professor Thomas J. Csordas, Chair Professor Suzanne A. Brenner Professor Maria Charles Professor Janis H. Jenkins Professor Steven M. Parish Professor Christena L. Turner 2011 Copyright Heather Spector Hallman, 2011 All rights reserved. The Dissertation of Heather Spector Hallman is approved, and it is acceptable in quality and form for publication on microfilm and electronically: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Chair University of California, San Diego 2011 iii TABLE OF CONTENTS Signature Page……………………………………………………………............ iii Table of Contents………………………………………………….……………. -
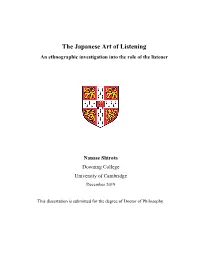
The Japanese Art of Listening an Ethnographic Investigation Into the Role of the Listener
The Japanese Art of Listening An ethnographic investigation into the role of the listener Nanase Shirota Downing College University of Cambridge December 2019 This dissertation is submitted for the degree of Doctor of Philosophy. This thesis is the result of my own work and includes nothing which is the outcome of work done in collaboration except as declared in the Preface and specified in the text. It is not substantially the same as any that I have submitted, or, is being concurrently submitted for a degree or diploma or other qualification at the University of Cambridge or any other University or similar institution except as declared in the Preface and specified in the text. I further state that no substantial part of my thesis has already been submitted, or, is being concurrently submitted for any such degree, diploma or other qualification at the University of Cambridge or any other University or similar institution except as declared in the Preface and specified in the text. It does not exceed the prescribed word limit for the relevant Degree Committee. 1 Abstract The Japanese Art of Listening An ethnographic investigation into the role of the listener Nanase Shirota This project investigates the art of listening in Japan through ethnographic observation of hostesses (escorts) and listening volunteers, and an analysis of self-help literature on listening. At night clubs in Tokyo, hostesses, who are famous for being good listeners, use listening as a streetwise skill. This enables them to stay in subordinate and supportive positions, and to help customers dominate a conversation. The customers can gain a sense of recognition, enhance intimate relationships with the hostesses or rebuild their masculinity.