Linee Pedagogiche Dell'istituto Delle Figlie Di
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Father Paul Grankauskas John Sengewalt Stacy Sefton Jenny
Sunday Mass Schedule Parish Office Bulletin Saturday 5:30 p.m. Vigil Mass Monday - Friday The bulletin deadline is Sunday 9:00 a.m. & 12:00 p.m. 9:00 a.m. - 4:00 p.m. 12:00 p.m. Friday one week 540-277-2943 before publication. Weekday Mass Schedule [email protected] Monday & Tuesday 12:00 p.m. Stbridgetberryville.org Religious Education Wednesday 9:00 a.m. 540-277-2948 Thursday & Friday 12:00 p.m. Baptism [email protected] Saturday 9:00 a.m. Contact parish office for Religious Education classes are information. held from the Sunday following Holy Days Labor Day until the first 12:00 p.m. & 7:00 p.m. Marriage Sunday in May. Classes are Contact parish priest at least Sundays from 10:15 a.m. to Confessions six (6) months prior to 11:30 a.m. Mondays 7:30 p.m. - 8:30 p.m. proposed date of the wedding. Saturdays 4:00 p.m. - 5:00 p.m. Knights of Columbus Rosary Council 16938 First Friday The Rosary is prayed after the Michael Murrow, Grand Knight Adoration following 12:00 p.m. Mass on First Friday [email protected] 12:00 p.m. Mass each month. For more information please Rosary & visit KofCberryville.org. Divine Mercy Chaplet Hospitalized & Homebound Contact the parish office so that Men’s Club Eucharistic Adoration hospitalized and homebound George Darnell Mondays during Confessions parishioners may receive [email protected] from 7:30 p.m. - 8:30 p.m. pastoral care. Meetings are the first Saturday of each month at 10:00 a.m. -
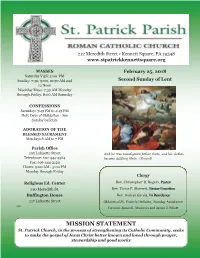
John Patrick Publishing Morganbasementwaterproofing.Com Morganbasements.Com 800-333-3166 236 St
212 Meredith Street • Kennett Square, PA 19348 www.stpatrickkennettsquare.org MASSES February 25, 2018 Saturday Vigil: 5:00 PM Second Sunday of Lent Sunday: 7:30, 9:00, 10:30 AM and 12 Noon Weekday Mass: 7:30 AM Monday through Friday, 8:00 AM Saturday CONFESSIONS Saturday: 3:45 PM to 4:45 PM Holy Days of Obligation - See Sunday bulletin. ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT Mondays 8 AM to 7 PM Parish Office 205 Lafayette Street And he was transfigured before them, and his clothes Telephone: 610-444-4364 became dazzling white. (Gospel) Fax: 610-444-2129 Hours: 9:00 AM - 5:00 PM Monday through Friday Clergy Religious Ed. Center Rev. Christopher B. Rogers, Pastor 210 Meredith St. Rev. Victor F. Sharrett, Pastor Emeritus Buffington House Rev. Andres Garcia, In Residence 227 Lafayette Street Oblates of St. Francis DeSales, Sunday Assistance 236 Deacons James K. Madonna and James J. Elliott MISSION STATEMENT St. Patrick Church, in the process of strengthening its Catholic Community, seeks to make the gospel of Jesus Christ better known and loved through prayer, stewardship and good works ST. PATRICK CHURCH, KENNETT SQUARE, PA PRAYER INTENTIONS All praise and glory is yours, Lord our God, for You have called us to serve You in love. Bless our sick: Ro Teel, Gweneth Malchione, Bill Ewell, Ronald Hall, Frank Reck, Michael Odorisio, Monday, February 26, Lenten Weekday 7:30AM Elaine Baccino Sr., Mario Lorenzut, Ginny Basilio, Pastor Dan r/o Tony & Ginny Basilio Nicewonger, Steve Briley, Ana Teresa Encar- Tuesday, February 27, Lenten Weekday nacion, Robert “Mack” Marc-Aurele, Adriano 7:30AM Larry Giancola D’Angelo, Clara Dunlap, Phil Morehead, Rosemary r/o Joe & Roseann Jester F. -

Church Bulletin 2012
Saint Bernadette of Lourdes Parish “Where Miracles Happen” 1035 Turner Avenue Drexel Hill PA 19026 Rectory: (610)789-7676 Fax: (610)789-9539 School: (610)449-5184 www.stbl.org April 26, 2020 — Third Sunday of Easter ____________________________________________________________________________ Mass Schedule Sunday Masses Holy Day Masses Saturday Vigil: 4:30pm Times Announced in Sunday Bulletin Sunday: 9:00am and 11:00am Weekday Mass Sacrament of Reconciliation Monday—Friday 8:30am Saturday: 3:30pm — 4:15pm __________________________________________________________________________________________________________ Director of Religious Education Marykate Murphy (Ext. 212) Parochial Administrator School Principal Rev. Michael J. Saban (Ext. 104) Mrs. Joanne Montie Resident Parish Business Manager Rev. Hugh J. Dougherty Robert J. Helmig (Ext. 103) Administrative Secretary Permanent Deacons Helen V. Kraus (ext. 101) Deacon Thomas P. Fitzpatrick Parish Music Coordinator Dorothy Toomey 0234 Page Two April 26, 2020 THIRD SUNDAY OF EASTER We are an Easter people so we are a joyful people. Jesus has conquered death, broken open our tombs of sin and despair, and redeemed us in our humanity. Animated by the Holy Spirit, we live in the light and life of Christ, spreading that light and life on to those around us. Let our hearts be glad and tongues exult as we lift our voices in praise to God. Parish Information NEW FAMILIES VISITS TO THE MOST BLESSED SACRAMENT can be made Welcome to St. Bernadette Parish! To register in the parish, please in the Chapel email Deacon Tom Fitzpatrick at [email protected]. He will get back to you to arrange a convenient time to meet with him to regis- RECITATION OF THE ROSARY takes place every Monday ter. -

Holy Redeemer by the Sea Catholic Parish Staffed by the Oblates of St
Holy Redeemer by the Sea Catholic Parish Staffed by the Oblates of St. Francis de Sales We are a diverse Catholic Community that welcomes our visitors, serves all God’s Children, and gathers to worship with our Faith Community. W EEKLY BULLETIN Liturgy Schedule (through Labor Day) July 10, 2016 Holy Redeemer by the Sea - Kitty Hawk 301 W. Kitty Hawk Road Kitty Hawk, NC 27949 Saturday Confession 4:00 pm Mass 5:00 pm Sunday Mass 9:00 am, 11:30 am, 7:00 pm Holy Trinity by the Sea Chapel - Nags Head Milepost 16 at the Intersection of 12 & 158 Saturday Confession 4:30 pm Mass 5:30 pm, 7:30 pm (Bilingual) Sunday Mass 8:00 am, 11:00 am YEAR ROUND Holy Redeemer by the Sea – Kitty Hawk Monday - Friday: Morning Prayer 8:45 am Mass/Communion Service 9:00 am 7:30 pm Bilingual Vigil at HT Holy Days: 9:00 am & 6:00 pm at HR Healing Mass - 1st Wednesday: 9:00 am Adoration - 1st Friday: 9:30 am - 11:00 am CALENDARIO ANUAL Parish Artist Glenn Eure Lunes - Viernes: 8:45 am Oración de la Mañana, Santísimo Redentor 9:00 am Misa/celebración de la Palabra, Santísimo Redentor Días Santos: 7:30 pm Misa de la Vigilia (Bilingüe) en la Santísimo Misa del dia: Trinidad 9:00 am y 6:00 pm en Santísimo Redentor Primer viernes de mes: 9:30 am—11:00 am Adoración, Santísimo Redentor HOLY REDEEMER BY THE SEA HOLY TRINITY BY THE SEA HOLY REDEEMER BY THE SEA CONTACTCONTACT INFORMATION INFORMATION HOLY TRINITY BY THE SEA CATHOLICCATHOLIC CHURCH CHURCH CCATHOLICATHOLIC C CHAPELHAPEL (252)(252) 261-4700 261-4700 office office Emergencies/Emergencias:Emergencies/Emergencias: (252)(252) 261-4700 261-4700 x 215 x 215 Parish Office:Office 9am: 9am - 4pm,- 4pm, Mon Mon - Fri - Friday Email: [email protected] www.obxcatholicparish.org Website: www.obxcatholicparish.org OBX Catholic Parish–Holy Redeemer OBX Catholic Parish–Holy Redeemer @catholicparish@catholicparish TREASURES FROM OUR TRADITION The first “presbyters” were advisers to the bishops rather than what we would call “priests,” yet by the year 1000 our present-day understanding of the ordained priesthood is clearly in place. -

SC Masters Redesign.Qxd
May 11 to May 17, 2011 www.scross.co.za R5,50 (incl VaT RSa) Reg No. 1920/002058/06 No 4725 LocaL eLections: Focus on Vocations: John Paul ii Be wise about How future priests beatification in your vote are trained words and pics Page 9 Page 11 Page 18 Pretoria archbishop plans for the future By MaTHiBeLa SeBoTHoMa ing up in homes that are incom - FTER a period of consultation, prayer plete. and reflection, Archbishop William He expressed ASlattery of Pretoria has set out his concern that in new vision and appointed new personnel many families to key positions in the archdiocese he took the father plays a over earlier this year. non-existent role. “One of the most important responsibil - He said priests ities of a local Church is the passing on of should help in the faith to those around us and especially the preparation to the young,” he said. He encouraged of youth for mar - parish priests to know their catechists. “We riage, in reconcil - must continually upgrade the knowledge, iation in mar - formation and teaching skills for those riage, and in the responsible for teaching and evangelising,” strengthening of said the new archbishop. married life. “We also need to celebrate He acknowledges the “14 excellent success in married life by offering those Catholic schools in the archdiocese”, but good couples who celebrate silver and pointed out that “in reality the majority of golden jubilees an opportunity to stand our Catholic children depend on the local before the community and bear witness to The reflection of St Peter’s basilica is distorted in the window of a Roman bus near the Vati - parish for their knowledge of the faith”. -

Florida Catholic | Dec
FLORIDAWWW.THEFLORIDACATHOLIC.ORG | Dec. 8-21, 2017 | Volume 79, NumberCatholic 3 ORLANDO DIOCESE PALM BEACH DIOCESE VENICE DIOCESE National Power of the Charities conference pen brings Christmas inspires youths comfort, joy appeal Traveling in matching hoodies and neon or- The “angels” who are part of the “Letters From Catholic Charities Diocese of Venice has ange-slice foam hats, 183 teens from the Diocese of Heaven” ministry prepare greeting cards con- launched its annual Christmas Appeal with a goal Orlando joined more than 22,000 young Catholics taining writings from Scripture, little personal to raise $560,000 in December and January in or- from across the nation for the National Catholic handwritten notes, poems, letters with prayers, der to keep services up and going. Youth Conference, held Nov. 16-19 in Indianapolis. religious and cheery images, and holiday wishes. The Christmas Appeal is the largest fundraiser The teens from 18 parishes experienced the The items are later hand-delivered or mailed to for Catholic Charities and is vital for operating the youthful pulse of praise music, powerful witness organizations, charities and ministers, and also to social service organization. Each donation will talks, and opportunities to serve and grow in their individuals who might need a spiritual lift or just help real individuals and families who are assist- faith. “It’s a pilgrimage really,” said Jennifer Chell- a kind gesture to brighten their day. Cards are dis- ed through any one of the 37 different programs berg. “At (the event), Lukas Oil Stadium becomes a tributed weekly and around the various holidays, available in more than 30 locations throughout the holy place.” keeping ministers busy. -

Saint of the Day
Saint of the Day January January 1: Solemnity of Mary, Mother of God This feast of Mary is considered to be one of the oldest and most important feasts of Our Lady. In 431, the Council of Ephesus met to correct false teachings about Christ’s divinity. The Council affirmed that Jesus is true God and true man. Since Mary is the Mother of Jesus, who is the Second Person of the Blessed Trinity, she can truly be called the Mother of God. Devotion to Mary as the Mother of God continued to spread from this time to the present. January 2: St. Basil the Great, Bishop Born to wealthy family in 330, Basil’s family had been Christians for generations. He was well educated, and eventually settled in Caesarea to practice law in 356. There, he met a bishop named Eustanthius and radically changed his life. He wrote, “I beheld the wonderful light of the Gospel truth, and I recognized the nothingness of the wisdom of the princes of this world.” He was baptized and founded a monastic community on his family estate. St. Basil wrote many works about monastic life which has deeply influence the Eastern Church. He attended the Council of Constantinople in 360 and supported the Nicene Creed. He was made a bishop in 370 and focused on serving the poor and reforming criminals. He died in 379. January 3: The Most Holy Name of Jesus Today we remember that, by conferring the name Jesus on His Son, God set that name above all other names. -

Peter of Atroa (773–837) Basil the Great (329–79)
JANUARY 1 Peter of Atroa (773–837) EMinistry under duress Ephesus is a popular archaeological site on the western coast of today’s Turkey. The apostle Paul established a Christian congregation there on his first missionary journey, remaining there three years, ministering to first-generation Christians. About seven hundred years later, Peter of Atroa was born to Christian parents in the neighborhood of Ephesus. Peter had natural spiritual interests, and at eighteen, he became a monk, and a few years later, an ordained priest. As he began a pilgrimage to Jerusalem, a mystical vision turned him and his companion aside with the inspiration to build a monastery. A strong work resulted and Peter became the monastery’s leader at the age of thirty-two. People sought him because of his reputation as a healer and because of his sensitive spirit. The early ninth century was a difficult time for Christians in that part of the world. Persecution increased with each passing year, and Peter worked fervently to protect his monks from harm. He died on the first day of January, 837, in the chapel choir, while his brother monks sang around him. JANUARY 2 Basil the Great (329–79) EClear thinking Popular heresy has always been a threat to basic Christian doctrine. It was rampant in the early centuries, and one attractively 1 Butler’s Lives of Saints expressed teaching was Arianism. The controversy began in Alexandria, in about 320, as a dispute between Arius and his bishop. Arius thought that Christ was neither fully God nor fully human, but something in between. -

Pope's Priestly Vocation Is His Favorite Gift
WWW.THEFLORIDACATHOLIC.ORG | Dec. 6-19, 2019 | Volume 81, Number 3 Pope’s priestly vocation is his favorite gift CAROL GLATZ chemistry in high school, and worked as a bouncer. Catholic News Service The vocation of a priest, on the other hand, would be the exact opposite for Father Bergoglio; it would be draw- VATICAN CITY | In Caravaggio’s painting of Mat- ing people close, not tossing them out, and not worrying thew, the sinful tax collector being called by Jesus to “Fol- about getting dirty in the process. low me,” Pope Francis sees the same unexpected, “Priests who are — allow me to say the word, ‘aseptic,’ grace-filled moment found in his own those ‘from the laboratory,’ all clean and tidy — do not call to the priesthood. help the church,” the pope told Rome’s A 17-year-old Argentine student priests in 2014. headed to a school picnic on Sept. 21, “Today we can think of the church 1953, the feast of St. Matthew, Jorge as a ‘field hospital,’” he said, because Bergoglio felt compelled to first stop “there are so many people who are by his parish of San Jose de Flores. wounded by material problems, by scan- It was there, speaking with a priest dals, also in the church. People wounded he had never seen before and receiv- by the world’s illusions. We priests must ing the sacrament of reconciliation, be there, close to these people,” immedi- he was suddenly struck by “the lov- ately treating those wounds with mercy ing presence of God,” who, like his before delving into the details. -

The Newest Salesian Saint
ST. LEONIE AVIAT: MOTHER FRANCES DESALES AVIAT The Newest Salesian Saint reflections by MOST REVEREND LEWIS FIORELLI, O.S.F.S. Superior General of the Oblates of St. Francis de Sales --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- On November 25, 2001, The Salesian family will have a new saint! In honor of her canonization, I would like to reflect briefly on St. Leonie Aviat, Mother Frances de Sales. I will begin my reflections with a few remarks on the central place of “Nazareth” in the spirituality of our founders, for that appreciation provides a helpful clue into the “sleeves rolled up” holiness of that remarkable contemporary woman and saint. You can learn much about the spirituality of saints from their favorite scriptural passages. Whenever I read something by St. Francis de Sales, for instance, I am careful to observe what Scripture he is quoting, or paraphrasing or alluding to. In this way, I have discovered that a particular favorite of our Patron id Galatians 2:20: “the life I live now is not my own; Christ is living in me.” This passage is central to an appreciation of his Jesus-centered spirituality: “Live Jesus!” In Galatians 2:29 St. Paul affirms that Christians are now dead, having been “crucified with Christ.” Dead, we no longer live; now Christ lives in us and acts through us. And this is how he continues to pour out the effects of his Redemption throughout time and history. Our role in all of this is a simple one: to “get out of way” to make room for the Savior to live and act in us and, thus, to be seen once again walking upon the earth. -

Curriculum Vitae Wendy M. Wright, Ph.D. Degrees Earned Specialized Training Programs Professional Employment
Curriculum Vitae Wendy M. Wright, Ph.D. Department of Theology Creighton University 2500 California Plaza Omaha, NE, 68178 (402) 280-2611 FAX (402) 2502 [email protected] Degrees Earned BA, 1972, California State University at Los Angeles (History with Highest Honors) MA, 1976, University of California at Santa Barbara (Religious Studies) PhD, 1983, University of California at Santa Barbara (Late Medieval/Early Modern Contemplative Studies from Program in Interdisciplinary Studies) Honorary Doctor of Humane Letters from De Sales University, PA: 2000 Specialized Training Programs Certification in Spiritual Direction and the Nineteenth Annotation Retreat, Creighton University Graduate Program in Christian Spirituality: 1992. Professional Employment University of California at Santa Barbara, Department of Religious Studies Teaching Assistant, 1976, 1978-79 Associate Faculty, 1980-81 Lecturer, Spring, 1983. Weston School of Theology, Cambridge, MA Visiting Assistant Professor of Church History, 1985-87. University of Nebraska at Omaha, Visiting Professor of Religion, 1988-89. Creighton University, Department of Theology Visiting Professor of Theology, 1989-90 Assistant Professor of Theology, 1990-1993 Associate Professor of Theology, 1994-1998 Professor of Theology 1998-present Director, Center for the Study of Catholicism at Creighton, 1999-2003 John C. Kenefick Faculty Chair in the Humanities, Creighton, 2002 - 2015. 1 Other Graduate and Professional School Teaching and Thesis Advising: Maryknoll Novitiate, Cambridge, MA; Emanuel College, Boston, MA; United Methodist Academy for Spiritual Formation National Faculty; Creighton University Graduate Program in Christian Spirituality; Seattle University, Institute for Theological Studies (SUMORE), School for Theology and Ministry, Graduate Ministry Program; Shalom Ecumenical Center for Graduate Theological Education Augustana Lutheran College, South Dakota; Reflect Institute (Evangelical Lutheran Church), Kansas City Center; Chestnut Hill Holistic Spirituality Program, Philadelphia, PA; St. -

The Life of Louis Brisson at a Glance
The Life of Louis Brisson at a glance 23 June 1817 Birth in Plancy 29 June 1817 Baptism in Plancy: Louis Alexandre Sosthène 1823-1831 School days in Plancy 22 March 1829 receives First Communion in Plancy June 1829 receives Confirmation in Troyes 1831-1835 attends the Minor Seminary in Troyes 13 July 1835 receives Tonsure 1836-1840 Seminary in Troyes – Study of Philosophy and Theology 6 July 1838 Ordination to Minor Orders in Troyes Ordination to the Sub-diaconate 25 May 1839 (in the Archdiocese of Sens because the bishop of Troyes was sick) 21 December 1839 Ordination to the Diaconate in Troyes Ordination to the Priesthood in the diocese of Châlons 19 December 1840 (because the bishop of Troyes did not feel well) 22 December 1840 First Mass celebrated in Plancy 29 March 1842 First encounter with Marie de Sales Chappuis, a Visitation sister 1 October 1843 Official appointment as Spiritual Director and confessor of the Visitation in Troyes The “three miracles” of money for a poor family's rent, quotation from the Summa 1845 Theologica by an uneducated penitent, and the apparition of Jesus (on 24 February 1845). Louis Brisson is ready to found the Oblates of St. Francis de Sales. Appointment to be the leader of the Catholic Association of St. Francis de Sales in the 1857 Diocese of Troyes for the renewal of the Christian life and for the concern for the poor and the sick. Beginning of the help for working young ladies; by 1863 four hostels for female workers 1858 already existed Leonie Aviat and Lucie Canuet undertake the management of one hostel for working 10 April 1866 young ladies Leonie Aviat (Sr.