Deep Surfing Domenico Quaranta Deep Surfing
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
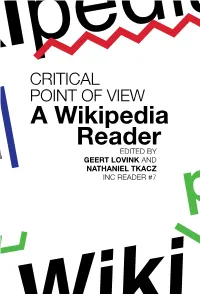
Critical Point of View: a Wikipedia Reader
w ikipedia pedai p edia p Wiki CRITICAL POINT OF VIEW A Wikipedia Reader 2 CRITICAL POINT OF VIEW A Wikipedia Reader CRITICAL POINT OF VIEW 3 Critical Point of View: A Wikipedia Reader Editors: Geert Lovink and Nathaniel Tkacz Editorial Assistance: Ivy Roberts, Morgan Currie Copy-Editing: Cielo Lutino CRITICAL Design: Katja van Stiphout Cover Image: Ayumi Higuchi POINT OF VIEW Printer: Ten Klei Groep, Amsterdam Publisher: Institute of Network Cultures, Amsterdam 2011 A Wikipedia ISBN: 978-90-78146-13-1 Reader EDITED BY Contact GEERT LOVINK AND Institute of Network Cultures NATHANIEL TKACZ phone: +3120 5951866 INC READER #7 fax: +3120 5951840 email: [email protected] web: http://www.networkcultures.org Order a copy of this book by sending an email to: [email protected] A pdf of this publication can be downloaded freely at: http://www.networkcultures.org/publications Join the Critical Point of View mailing list at: http://www.listcultures.org Supported by: The School for Communication and Design at the Amsterdam University of Applied Sciences (Hogeschool van Amsterdam DMCI), the Centre for Internet and Society (CIS) in Bangalore and the Kusuma Trust. Thanks to Johanna Niesyto (University of Siegen), Nishant Shah and Sunil Abraham (CIS Bangalore) Sabine Niederer and Margreet Riphagen (INC Amsterdam) for their valuable input and editorial support. Thanks to Foundation Democracy and Media, Mondriaan Foundation and the Public Library Amsterdam (Openbare Bibliotheek Amsterdam) for supporting the CPOV events in Bangalore, Amsterdam and Leipzig. (http://networkcultures.org/wpmu/cpov/) Special thanks to all the authors for their contributions and to Cielo Lutino, Morgan Currie and Ivy Roberts for their careful copy-editing. -

In Conversation: John Craig Freeman, Scott Kildall & Victoria Scott And
176 / 177 JOHN CRAIG FREEMAN is a public artist with over twenty years of experience using emergent technologies to produce large-scale public work at sites where the forces of globalization are impacting local IN CONVERSATION: JOHN CRAIG FREEMAN, communities. His work seeks to expand the notion of public by exploring how digital networked technology is transforming our sense of place. He has produced work and exhibited around the world including in SCOTT KILDALL & VICTORIA SCOTT AND Venice, Xi’an, Belfast, Los Angeles, Beijing, Zurich, New York City, Taipei, São Paulo, Warsaw, Kaliningrad, MICHAEL TAKEO MAGRUDER WITH Miami, Bilbao, Havana, Atlanta, Calgary, Buffalo, Boston, Mexico City, London and San Francisco. He has HELEN THORINGTON AND JO-ANNE GREEN been commissioned by both Rhizome.org and Turbulence.org. His work has been reviewed in The New York Times, El Pais, Liberation, Wired News, Artforum, Ten-8, Z Magazine, Afterimage, Photo Metro, New (TURBULENCE.ORG) Art Examiner, Time, Harper’s and Der Spiegel. He is currently an Associate Professor of New Media at Emerson College in Boston. See: http://rhizome.org/ See: http://turbulence.org/ SCOTT KILDALL is a cross-disciplinary artist working with video, installation, prints, sculpture and performance. He gathers material from the public realm to perform interventions into various concepts of space. He has a Bachelor of Arts in Political Philosophy from Brown University and a Master of Fine Arts from the School of the Art Institute of Chicago through the Art & Technology Studies Department. He has In a 2006 proposal to the Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, New Ra- exhibited his work internationally in galleries and museums in New York, Los Angeles, Berlin, London and dio and Performing Arts, Inc. -

Spawn of the Surreal Digest Domenico Quaranta
Domenico Quaranta - http://domenicoquaranta.com/ Spawn of the Surreal Digest Domenico Quaranta Articles and interviews published on the blog “Spawn of the Surreal” between July 2007 and September 2009. Available online at the URL http://spawnofthesurreal.blogspot.com/. This work is licensed under the Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. Around 2006, virtual worlds entered the peak of their hype cycle. One of the pupils of the mass media was Second Life, a synthetic environment that gave its users an high level of freedom, both in terms of design and of in-world activity. Unsurprisingly, many of these users were artists and creatives, entering virtual worlds as a new field of experimentation and as a new distribution platform. A small but extremely dynamic art world developed in Second Life, including artists, art critics, galleries and no-profit organizations. That same year, I designed my own avatar (which, for a funny chance, had my very same name) and some months later, I launched “Spawn of the Surreal” (http://spawnofthesurreal.blogspot.com/), a blog that featured the results of my explorations of what I called “the dumpster of the imaginary”. My first post on “Spawn of the Surreal” dates back to July 4, 2007; the last one was written on September 9, 2009, even if it stopped being a regularly updated blog some months before. -

Course Schedule
SPRING 2015 COURSE SCHEDULE UNDERGRADUATE COURSES that we receive about the world is often interpreted as objective—especially when presented through an authoritative frame such as the museum—a change in presentation or environment can dispel the beliefs that we take for granted. This HISTORY AND THEORY OF CONTEMPORARY course will explore the evolution of display as well as the many ART approaches that have challenged established modes of looking and interpretation. HTCA-101-1 MODERNITY AND MODERNISM Satisfies Art History Elective; HTCA-101 for Transfers; Liberal Lauren Macdonald Arts Elective Prerequisite: HTCA-100 This course provides a framework within which to examine and HTCA-220E-1 SOCIETY PHOTOGRAPHIC articulate pivotal topics in world art and architecture and to TBA consider their relevance to contemporary practice. The material Prerequisite: HTCA-102 will be organized in rough chronology spanning the historical Photography, thanks to its enormous impact on modern society, period from 1500 to 1950. The question sustained across the plays an essential role in theorizing social relations. It is central to sessions is what constitutes the many ways of defining “the questions like: Will humans become machines? How do we modern” and the related terms “modernism” and “modernity.” understand suffering? Where is the line between public and This course will pose possible answers through the lenses of private? What is creativity? In this course we’ll study how critics humanist discourse and its problematization in the ages of and artists have employed photography (not just as a practice, imperialism and colonialism; changing patronage for art in an but as an idea) for thinking about the conditions of modernity emerging system of commodity relations; the rise of urban and contemporary life. -

ISEA2015 DISRUPTION Art Catalogue Edited by Kate Armstrong Design: Milène Vallin
ISEA2015 DISRUPTION Art Catalogue Edited by Kate Armstrong Design: Milène Vallin Printed and bound in Canada This book can be downloaded as a .pdf or ordered in print at http://isea2015.org/publication © New Forms Art Press, artists and writers 1255 West Pender Street Vancouver, British Columbia Canada V6E 2V1 Library and Archives Canada Cataloguing in Publication International Symposium on Electronic Art (21st : 2015 : Vancouver, B.C.) ISEA 2015 disruption artistic program / edited by Kate Armstrong. Catalogue published in conjunction with the 21st International Symposium on Electronic Art held in Vancouver, Canada, from August 15 to 19, 2015. Issued in print and electronic formats. ISBN 978-0-9878354-1-3 (paperback) ISBN 978-0-9878354-2-0 (pdf) 1. Computer art--Exhibitions. 2. Art and technology--Exhibitions. I. Armstrong, Kate, 1971-, editor II. Vancouver Art Gallery, host institution III. Title. IV. Title: 2015 disruption artistic program. V. Title: Disruption artistic program. N7433.8.I58 2015 776 C2015-904663-7 C2015-904664-5 Acknowledgments This incredible event could not have happened without our amazing team and our many collaborators. First, a thank you to Thecla Schiphorst and Philippe Pasquier, the Symposium Directors of ISEA2015 who have closely worked with us throughout the long process of developing the artistic pro- gram for ISEA. Thanks to our many programming partners. A big thanks to everyone at the Vancouver Art Gallery, especially Wade Thomas, Diana Freundl, Debra Zhou, Jennifer Wheeler, Jennifer Sorko, and Sunny Kooner, and the spectac- ular Boca Del Lupo team – Jay Dodge, Carey Dodge, and Sherry Yoon – who have been such a pleasure to collaborate with during this project. -

Spring 2015 Undergraduate Courses
SPRING 2015 UNDERGRADUATE COURSES HISTORY AND THEORY OF CONTEMPORARY ART Course Code Title Faculty Day Time Location Prerequisite Satisfies Modernity and Moderism Requirement; LH HTCA-100 HTCA-101-1 Modernity and Modernism Lauren Macdonald T 4:15-7:00 Liberal Arts Elective Transfer students with 3 units of 100-level HTCA; eligibility determined Reframing the History of Art: Art History Elective; HTCA-101 for Transfers; Liberal MCR by Admissions upon HTCA-101A-1 Berit Potter T 4:15–7:00 Arts Elective Object – Space – Spectacle matriculation. Prereq- uisite of HTCA-100 and HTCA-101 for continuing students. HTCA-220E-1 Society Photographic TBA M 1:00-3:45 20B HTCA-102 Art History Elective; Liberal Arts Elective Carlos Villa: Predecessors, Art History Elective; Off-Campus Study Requirement; HTCA-220F-1 Thea Tagle T 4:15–7:00 25 HTCA-102 Studies in Global Cultures Requirement; Contemporaries and Legacies Liberal Arts Elective Like a Corpse on a Bier: Art History Elective; Studies in Global Cultures HTCA-220G-1 Automobiles, Streets, and the Ryan Tacata F 1:00-3:45 18 HTCA-102 Requirement; Critical Studies Elective; Avant Garde Liberal Arts Elective Before the Cure: Critical HTCA-102; Art History Elective; Critical Studies Elective; Studies in HTCA-310-1 Nicole Archer T 1:00–3:45 18 Investigations of Gothic Style 3 units of HUMN Global Cultures Requirement; Liberal Arts Elective HTCA-390-1/ Thesis Colloquium Requirement for BA in History and Thesis Colloquium Lydia Brawner F 1:00-3:45 16C CS-300; CS-390 US-390-1 Theory of Contemporary Art; Liberal -
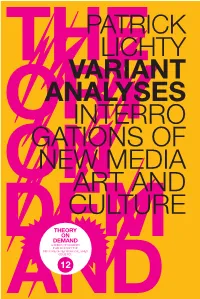
Variant Analyses Interro Gations of New Media Art and Culture
PATRICK LICHTY VARIANT ANALYSES INTERRO GATIONS OF NEW MEDIA ART AND CULTURE A SERIES OF READERS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF NETWORK CULTURES ISSUE NO.: 12 PATRICK LICHTY VARIANT ANALYSES INTER- ROGATIONS OF NEW MEDIA ART AND CULTURE Theory on Demand #12 Variant Analyses: Interrogations of New Media Art and Culture Author: Patrick Lichty Editorial support: Morgan Currie Design: Katja van Stiphout DTP: Margreet Riphagen & Katja van Stiphout Printer: ‘Print on Demand’ Publisher: Institute of Network Cultures, Amsterdam 2013 ISBN: 978-90-818575-4-3 Contact Institute of Network Cultures phone: +3120 5951863 fax: +3120 5951840 email: [email protected] web: http://www.networkcultures.org This publication is available through various print on demand services. For more information, and a freely downloadable pdf: http://networkcultures.org/theoryondemand. This publication is licensed under the Creative Commons Attribution Noncommercial No Derivative Works 3.0 Netherlands License. No article in this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means without permission in writing from the author. VARIANT ANALYSES 3 CONTENTS Acknowledgements 4 Introduction 7 NEW MEDIA: CRITICAL MILIEUX 12 Haymarket RIOT’s Machine: Hacking Visual Sociology By Patrick Lichty and Jonathon S. Epstein Presentation/Intervention/Performance: A Theory of the Eclectic Crash Presentations: A Theory of the Eclectic NEW MEDIA AND ACTIVISM 33 Grasping at Bits: Art and Intellectual Control in the Digital Age An Alpha Revisionist Manifesto The Paralytic -

CAC-Editorial-1.Pdf
1 前言 评委词 姜宇辉 这肯定谈不上是一篇中立、客观的评述。我在这里只想按照自己的线索把手 边的这几篇相当出色的论文串联在一起,就像水流一般,让它们产生一个共 同的趋向与合力。这个趋向便是阿甘本在《论友爱》中给出的对当下时代的诊 断,那就是装置与生命之间的争斗乃至厮杀;这个合力便是我们想在前卫的 思想和艺术实验里面去探寻的一息尚存的希望,那就是反抗的契机乃至颠覆 的可能。由此,Brian House的论文是相当突出的,因为它不仅明确提出了困 境与问题,而更是通过转用Vito Acconci的经典作品来对当下进行一种颇有 启示性的回应。援用他的精彩说法,关键问题恰恰在于,在一个人工智能看似 无限增加和加速的年代,如何在数据网络之中真正成为一个individual而非 1 dividual:二者的区分在于,后者只是捕获机器所操控的傀儡和砝码,而前者 身上则尚有挣脱网络与保持距离的可能。在Acconci的原初描述之中,公共与 私人(private)之间仍然存在着明显的分化;但在当下的时代,当私人领域亦 已然被数据网络全面深入地渗透、监控和左右,那么又何以激活乃至释放其 中尚存的“democratic potential”?House所复刻的Following Piece这件作品 似乎给出了一个令人眼前一亮的思路:既然私人领域早已是一个千疮百孔的 脆弱堡垒,那么在遍在的网络之中重新编织合力,似乎是一个可行的策略。然 而,在这个方向上,我们必然会遇到德勒兹和瓜塔里的Rhizome网络理论和 分子革命(molecular revolution)的构想,也必然会参考内格里和哈特关于诸 众(multitude)之情动(affect)的天马行空的革命纲领。因此我们不出所料地 读到了Jason Rhys Parry关于augmented ecology的论文。然而,所有这些源 自《千高原》(A Thousand Plateaus)的ecology理论在晚近以来皆越来越显 示出强弩之末的疲态。如果说生态系统的本质就是多元、异质、开放的连接, 那么这恰恰是我们时代的“症状”而非“希望”。借用Andrew Culp的说法,“过 度连接(too many connections)”恰恰不是福音而是罪孽。既然如此,明智之 举绝非去augment ecology(or rather‘ecologies’),而反倒是中断连接、缩 减网络、伪造消失(fake‘disappearance’)。 就此而言,余下的几篇文章虽然在批判性方面不甚突出,但却仍然对House所 提出的问题给出了不同方向的回应。Diego Gómez-Venegas和王洪喆的论文 虽然令人遗憾地未涉及到当代艺术的实践,但却补充了一个相当重要的历史 性的视角。只不过,历史本身当然也是多面向的,Gómez-Venegas从技术史和 媒介史所进行的考察、王洪喆从政治运动史所展开的挖掘自然会引申出迥异 的结论:前者以“forgetting”为要点,将Kittler的媒介考古学与控制论的历史演 变关联在一起,展现出重思人-机关系(“human-machine coupling”)的新颖视 角;而后者虽然未重点关注技术本身,但却颇耐人寻味地展现出控制论等“西 方科学思潮”在风云变幻的中国现代政治舞台上的曲折命运。就此看来,其实“- forgetting”倒是可以作为这两篇看似并不相关的文章的关联点。Gómez-Ven- egas的翔实历史考证固然出色,但却始终在一个核心要点之处含混不清、摇摆 2 不定,那正是“forgetting”与“erasing”这两种操作的本质性差异“forgetting” 从根本上来说是主体自身的一种活动,从被动方面看它揭示的是人的认知的 -

Citation As Performative Act Scott Kildall and Nathaniel Stern
Wikipedia Art: Citation as Performative Act Scott Kildall and Nathaniel Stern Introduction The Wikipedia Art entry, first launched on February 14 2009,1 stated: Wikipedia Art is a conceptual art work composed on Wikipedia, and is thus art that anyone can edit. It manifests as a standard page on Wikipedia - entitled Wikipedia Art. Like all Wikipedia entries, anyone can alter this page as long as their alterations meet Wikipedia's standards of quality and verifiability.2 As a consequence of such collaborative and consensus-driven edits to the page, Wikipedia Art, itself, changes over time.3 The work is a poetic gesture towards language and collaboration, a nod to the traditions of concept- and networked-based art, and most of all, a performance on, and intervention into, Wikipedia. According to Wikipedia itself, an ‘art intervention’ is ‘an interaction with a previously existing artwork, audience or venue/space’ and ‘by its very nature carries an implication of subversion.’4 Art interventions attempt to ‘affect perceptions,’ ‘change… existing conditions’ and/or ‘make people aware of a condition that they previously had no knowledge of.’5 Although such works are now ‘accepted as a legitimate form of art,’ they often stir ‘debate’ or cries of ‘vandalism,’ especially when the work itself has not been endorsed by ‘those in positions of authority over the… venue/space to be intervened in.’6 Wikipedia Art is many things: an open-ended concept, an immanent object, a collaborative text, and a net-work that complicates the very possibility for these distinctions. This paper most specifically explicates and unfolds the performance of Wikipedia Art as an intervention into, and critical analysis of, Wikipedia: its pages, its system, its volunteers and paid staff. -

Southeastern College Art Conference Abstracts from the Annual Meeting in Mobile, Alabama October 22-24, 2009
Southeastern College Art Conference Abstracts from the Annual Meeting in Mobile, Alabama October 22-24, 2009 Conference Chair: Jason Guynes Program Co-Chairs: Kara Burns and Elizabeth Richards Abadie-Fail, Trudy. Savannah College of Art and Design. Let’s Have a Live Crit! – An Introduction to the Importance of Current Technology in Distance Courses Design education continues to evolve as our field adapts to changes in the way we communicate. While many view distance education with skepticism, others have embraced this delivery method as a viable and effective form of instruction. Technology has played a key role in the development and delivery of courses that provide opportunities for rich student/faculty interactions. But, this technology is only as effective as the faculty involved in using it. This paper explores innovative teaching methodologies in the distance classroom including effective use of asynchronous and synchronous communication tools that have been used successfully in a graphic design distance program. These will include the use of discussion board postings, wikis and blogs, annotated PDFs, audio files, virtual critiques and guest presentations. Adams, Jamie. Washington University, St. Louis. Figures in Concept Courses The intermediate stage of learning is necessarily an environment of uncertainty and transience. Our curriculum at Washington University in the second year appears to lose its center as it intentionally becomes more expansive and culturally reflexive through a menu of concept studio courses. This period of learning is characterized by students gaining “extra-functional” abilities, where the building of knowledge is dominated by an effort to acquire new ideas. My own preoccupations with issues pertaining to pictorial and figural representations, narrative strategies, and painting and filmic history as well as contemporary notions of identity have led to the development of a number of concept studio courses at this level of intermediate study. -

Critical Point of View: a Wikipedia Reader, 2011
Original citation: Tkacz, Nathaniel and Velasco, Pablo R. (2018) Experience money. In: Lovink, Geert and Gloerich, Inte and De Vries, Patricia, (eds.) MoneyLab Reader 2 : Overcoming the Hype. Amsterdam: Institute of Network Cultures, pp. 31-42. ISBN 9789492302199. Permanent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/101472 Copyright and reuse: The Warwick Research Archive Portal (WRAP) makes this work of researchers of the University of Warwick available open access under the following conditions. This article is made available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) license and may be reused according to the conditions of the license. For more details see: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ A note on versions: The version presented in WRAP is the published version, or, version of record, and may be cited as it appears here. For more information, please contact the WRAP Team at: [email protected] warwick.ac.uk/lib-publications MONEYL A B READER 2 OVERCOMING THE HYPE MoneyLab Reader 2: Overcoming the Hype Editors: Inte Gloerich, Geert Lovink and Patricia de Vries Copy editing: Ed Graham Cover design: Anastasia Kubrak Design: Inte Gloerich EPUB development: Inte Gloerich Printer: Drukkerij Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam Publisher: Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2018 ISBN: 978-94-92302-19-9 Contact Institute of Network Cultures Phone: +31 (0)20 595 1865 email: [email protected] web: www.networkcultures.org Order a copy or download this publication freely at: networkcultures.org/publications. Join: MoneyLab mailinglist: listcultures.org/mailman/listinfo/moneylab_listcultures.org. Subscribe to the INC newsletter: networkcultures.org/newsletter. -

Made in China Catalogue (Pdf)
IN IN IN IN IN CHINA CHINA www.madeinchina-project.org IN CHINA CHINA CHINA IN CHINA CHINA CHINA www.madeinchina-project.orgIN CHINA CHINA CHINA IN CHINA CHINA CHINA IN www.madeinchina-project.org CHINA CHINA CHINA IN CHINA CHINA CHINA www.madeinchina-project.orgIN CHINA CHINA CHINA IN CHINA CHINA CHINA www.madeinchina-project.orgIN CHINA CHINA CHINA IN CHINA CHINA CHINA IN www.madeinchina-project.orgCHINA CHINA CHINA IN CHINA CHINA CHINA www.madeinchina-project.org IN CHINA CHINA CHINA IN CHINA CHINA CHINA IN www.madeinchina-project.orgCHINA CHINA CHINA www.madeinchina-project.orgIN CHINA CHINA CHINA IN CHINA CHINA CHINA MADE MADE IN CHINA CHINA CHINA MADEwww.madeinchina-project.org MADE IN CHINA CHINA CHINA MADE MADE IN CHINA CHINA CHINA MADE MADE www.madeinchina-project.org IN CHINA CHINA CHINA MADE MADE IN CHINA CHINA CHINA www.madeinchina-project.orgMADE MADE IN CHINA CHINA CHINA MADE MADE CHINA CHINA IN CHINA MADE MADE www.madeinchina-project.org CHINA CHINA CHINA MADE MADE CHINA CHINA CHINA MADEwww.madeinchina-project.org MADE CHINA CHINA CHINA MADE MADE MADE MADE www.madeinchina-project.org MADE MADE MADEwww.madeinchina-project.org MADE MADE MADE www.madeinchina-project.orgMADE MADE MADEwww.madeinchina-project.org MADE Table of Contents About the project MADE IN CHINA is both an art proj- artwork in series or multiples, cre- ect and a brand that explores and ated by some of the most prominent implements new ways of producing, Slovenian artists, as well as by guest promoting, and distributing art. It artists from other countries.