Indicatori Di Tenerezza
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
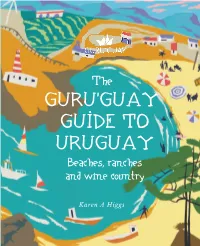
GURU'guay GUIDE to URUGUAY Beaches, Ranches
The Guru’Guay Guide to Beaches, Uruguay: Ranches and Wine Country Uruguay is still an off-the-radar destination in South America. Lucky you Praise for The Guru'Guay Guides The GURU'GUAY GUIDE TO URUGUAY Beaches, ranches Karen A Higgs and wine country Karen A Higgs Copyright © 2017 by Karen A Higgs ISBN-13: 978-1978250321 The All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever Guru'Guay Guide to without the express written permission of the publisher Uruguay except for the use of brief quotations. Guru'Guay Productions Beaches, Ranches Montevideo, Uruguay & Wine Country Cover illustrations: Matias Bervejillo FEEL THE LOVE K aren A Higgs The Guru’Guay website and guides are an independent initiative Thanks for buying this book and sharing the love 20 18 Got a question? Write to [email protected] www.guruguay.com Copyright © 2017 by Karen A Higgs ISBN-13: 978-1978250321 The All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever Guru'Guay Guide to without the express written permission of the publisher Uruguay except for the use of brief quotations. Guru'Guay Productions Beaches, Ranches Montevideo, Uruguay & Wine Country Cover illustrations: Matias Bervejillo FEEL THE LOVE K aren A Higgs The Guru’Guay website and guides are an independent initiative Thanks for buying this book and sharing the love 20 18 Got a question? Write to [email protected] www.guruguay.com To Sally Higgs, who has enjoyed beaches in the Caribbean, Goa, Thailand and on the River Plate I started Guru'Guay because travellers complained it was virtually impossible to find a good guidebook on Uruguay. -

Halep, Stephens Advance As Fans Return to US Open
CCRICKETRICKET | Page 3 FFOOTBALLOOTBALL | Page 4 Australia in a Abraham and ‘better place’ Giroud score aft er talks: as Milan, Roma Langer cruise Tuesday, August 31, 2021 TENNIS Muharram 23, 1443 AH King lauds Osaka GULF TIMES for stand on mental health, racial issues SPORT Page 2 TENNIS SPOTLIGHT 100m Paralympic track thriller Halep, Stephens as Streng unseats Peacock AFP Tokyo, Japan erman sprinter Felix advance as fans Streng stormed his way to Paralympic gold in the T64 100m in Tokyo Gyesterday, dethroning British ri- val Jonnie Peacock who ended up sharing the bronze after a photo fi nish. return to US Open The track thriller saw Streng fi nish in 10.76 seconds, short of the Paralympic record he set just a day earlier in heats, but ahead Rublev reaches second round with straight sets win over Karlovic of Costa Rica’s Sherman Isidro Guity Guity, who took silver. AFP sociation, which oversees the After several tense minutes, New York, United States event, acknowledged the delays the decision came back: a shared but said the last-minute deci- bronze, with both Peacock and sion to impose a vaccine re- Germany’s Johannes Flores com- heering spectators quirement for fans was not to ing in at precisely 10.78 seconds. brought energy to the blame. The pair beamed as they re- fi rst matches of the The tennis major, which took ceived their fl ags to join the other US Open yesterday as place amid empty stands last medallists. Ctwo-time Grand Slam champi- year due to the coronavirus pan- “It felt amazing,” Streng said on Simona Halep, battling back demic, commenced yesterday afterwards of his win. -

Extinction Rebellion Protesters Seek to Shut Down City Airport for Three Days
BUSINESS WITH PERSONALITY ORDER, ORDER HOME TRUTHS THE TOP RACE IS ON TO GADGETS TO SMARTEN UP REPLACE JOHN YOUR LIVING SPACE P21 BERCOW P18 THURSDAY 10 OCTOBER 2019 ISSUE 3,475 CITYAM.COM FREE Inmarsat deal pushes closer NEW TAX RULES to launch pad SEBASTIAN MCCARTHY @SebMcCarthy A BLOCKBUSTER buyout of British satellite giant Inmarsat looks set to go ahead after clearing a major hurdle yesterday evening. TARGETING TECH The $3.4bn (£2.78bn) private equity takeover of Inmarsat is now expected to be approved by the UK government after regulators said they did not hold national security or market competition concerns. Inmarsat and its buyers have proposed a series of remedies, such as a pledge to keep the firm in the UK for several years as well as adequate security controls on sensitive information, in the wake of the probe. The deal came under the glare of both the government and Britain’s competition watchdog this summer after being announced in March. Last night the Competition and Markets Authority said JAMES WARRINGTON written up almost a century ago, and positive, will lead to a more detailed hard to convince countries to scrap their the takeover need not be tasked the global economic behemoth to deliberation by the OECD. unilateral laws, as wider measures could “expected to result in a @j_a_warrington lay out new proposals. The Paris-based organisation hopes its take years to come into force. substantial lessening of MULTINATIONAL tech giants are set for a The rules, if approved, would enable proposals will stop countries from rolling The organisation outlined its scope for competition”. -

Miss De Gustavo Ott 1
Miss de Gustavo Ott 1 PREMIO CELCIT 2002, VENEZUELA MISS de Gustavo Ott ©2000 ADVERTENCIA: Todos los Derechos para su puesta en escena en Teatro, Radio, Cine, Televisión o Lectura Pública, están reservados tanto para compañías Profesionales como Aficionados. Los Derechos y permisos deben obtenerse a través de SGAE. Quedan reservados todos los derechos. Quedan especialmente prohibidos los siguientes actos sobre esta obra y sus contenidos; a) toda reproducción, temporal o permanente, total o parcial, por cualquier medio o cualquier forma; b) la traducción, adaptación, reordenación y cualquier otra modificación no autorizada por el autor a través de su agente c) cualquier forma de distribución de las obras o copias de la misma: d) cualquier forma de comunicación, exhibición o representación de los resultados de los actos a los que se refiere la letra (b); e) Queda expresamente prohibida la utilización de otro nombre que no sea el del autor como responsable de esta obra, en especial, las formas “versión de” o “adaptación de”, ya que el autor es propietario del 100% de los derechos de estas obras. Los cambios de lenguaje, contextualización al habla de las distintas culturas, improvisaciones, cortes, agregados de palabras, modificaciones de escenas o de personajes, etc., forman parte del dinámico trabajo de puesta en escena en el teatro actual por parte de directores y actores, pero no da pie en ningún caso a entender el espectáculo como “versión” ”adaptación” de este original. Las adaptaciones serán permitidas cuando se trate de un género a otro (teatro a cine, por ejemplo) pero siempre bajo la autorización del autor a través de su agente, SGAE. -

Pain, Grief As Kuwaiti Martyrs Laid to Rest
Digital art: Saudis reopen Ronaldo-less Real Imagination border for Qatar complete Super Cup in motion4 hajj pilgrims9 rout47 of Barcelona Min 32º Max 47º FREE www.kuwaittimes.net NO: 17309- Friday, August 18, 2017 Pain, grief as Kuwaiti martyrs laid to rest KUWAIT: Kuwait yesterday, amid sheer sad- Minister of State for Youth Affairs Khaled Al- KUWAIT: Mourners ness, bid final farewell to two prominent citi- Roudhan were among the mourners. attend the funeral zens and clerics, both victims of a terrorist Meanwhile, HH the Amir Sheikh Sabah Al- yesterday of Waleed attack on a restaurant in Ouagadougou in Ahmad Al-Jaber Al-Sabah decided to name Al-Ali and Fahd Burkina Faso on Monday. The bodies of Grand two new mosques after the martyred duo to Al-Husseini, two Mosque Imam Sheikh Dr Waleed Al-Ali and pay tribute to them. Kuwaiti clerics who Sheikh Fahd Al-Husseini were laid to rest, as Speaking to the press, Ghanem hailed Ali were killed along leading state officials including National and Husseini as two leading philanthropists with 16 people in an Assembly Speaker Marzouq Al-Ghanem, with a profound penchant for altruism, attack at a restaurant Minister of Awqaf and Islamic Affairs extending his deepest condolences to their in Burkina Faso. Mohammad Al-Jabri and Minister of families and the Kuwaiti people over this —Photo by Commerce and Industry as well as Acting terrible loss. — KUNA (See Page 6) Yasser Al-Zayyat Local FRIDAY, AUGUST 18, 2017 Local Spotlight Nurses’ remittances By Muna Al-Fuzai through exchange channels under the guise of remittances. -

EC Announces Poll Dates for 5 States
RNI No.2016/1957, REGD NO. SSP/LW/NP-34/2016-18 Follow us on: @TheDailyPioneer facebook.com/dailypioneer instagram.com/dailypioneer/ Established 1864 Late City Vol. 154 Issue 270 Published From *Air Surcharge Extra if Applicable NATION 5 WORLD 7 SPORT 10 DELHI LUCKNOW BHOPAL MAHAGATHBANDHANS TRIED, POMPEO EYES PROGRESS PAK TO FACE BHUBANESWAR RANCHI OVER TRUMP-KIM SUMMIT AUSTRALIA IN 1ST TEST RAIPUR CHANDIGARH TESTED, FAILED IDEAS: JAITLEY DEHRADUN LUCKNOW, SUNDAY OCTOBER 7, 2018; PAGES 12+8 `3 www.dailypioneer.com USUALSUSPECTS EC announces poll dates for 5 States SWAPAN DASGUPTA Chhattisgarh goes to election in two phases on Nov 12, Nov 20; MP, Mizoram on 2019 poll crucial for Cong Nov 28; polling in Rajasthan, Telangana on Dec 7; results to be out on Dec 11 PNS n NEW DELHI before India dumps its ilk adhya Pradesh, MChhattisgarh and t is entirely possible to be sympathetic to the argument Mizoram will go to polls in Iemanating from the Congress camp that the alliance talks November, while Rajasthan with the Bahujan Samaj Party in Madhya Pradesh, and Telangana in December. Chhattisgarh and Rajasthan broke down on account of The Election Commission (EC) Mayawati’s exaggerated demands for seats. From a purely on Saturday announced the psephological angle, the BSP seems to have insisted on polling dates for the five States, seats where its presence was nominal and where it had little the results of which will set the hope of winning. The Congress, or so the argument goes, tone for the 2019 Lok Sabha could therefore hardly be faulted for abandoning all hope for elections. -

Halep, Muguruza Among Early Winners As Fans Return to US Open
Sport TUESDAY 31 AUGUST 2021 Play Ronaldo as a striker, says Rooney When you’ve got someone like Cristiano, you want him fresh around the box. He still wants to be the best and I’m sure he will have a big impact on them this season. Wayne Rooney Sport | 15 CYCLING: VUELTA A ESPAÑA Overall ranking: Top 3 1: Odd Christian Eiking 59H 57' 50'', 2: Guillaume Martin, 3: Primož Roglic Qatar gear up for Serbia clash in Debrecen Qatar players in action during a training session ahead of their FIFA World Cup European Qualifying match against Serbia which will take place in Debrecen, Hungary, tomorrow. The reigning Asian champions Qatar, a guest team in the UEFA qualifiers, are pitted in Group A along with European heavyweights Portugal, Republic of Ireland, Luxembourg, Serbia, and Azerbaijan. Qatar will 'host' Serbia at their 'home ground', 20,000-capacity Nagyerdei Stadion, before welcoming Christiano Ronaldo-led Portugal on September 4. Qatar will play their home fixtures on European soil to facilitate shorter travel times for their group opponents. Halep, Muguruza among early winners as fans return to US Open AP – NEW YORK Simona Halep and Garbiñe Muguruza, a pair of two-time Grand Slam champions who Results have had their difficulties in Andrey New York, pulled out tough At USTA Billie Jean King Rublev two-set victories yesterday in National Tennis Center the opening round of the US New York Open. Surface: Hardcourt outdoor Flawless Sloane Stephens then had (seedings in parentheses): one even tougher, needing 2 Rublev hours, 10 minutes to edge Madison Keys 6-3, 1-6, 7-6 (7) MEN’S SINGLES downs in a rematch of her victory in FIRST ROUND the 2017 final. -

Cathrin Skog En Av Favoriterna I Miss World 2006
2006-09-18 11:21 CEST Cathrin Skog en av favoriterna i Miss World 2006 Cathrin Skog, 19 årig call-center agent från den lilla byn Nälden i närheten av Östersund är Sveriges hopp i årets Miss World 2006. Cathrins ambition i framtiden är att studera internationell ekonomi och hon älskar att måla och lyssna på musik, speciellt street, disco och funk. Hennes personliga motto i livet är att alltid se livet från den ljusa sidan och att aldrig ge upp. Finalen i Miss World 2006 kommer att hållas på lördagen den 30 september i Polen där den 56: e Miss World vinnaren kommer att koras av både en expertjury på plats och via internetröster från hela världen. Cathrin är en av förhandsfavoriterna och spelas just nu till 17 gånger pengarna. Miss Australien (Sabrina Houssami) och Miss Venezuela (Alexandra Federica Guzaman Diamante) delar på favoritskapet med spel till 8 gånger pengarna. För mer info om tävlingen, se www.missworld.com Odds Vinnarspel Miss World 2006 Miss Australia 8.00 Miss Venezuela 8.00 Miss Canada 11.00 Miss India 11.00 Miss Lebanon 13.00 Miss Angola 17.00 Miss Columbia 17.00 Miss Dominican Republic 17.00 Miss South Africa 17.00 Miss Sweden 17.00 Miss Mexico 19.00 Miss Philippines 19.00 Miss Puerto Rica 19.00 Miss Czech Republic 21.00 Miss Jamaica 21.00 Miss Martinique 21.00 Miss Spain 21.00 Miss Iceland 23.00 Miss Italy 26.00 Miss Panama 26.00 Miss Singapore 29.00 Miss Ukraine 29.00 Miss Brazil 34.00 Miss Chile 34.00 Miss China 34.00 Miss Greece 34.00 Miss Nigeria 34.00 Miss Peru 34.00 Miss Poland 34.00 Miss Turkey 34.00 Miss USA 34.00 -

Dueños De Personas .. Personas Con Dueños
1 2 3 Asociación Civil El Paso. Dueños de personas, personas con dueños. Investigación sobre trata de personas en Uruguay. Montevideo: Asociación Civil El Paso, 2020. 292 p. ISBN 978-9915-9301-0-7 1. Trata de personas. 2. Explotación sexual co- mercial de niñas, niños y adolescentes. Prego Tramuja, Cristina (coord.) JKVM 364.1 Esta publicación fue realizada con el apoyo de la Unión Europea en el marco del Instru- mento Europeo para la Democracia y los De- rechos Humanos. El objetivo específico del proyecto Uruguay mira la trata es contribuir a los esfuerzos de Uruguay en promover la implementación de políticas públicas sobre trata de personas en el país con enfoque de derechos humanos. El contenido de esta pu- blicación es responsabilidad exclusiva de la Asociación Civil El Paso y de ninguna manera es reflejo del puntos de vista de la Unión Eu- ropea. La ejecución del proyecto está a a car- go de la Asociación Civil El Paso asociada a la agencia Voz y Vos – Asociación Civil El Abrojo. Coordinación general de proyecto Cristina Prego Tramuja Coordinación de la investigación Natalia Guidobono Genisans 4 Equipo de investigación Relevamiento de información en prensa Marisa Acosta Niell Voz y Vos, El Abrojo: Paula Baleato Devita Camila Figueira, integrante del Equipo Técnico Valeria España Gómez Paula Baleato, Coordinación ejecutiva Heloisa Greco Alves Natalia Guidobono Genisans El Paso: Sandra Perroni Beneventano Agustina Larrosa Falero Cristina Prego Tramuja Luis Purtscher Bachini Corrección de estilo Andrea Tuana Nägeli María Cristina Dutto Colaboradora en campo Diseño Karina Núñez Rodríguez Guillermo Alberti Asesoramiento metodológico Fotografía Docentes integrantes del Área de Género del Susette Kok Departamento de Trabajo Soscial, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República: Laura Cafaro Carla Calce La presente investigación está protegida por Mariana González Guyer los derechos de propiedad intelectual. -

Page 01 Aug 18.Indd
3rd Best News Website in the Middle East BUSINESS | 11 SPORT | 19 Apple CEO says Nadal pushes perfect he disagrees streak to 15 against with Trump Gasquet in Cincinnati Friday 18 August 2017 | 26 Dhul-Qa’Da 1438 www.thepeninsulaqatar.com Volume 22 | Number 7257 | 2 Riyals Pilgrimage still Emir sends message to politicised: British PM QNA Foreign Minister mir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani has Esent a written message Agencies “Regardless of the manner to British Prime Minister in which Qataris were banned Theresa May, pertaining to oreign Minister H E from the pilgrimage, which bilateral relations and means Sheikh Mohamed bin was politicised, and the man- to promote these relations in Abdulrahman Al ner in which they were again addition to the latest regional Thani yesterday met permitted to make the pilgrim- and international develop- the Foreign Minister age, which was also politicised ments, particularly the Gulf Fof Sweden, Margot ... the government of Qatar crisis. Wallstrom. welcomes the decision and will Foreign Minister H E Both sides reviewed rela- respond positively,” Sheikh Sheikh Mohamed bin Abdul- tions between Qatar and Mohammed said at a press rahman Al Thani handed the Sweden, ways of boosting and conference yesterday with his message during a meeting developing them, as well as Swedish counterpart in with May at 10 Downing developments in the region. Stockholm. Street yesterday. The Qatari Foreign Minis- The Minister stressed ter briefed his Swedish Qatar’s commitment to resolv- Foreign Minister H E Sheikh Mohamed bin Abdulrahman Al Thani with his Swedish counterpart counterpart on all illegal meas- ing the Gulf crisis Margot Wallstrom, yesterday. -

Cabinet Confident Life ‘Back to Normal’ Soon
MUHARRAM 23, 1443 AH TUESDAY, AUGUST 31, 2021 16 Pages Max 44º Min 30º 150 Fils Established 1961 ISSUE NO: 18520 The First Daily in the Arabian Gulf www.kuwaittimes.net Kuwait mulls work from CBK launches e-payment service 7-time Emmy winner From disaster to Paralympics 4 home for some categories 8 amid digital expansion plan 12 Ed Asner dies at 91 15 gold: China’s ‘Flying Fish’ Cabinet confident life ‘back to normal’ soon Iraq says Katyusha missiles fired by outlawed groups By B Izzak vaccinations. For most of the past 10 days, the number of new cases Kuwait’s Mutairi wins KUWAIT: The government said yes- remained below 200 as the number of terday it was confident that life in the deaths dropped sharply and coron- silver at Tokyo Paralympics country will return to normal “soon” avirus patients at hospitals have after indicators on the coronavirus declined to just 200. Those receiving pandemic have recorded positive treatment at intensive care units also Volvo Kuwait to present Mutairi a car results leading to achieving herd fell to just 89 yesterday. TOKYO: Kuwait’s Ahmad Al-Mutairi won a the event at the 2016 Rio Games and the immunity. Health Minister Sheikh Basel During the meeting, Defense silver medal in the men’s T33 100-meter race 2019 world champion, finished in his season’s Al-Sabah briefed the Cabinet’s weekly Minister Sheikh Hamad Jaber Al-Ali at the Tokyo Paralympics yesterday. best time of 17.83 seconds, missing gold by meeting that the country has wit- Al-Sabah briefed the Cabinet on the Volvo Kuwait announced yesterday that it just 0.1 seconds at Tokyo’s National Stadium. -

A Brief Obsessive Guide to the Amazing Race
The World is Waiting for You: A Brief Obsessive Guide to The Amazing Race 1st Edition By David A. Bindley CONTENTS AUSTRALIA Season Seven 84 Season One 3 Season Eight: Family Edition 86 Season Two 7 Season Nine 90 Season Three: Australia vs. New Zealand 10 Season Ten 93 BRAZIL Season Eleven: All-Stars 96 Season One 14 Season Twelve 98 CANADA Season Thirteen 100 Season One 17 Season Fourteen 103 Season Two 19 Season Fifteen 106 CHINA Season Sixteen 109 Season One 23 Season Seventeen 112 Season Two 25 Season Eighteen: Unfinished Business 115 Season Three 28 Season Nineteen 118 Season Four N/A Season Twenty 122 FRANCE Season Twenty-One 125 Season One 32 Season Twenty-Two 128 ISRAEL Season Twenty-Three 132 Season One 35 Season Twenty-Four: All-Stars II 135 Season Two 38 Season Twenty-Five N/A Season Three 43 VIETNAM Season Four N/A Season One 139 NORWAY Season Two 142 Season One 50 Season Three 145 Season Two 54 REGION: ASIA PHILIPPINES Season One 149 Season One 58 Season Two 152 Season Two N/A Season Three 155 UKRAINE Season Four 158 Season One 62 REGION: LATIN AMERICA UNITED STATES OF AMERICA Season One 163 Season One 66 Season Two 165 Season Two 68 Season Three 168 Season Three 71 Season Four: Brazilian Edition 171 Season Four 75 Season Five 173 Season Five 78 Season Six: Ecuador Edition N/A Season Six 81 NOTES: Italicised titles are taken from official sources, mostly onscreen graphics. Where versions aired in languages other than English, official titles are used only for Detours.